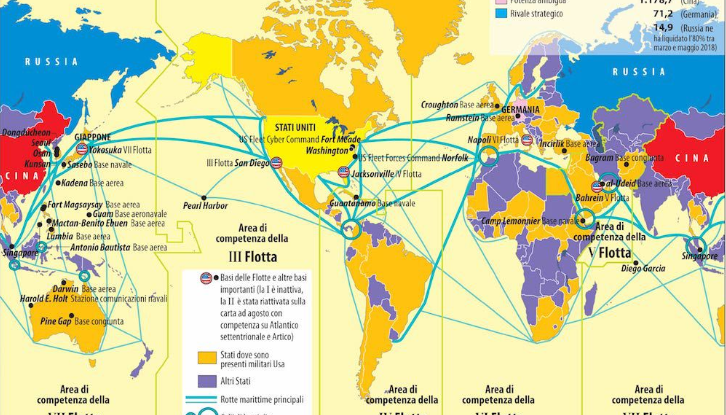
RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI
26 MARZO 2020
A cura di Manlio Lo Presti
Esergo
Ma non ti ho spinto io verso la politica.
– Che altro c’è da fare?
– L’assassinio, il furto, la violenza e tante altre degne attività
(Sidney Chaplin e Marlon Brando nel film LA CONTESSA DI HONG KONG)
In: Suonala ancora Sam, Bompiani, 1999, pag. 264
https://www.facebook.com/Detti-e-Scritti-958631984255522/
Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.
Tutti i numeri dell’anno 2018 e 2019 della Rassegna sono disponibili sul sito
Precisazioni
www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com
Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.
Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com
La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SOMMARIO
La guerra dei numeri nella dittatura strisciante del reality Italia
RISALITE A BORDO CAXXO !!
USA nostri “amici”
Le città verranno distrutte all’alba
Tosca di Puccini
Esoterismo, geopolitica, tradizione: all’arte di Alexey Guintovt non manca nulla.
È lui. È tornato. È bazaar!
Americanizzare l’Italia
DER ELEFANT IM RAUM (L’elefante nella stanza).
Le multinazionali divorano l’Italia e la politica si gingilla su temi secondari
Uno si divide in due
Non ci sono intellettuali
Bruno Vespa contro le Ong?
Il provvedimento sulle intercettazioni è legge
La fantaeconomia anticipa la realtà?
I trogloditi del pareggio di bilancio, cavalieri della catastrofe
Christine La “gaffe” (!?!)
30 milioni morti per malaria
IN CINA VIRUS TI BATTO. FORSE …
DRAGHI ORDINA. MA LO STATO CHE ESEGUE, non c’è più
CONTE E LA VIA ITALIANA ALL’EPIDEMIA
Quale Karl Polanyi?
QUANDO IL PADRE ERA SACRO
IN EVIDENZA
La guerra dei numeri nella dittatura strisciante del reality Italia
Come confrontare i dati rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. In questa poca chiarezza la misura della mancata gestione del problema
24 Marzo 2020 | di Alessandro Cicero
La drammatizzazione di un fatto, un evento, un racconto ha la funzione di renderlo “forte” e quindi emotivamente e operativamente fruibile anche a chi, provvisto o sprovvisto di categorie di interpretazione, lo trovi utile strumento per inserire sé stesso nel flusso degli avvenimenti, traendone norme di comportamento e ancoraggi ad una o più appartenenze nelle quali riconoscersi. Nascono così “parole d’ordine”, comodi mantra ripetuti talmente di frequente che citando o parafrasando Goebbels, che di queste cose se ne intendeva, si rimane coerenti con le proprie affermazioni “anche a rischio di prendere in giro sé stessi”.
Così vediamo noi italiani totalmente affogati dalle sabbie mobili di affermazioni che voler definire di dubbio gusto è solo frutto e sintomo di una buona educazione ricevuta. Di dubbio gusto è senz’altro l’affermazione, così disinvoltamente ripetuta da più parti, secondo cui “siamo in guerra”, passi se esca dalla bocca di medici o infermieri, o commessi del supermercato, farmacisti, autotrasportatori della filiera agroalimentare (ma solo di quella?) costretti a percorrere strade e raggiungere luoghi inseriti nelle zone rosse, o anche da parte di tassisti, piloti, hostess, forze dell’ordine, e di tutti quei soggetti che effettivamente stanno garantendo, sotto grave stress, un buon funzionamento (almeno per ora) del nostro sistema. Passi per lo stress. E poi basta. Nessuno sta bombardando le nostre case, violando le riserve idriche, sabotando la produzione di energia elettrica e altri piccoli dettagli che accadono costantemente in tutte le guerre, inclusi stupri, saccheggi ed esecuzioni sommarie per strada.
Il presidente del Consiglio Conte
Affermare fino allo sfinimento che “siamo in guerra” svolge ben altre funzioni, di tipo politico, che vanno oltre ciò che si è scritto sopra, anche se sul consenso generato nei più esse si innestano e sviluppano. I poteri speciali hanno bisogno di questo. Non hanno bisogno della guerra, si accontentano di una narrativa coerente. Per sgombrare il campo da eventuali equivoci i poteri speciali sono necessari in caso di grave calamità naturale o umana, in capo alla Protezione Civile o ad un organo Commissariale esperto e deputato alla risoluzione di questi problemi, ma è ciò che stiamo vivendo? Stiamo vivendo la drammatizzazione quotidiana di un evento vero, una drammatizzazione che copre come una cortina fumogena o un rumore bianco almeno tre fatti che sono davanti agli occhi di noi tutti, se si ha la pazienza di guardare oltre le volute del fumo:
non abbiamo una catena di comando chiara;
non vengono posti in essere provvedimenti che hanno palesemente funzionato in situazioni in buona parte simili alla nostra (vedi il caso Corea del Sud);
non sono chiari i numeri sopra i quali dovrebbero essere prese le decisioni (“prima conoscere, poi discutere, poi deliberare” diceva Luigi Einaudi e non a caso, nelle “prediche inutili”);
di conseguenza, si è creato un blocco d’opinione attorno all’operato del Governo e del presidente del Consiglio, che impedisce non già la critica (almeno per ora e salvo il caso di alcuni medici che hanno perso anche il diritto di lamentarsi e di informare il pubblico), ma l’emersione della stessa, soffocata dal consenso liberticida degli spettatori del reality.
Il prof. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità
Soprattutto quest’ultimo fatto ci porterà alla rovina, ma ci andremo a poco a poco, cantando dai balconi ad orari prestabiliti, come delle moderne, e autoconvocate, adunanze di consenso. L’unica guerra che si può combattere per cercare di vincere, di riavere indietro la nostra vita e la nostra modesta, ma dignitosa, prosperità, è quella dei numeri. Si perché i numeri hanno il difetto di non mentire, anche se in verità si può mentire concatenando varie interpretazioni degli stessi, in modo da confondere le acque e arrivare a delle comode menzogne basate su alcune verità. Ciò che si deve pretendere, quindi, non è solo la verità dei numeri, ma anche la chiarezza del metodo con il quale li si tratta. Non vi annoierò con troppe cifre, annoiano anche me, ma devo per forza richiamarne alla memoria qualcuno e, soprattutto devo richiamare qualche concetto col quale noi tutti consapevolmente o no, abbiamo trattato le cifre come fenomeno di massa.
Partiamo da un documento ufficiale: “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia” dell’Istituto Superiore di Sanità del 20 marzo scorso, l’ultimo di questo tipo pubblicato. Non ci interessano i valori assoluti, sono ormai superati dagli eventi. Ci interessano i valori relativi riportati nel “paragrafo 3. Patologie pre-esistenti”, nel quale si riportano le percentuali di incidenza della presenza di patologie aggiuntive al Covid-19 in un campione di 481 deceduti su una popolazione statistica di 3.200. La cosa interessante è che la percentuale di soggetti deceduti che non avevano patologie pregresse è dell’1,2%. Questo numero richiama alla memoria le polemiche iniziali, durante le quali c’era chi chiedeva di distinguere fra morti “di Coronavirus” e morti “col Coronavirus”. A questa legittima richiesta si è sempre preferito rispondere in modo retorico e stizzito: “i morti sono i morti!”.
L’utilizzo della retorica violenta per evitare di dover dare delle risposte, spesso nasconde altre pretese e altri disegni, ma contiamo sul fatto che se la distinzione fra deceduti “con” o “di” Coronavirus la fanno l’Istituto Superiore di Sanità e la virologa Ilaria Capua, evidentemente una valenza scientifica ci deve pur essere. Lunedì scorso, 23 marzo ore 18:00 circa, ci dicono che il numero dei decessi in Italia è arrivato a 6.078 con un incremento, ci dicono, dei nuovi casi a 63.928 in totale, più 4.790 rispetto al giorno precedente, pari ad un incremento del 7,49% circa, in deciso miglioramento rispetto a dieci giorni fa (era attorno al 22% di media quotidiana) e con un trend che, in assenza di nuovi focolai infettivi, farebbe ben sperare. I nuovi decessi sono stati 602, con un incremento del 10,99% circa, anche questo in leggero calo, ma non così marcato, rispetto a dieci giorni fa.
anche questo in leggero calo, ma non così marcato, rispetto a dieci giorni fa.

Sono dati che potrebbero aprire, in un’altra decina di giorni, a nuovi scenari narrativi, ma ciò che si vuole porre in evidenza è che ciò sarebbe potuto avvenire fin dall’inizio. Purtroppo occorre fare un’osservazione, il dato che ci interessa di più non è quello dei contagiati, ma proprio quello dei decessi, proprio perché è l’unico dato certo. Il dato dei contagi, come faceva notare, sui social, un noto medico romano in quarantena per contagio, è del tutto approssimativo (non ci spingiamo oltre), in quanto la verifica col tampone si applica solo ai contagiati sintomatici, e nemmeno a tutti, visto che proprio il medico citato non è mai stato verificato in tal modo. Sono certi i morti e questo rimane l’unico dato confrontabile, ipotizzando che non vi siano reticenze o censure statistiche da parte di alcune nazioni poco o nulla democratiche (anche se acclamate come eroiche), si hanno solo notizie confuse, approssimative o poco chiare.
Dichiarare in modo limpido i criteri con cui si effettuano le statistiche è un obbligo per chi voglia renderle note ed è anche l’unico metodo attraverso il quale possano essere effettuate delle comparazioni, si trattano i dati in modo omogeneo sulla base dei reciproci criteri adottati. L’unica nazione, che sembra, abbia dichiarato in modo estremamente esplicito e chiaro il proprio criterio di rilevazione è la Corea del Sud, rilevazione a tappeto, cioè sul totale della popolazione, ovviamente in modo progressivo, con campagne di prelievo e analisi dei tamponi quotidiane. In questo modo si conosce il fenomeno e si può discutere e, infine, deliberare. La Corea del Sud, nel momento in cui scrivo, ha pubblicato i seguenti dati: 8.961 casi totali, di cui 64 nuovi, 111 morti totali, più 7 rispetto al giorno precedente. Balza subito all’occhio che la percentuale dei decessi sul totale dei contagiati è appena del 1,24%, e non del 9,51% come nel caso italiano. Ma quanto è realistico il dato italiano? Se applicassimo il dato coreano, facendo un calcolo al rovescio, sulla popolazione dei nostri deceduti, per ottenere il numero degli infettati, otterremmo questo 490.161. Questo sarebbe ad oggi, a parità di condizioni con la Corea del Sud, il numero “effettivo” dei contagiati, noti e non noti. Un numero pazzesco, un ordine di grandezza sopra il numero ufficiale. D’altro canto, se applicassimo alla lettera il numero fornito dall’Istituto Superiore di Sanità, ovvero la percentuale dei morti “di” Coronavirus sul totale dei decessi, (1,2% ricordiamolo), otterremmo 73 soggetti, equivalenti, se posti a rapporto con i casi totali d’infetti, ad una percentuale di appena 0,11%. Un dato che avrebbe, con tutta evidenza, disegnato scenari di comunicazione del tutto diversi.
 Sono realistici questi dati? Non lo sappiamo, ma possono a tutta ragione essere presi come estremi di una situazione totalmente variabile e incerta. E in questa incertezza sta la misura della mancata gestione del problema, il che ci porta al quarto dei punti elencati sopra, la comunicazione. Il premier Conte sembra essersi impegnato solo in questa e i segnali che continuamente offre sono tutti nella stessa direzione: gestione poca e lenta, comunicazione in eccesso, rituale, ad orari comandati, e con punte di rara dolosità, come la diretta Facebook della notte fra sabato e domenica. Se non si vuol investire sulla rilevazione a tappeto, cosa assolutamente preferibile in quanto significherebbe la presa in carico della salute di tutti, si proceda almeno ad una rilevazione a campione. Una rilevazione random, magari stratificata per territorio e classi di età. Un campione significativo, ma non titanico, di 1.200 – 1.500 persone. Un approccio del genere costerebbe poco e darebbe al decisore politico almeno dei dati su cui fondare una strategia di intervento tale da consentire di smettere di brancolare nel buio e di stratificare continuamente nuove decisioni senza nemmeno attendere gli esiti di quelle precedenti, in una cascata di continua emotività senza senso, se non quello di tenere sempre tesi gli ascoltatori/elettori.
Sono realistici questi dati? Non lo sappiamo, ma possono a tutta ragione essere presi come estremi di una situazione totalmente variabile e incerta. E in questa incertezza sta la misura della mancata gestione del problema, il che ci porta al quarto dei punti elencati sopra, la comunicazione. Il premier Conte sembra essersi impegnato solo in questa e i segnali che continuamente offre sono tutti nella stessa direzione: gestione poca e lenta, comunicazione in eccesso, rituale, ad orari comandati, e con punte di rara dolosità, come la diretta Facebook della notte fra sabato e domenica. Se non si vuol investire sulla rilevazione a tappeto, cosa assolutamente preferibile in quanto significherebbe la presa in carico della salute di tutti, si proceda almeno ad una rilevazione a campione. Una rilevazione random, magari stratificata per territorio e classi di età. Un campione significativo, ma non titanico, di 1.200 – 1.500 persone. Un approccio del genere costerebbe poco e darebbe al decisore politico almeno dei dati su cui fondare una strategia di intervento tale da consentire di smettere di brancolare nel buio e di stratificare continuamente nuove decisioni senza nemmeno attendere gli esiti di quelle precedenti, in una cascata di continua emotività senza senso, se non quello di tenere sempre tesi gli ascoltatori/elettori.
Avremmo voluto vedere fin dall’inizio il premier Conte che non minimizzasse, come ha fatto all’inizio del fenomeno, perdendo del tempo preziosissimo. Il premier Conte che non mettesse sotto accusa, con il risultato di una messa alla berlina internazionale, i medici di due ospedali che, come italiani, non possiamo invece che ringraziare, assieme al personale paramedico tutto. Il premier Conte che prima di varare misure draconiane sulla libertà personale (necessarie anche quelle in tempi di pandemia) investa nell’unico fatto che gli consenta di gestire il problema, la mappatura a tappeto del fenomeno. Un premier che si procura, con la determinazione di chi è in guerra (la si dichiara tanto e poi non ci si muove?) tamponi, reagenti per le analisi, personale per effettuarle, mascherine per gli operatori sanitari e mascherine per tutta la popolazione, invece di fermare l’Italia, provocando un danno incalcolabilmente superiore, e renderla certamente più povera e debole di prima, più soggetta ad attacchi esteri, anche di quelli penosi, basati su una finta solidarietà, funzionale a combattere in territorio italiano battaglie commerciali contro i nostri storici alleati. Vorremmo un Governo che si presentasse davanti al Parlamento, sede naturale di questo tipo di discussioni. Un Governo competente e democratico, insomma. È pretendere troppo?
Alessandro Cicero
FONTE:https://www.eurocomunicazione.com/coronavirus-la-guerra-dei-numeri-nella-dittatura-strisciante-del-reality-italia/
RISALITE A BORDO CAXXO !!
Rosanna Spadini 21 03 2020
- – Dove stanno i medici “senza frontiere” che fino a un mese fa s’imbarcavano sulle navi ONG per 10.000 euro al mese?
- – Dove stanno i “medici” di EMERGENCY?
- – Dove sta il “grande” Gino Strada?
- – Perché questi meravigliosi salvatori della patria a Bergamo non si sono visti, mentre sono arrivati medici da Cuba e dalla Cina?
- – Le ONG da 20 anni ci chiedono soldi, vantandosi di salvare vite in zone di guerra.
- – Dove stanno questi meravigliosi eroi della medicina, degli ospedali da campo del terzo mondo?
Risalite a bordo caxxo !! (un medico di Torino)
https://www.facebook.com/100000545483769/posts/3319462881415195/
USA nostri “amici”
Francesco Erspamer 1 03 2020
Leggete la pagina ufficiale del dipartimento di stato americano sull’Italia (copio il link nei commenti). Ricordando che gli Stati Uniti fanno finta di essere un paese amico e un nostro grande alleato.
Il primo paragrafo invita i cittadini americani a non andare in Italia se non in caso di necessità; è il livello tre, come per la Cina, la Corea del Sud e (ovvio) l’Iran. Non gli è parso vero, all’amministrazione Trump, di fare a prezzo zero un favore a Salvini, Renzi e Berlusconi, e uno sgambetto a un governo meno servile dei precedenti. Infatti CNN, nel riportare la notizia, ha dato evidenza solo alla reazione del presidente di Federalberghi, tale Barnabò Bocca, e alla sua accusa al governo italiano di non aver fatto abbastanza per contenere il coronavirus, trattandolo come se fosse un esperto, uno scienziato, insomma obiettivo; e trascurando invece il piccolo dettaglio che è stato un senatore di Forza Italia, oltre al fatto che la sua fulminante carriera è avvenuta nella catena alberghiera del padre.
Ma ancora più interessante è il secondo paragrafo del comunicato del governo americano. Eccone la traduzione integrale: “Il rischio di terrorismo resta identico. L’Italia presenta un radicato rischio causato da gruppi terroristi che continuano a pianificare attacchi in Italia. I terroristi possono attaccare all’improvviso, prendendo di mira località turistiche, nodi ferroviari, mercati e centri commerciali, uffici governativi, alberghi, ristoranti, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e altri luoghi pubblici”. È ciò che sino a ieri meritava all’Italia il livello 2, come la Francia, l’Inghilterra e la Germania; con la curiosa differenza che in questi paesi di sanguinosi attentati terroristici ce ne sono stati mentre in Italia no. Come a dire, quando ci sono pretesti per attaccare l’Italia, si amplificano, e quando non ci sono, si inventano. Ma i finti nazionalisti italiani sono tutti filoamericani.
Potrebbe invece essere l’occasione per invitare i ventimila soldati americani stazionati in Italia ad andarsene, per evitare il coronavirus, oltre che le persistenti minacce terroristiche. Che se ne tornassero negli Stati Uniti, il paese degli omicidi quotidiani (a parità di popolazione, sei volte più numerosi che in Italia) e delle stragi settimanali (l’ultima un paio di giorni fa in Minnesota, cinque persone ammazzate da un impiegato incazzato; dall’inizio dell’anno è la quarta) che però non fanno notizia.
https://www.facebook.com/100003196950060/posts/2706833596099846/
Le città verranno distrutte all’alba
Pubblicato il 22 Marzo 2020 · in Interventi ·
di Sandro Moiso
Il silenzio del Governo, dopo la rapida comunicazione di sabato sera del presidente del consiglio, era più che sospetto. L’elenco infinito e incerto di attività di vario genere (passate nel frattempo da 88 a 100 e poi ancora a 80) che avrebbero dovuto mantenere le proprie funzioni produttive e distributive senza chiudere, altrettanto. Ma la notizia che il decreto sarà attivo soltanto a partire da mercoledì 25 marzo, quindi senza entrare in vigore del tutto da lunedì 23, perché Confindustria continua a sostenere che non si possono chiudere tutte le attività e che occorre ancora limarlo meglio, lascia comunque senza fiato. Anche chi come me è abituato, da decenni, a cogliere nella sete e nell’avidità di profitto e sfruttamento del capitalismo il limite ultimo per la sopravvivenza della specie. Eppure, eppure…
Non c’è limite al peggio poiché, come si afferma in un articolo uscito poche ore fa su Repubblica nella sezione Economia e finanza (qui), non solo il decreto è stato rinviato nella sua attuazione di almeno tre giorni, ma gli imprenditori chiedono comunque che le attività restino ancora aperte poiché: “Molti container arriveranno domani nelle fabbriche italiane per scaricare merci e i fornitori esteri già minacciano penali, se il blocco entrasse in vigore subito” e “le imprese sono a corto di liquidità, chiudere senza criteri ben calibrati può voler dire non riaprire più”.
Non solo, gli aderenti alla Confapi (associazione delle piccole e medie industrie), per bocca del presidente Maurizio Casasco, chiedono di detassare le piccole aziende in difficoltà, ma anche che siano le aziende stesse a poter certificare, con procedure semplificate, la necessità dell’apertura degli stabilimenti e una “disposizione di carattere generale che consenta la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano però funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali” (qui).
Nella stessa lettera indirizzata al governo si chiede infine di garantire i “tempi tecnici necessari dall’entrata in vigore del provvedimento a concludere le lavorazioni in corso, ricevere materiali e ordinativi già in viaggio, consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti”.
Diciamolo subito il grido di dolore degli imprenditori non è nient’altro che un crimine contro l’umanità e come tale va denunciato. Sul Titanic che affonda i sabotatori di Confindustria aprono ulteriori falle nelle scialuppe di salvataggio per garantire che l’ordine produttivo trionfi. Con il rinvio del Dpcm spostandolo al 25 marzo e con la forza militare dell’isolamento totale dei centri abitati.
Andranno processati tutti, governo vile e imprenditori avidi e sprezzanti, per un crimine contro l’umanità che mostra il vero volto della società libera, vivace e ricca in cui siamo in attesa soltanto di morire. Le aree industriali d’Italia si stanno trasformando in autentici lager che, esattamente come quelli a cielo aperto in Palestina, non hanno nulla da invidiare o rimproverare a quelli nazisti.
Mentre, per ora, gli unici a poter vantare la richiesta di una relazione davanti al Parlamento e alle camere riunite rimangono, purtroppo, soltanto i partiti della Destra, i sindacati confederali, colti di sorpresa dalle ultime giravolte di Conte non possono fare altro che minacciare un tardivo sciopero generale (qui). Il Pd, naturalmente, per bocca del ministro agli affari regionali Boccia, sottolinea il senso di responsabilità dimostrato dagli industriali e con Dario Franceschini ringrazia Conte, affermando di vedere, nell’ora più drammatica della storia della Repubblica: “un’abnegazione totale, unica e assoluta da parte di tutti, da Conte ai ministri che lavorano con competenza, tutti con grande generosità”.
Sorge a questo punto il dubbio che nei suoi silenzi, nei suoi prolungati rinvii e nelle decisioni autoritarie prese nel suo ufficio, contornato soltanto dai rappresentanti degli imprenditori e della finanza, l’uomo di pezza Conte sia niente di più e niente di meno di quel grigio e freddo burocrate esecutore di ordini descritto da Hannah Arendt nel suo fondamentale testo intitolato La banalità del male.
Ma non temete, pagheranno caro, pagheranno tutto.
https://www.carmillaonline.com/2020/03/22/le-citta-verranno-distrutte-allalba/
ARTE MUSICA TEATRO CINEMA
Tosca di Puccini
In occasione della rappresentazione de La Tosca alla Scala di Milano è stato divertente seguire le banalità mediatiche sull’antisovranismo, le chiacchiere contro l’uomo forte (“che se l’avessero provato…”), vedere la fuffa sculettare fuori e dentro il Teatro, osservare la faccia di Franceschini che di lì a poco avrebbe elargito 15 milioni non per i senza tetto, per i diseredati o che altro, ma per la “memoria, la memoria, la memoria!”…
Divertente, oltre che andare con l’orecchio alla sublime musica del Maestro Puccini, andare con la memoria (ehhh, c’è memoria e memoria!) alle parole del Maestro:
« Io sono per lo Stato forte. A me sono sempre andati a genio uomini come De Pretis, Crispi, Giolitti, perché comandavano e non si facevano comandare. Non credo nella democrazia, poiché non credo alla possibilità di educare le masse. E’ lo stesso che cavar l’acqua con un cesto! Se non c’è un governo forte, con a capo un uomo dal pugno di ferro, come Bismark una volta in Germania, come Mussolini, adesso in Italia, c’è sempre pericolo che il popolo, il quale non sa intendere la libertà se non sotto forma di licenza, rompa la disciplina e travolga tutto. Ecco perché sono fascista: perché spero che il fascismo realizzi in Italia, per il bene del Paese, il modello statale germanico dell’anteguerra ..»
(Giacomo Puccini, tesserato fascista e come tale fatto senatore… a proposito di senatori ). (Cit. Maurizio Murelli)
11 12 2019
Esoterismo, geopolitica, tradizione: all’arte di Alexey Guintovt non manca nulla.
di Luca Negri – 20 Dicembre 2017
Chi possiede una copia de La Quarta Teoria Politica di Aleksandr Dugin nella prima o seconda (da poco disponibile e ben più arricchita) edizione della NovaEuropa probabilmente si sarà soffermato sulle copertine. Sono opere d’arte. Un fondo giallo oro, da icona bizantina e sopra un rosso sangue che disegna guerrieri, uno perfino con testa di falco, come l’antico Horus egizio. Opere con un che di antico ma anche di futuristico, opere di Alexey Guintovt, premio Kandinskij 2008. Scelte con coerenza, dato che Guintovt è membro, dalla sua fondazione, dell’Eurasian Union of Youth, costola del partito euroasiatico ideato da Dugin. Al di là di come la si pensi in politica estera, l’arte di Guintovt lascia il segno. Forse non solo nei russi ma anche in noi italiani si risveglia qualcosa, come l’azione di un arcangelo di popolo, di un logos che possiamo capire. Sarebbe possibile in Italia (la si fa e lo ignoriamo? probabilmente sì) un’arte affine a quella di Alexey? Aprirebbe un fronte nella guerra dell’immaginario che ci tocca combattere? Abbiamo fatto due chiacchiere con lui, on line, nella lingua dei colonizzatori anglosassoni, per giunta, per capire che aria tira dall’altra parte del continente, a Mosca che forse è la Terza Roma.
Gli artisti, come scrisse Pound, sono le antenne della razza e Alexey mi pare un’ottima antenna. E usa molto le mani per creare le sue opere. Si dice seguace dei grandi maestri del passato, quelli che sapevano che l’arte è fatta da impronte della pelle, e lui non tralascia alcuna alchimia, dal disegno classico ad inchiostro alle simulazioni al computer. Predilige però i metodi tradizionali, come tradizionali sono in un certo senso i soggetti che rappresenta. Appunto qualcosa di antico e fantascientifico, qualcosa che buca la storia come le sue stelle rosse in volo come cosmonavi. Ma che pensieri, sensazioni e azioni vorrebbe far sorgere nel pubblico la sua arte? Alexey ha le idee chiare:
Il Postmoderno sovrasta tutti gli aspetti della vita e ci pone una domanda di fedeltà alla Tradizione, quella artistica compresa. Il mio messaggio è rivolto principalmente alle persone emarginate, ma non solo a loro. Mi rivolgo a coloro che sostengono la gerarchia divina, che resistono al paradigma del mondo moderno, ai suoi processi degenerativi, in accelerazione.
Su ogni piano, aggiunge, politico, culturale, nel caso militare. Ecco, non so quanti artisti di casa nostra oggi potrebbero affermare cose del genere. E i mercanti d’arte d’Occidente saranno a loro agio con un Guintovt che forse evoca il monumentalismo del Realismo Socialista? Ma no, lui nega decisamente.
Non copio mai la realtà del mondo materiale. Sono un simbolista, esploro una realtà di formazioni simboliche, come un’interfaccia fra le icone Ortodosse e l’avanguardia russa.
E allora parliamo dei colori, di tutto quel rosso e oro e nero, delle Stelle, la testa di falco…
Naturalmente i colori hanno un significato alchemico, è la sequenza della Grande Opera, ma il significato fondamentalmente è diretto e ovvio, per tutti: il nero è austerità, umiltà. Il rosso oro è la gioia della Pasqua! Io mi rivolgo a un numero illimitato di persone nel mondo che sono in grado di comprendere il linguaggio internazionale delle immagini, ma soprattutto in chi ha la sua trincea nella Tradizione e al popolo della Grande Russia e dell’Eurasia.
Esoterismo, geopolitica, profili di Apollo, ritratti di Eliade, Evola. Non mancano richiami all’Italia: la Lupa, il Colosseo, la Serenissima. Infatti dichiara immenso rispetto per la cultura Mediterranea. Grecia, Roma. Fa riferimento al Logos Italiano indagato da Dugin in Noomachia, poderosa opera (5 volumi) inedita in Italia. Ancora Dugin, che gli informati del web sanno non troppo lontano da Putin. L’ala sinistra dei social ha tifato eccome per il situazionismo in topless delle Pussy Riot finanziato da Soros (che Guy Debord si sia suicidato anche per preveggenza?). Ma insomma, chiediamo ad Alexey, nella Russia putiniana c’è libertà d’espressione?
Gli abitanti del mio paese, improvvisamente e contro la loro volontà, si son ritrovati in un mondo globalizzato e molte delle nostre opinioni son differenti da quelle dell’Occidente globale. Io ho vissuto in Europa e ti posso dire che in un certo senso oggi la Russia è uno dei paesi più liberi del mondo. Io ho vissuto anche nell’URSS e so bene cos’è il KGB. In carcere ci finirono mio padre, suo fratello. Mio nonno e il bisnonno perfino fucilati. Ora dovremmo esser liberi ma sperimentiamo invece, noi in Russia e voi in Europa, un’oppressione liberale. Una censura micidiale. I naziliberali ucraini hanno sostenitori anche Mosca, e sono altri liberali. Sono i responsabili delle decine di migliaia di morti nel sud della Grande Russia, nell’ex Ucraina. E non solo di quelli.
Non gli dico che qui in Italia da un quarto di secolo ci son politici che fanno a gara per l’agognata etichetta del più liberale. Ma il liberalismo di casa nostra, quello democratico e di sinistra, si ferma sulla soglia dell’antifascismo.
dd058f3adc24d3146a8b85595045e578
Un artista italiano che volesse far qualcosa di analogo al lavoro di Guintovt potrebbe in futuro incappare nelle spire della legge Fiano, se gli scappasse un’aquila o un fascio di troppo. Proviamo a spiegare una tale assurdità ad Alexey e lui non si stupisce: il liberalismo attacca le ideologie già sconfitte, il Comunismo e il Fascismo. E con quella scusa censura tutto ciò che non è conforme ai suoi piani. Ma lui confida che prima o poi le cose cambieranno, arriverà l’epoca di un’equidistanza dalle ideologie del Novecento, un’epoca ancorata nella Tradizione e che porterà a compimento le promesse di giustizia sociale.
Io, con cautela, riesco a vederla una nuova umanità. Quando il governo liberale non farà più ombra sul pianeta. E sarà libera l’armonia della creazione, libera di instaurare il Regno della Tradizione.
Ecco che dalle miserie di casa nostra con la legge Fiano e temibilissimi nazisti a Como, l’artista ci innalza ad un piano escatologico, quasi messianico. Tipicamente, logicamente russo, diremmo. Non ci rimane che ringraziarlo e augurargli buon lavoro.
FONTE:https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/arte/il-simbolismo-di-alexey-guintovt/
ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME
È lui. È tornato. È bazaar!
1- lavoro da remoto
2- deflazione
3- identità digitale marchiata
4- restaurazione verde
5- eliminazione del contante
6- desovranizzazione
7- sospensione dei diritti
8- sottrazione della prole in favore di servizi pubblici che attuano programmi imposti da privati
9- deliri di genere
10- anarchia immigrazionista
11- dematerializzazione del contante
12- privatizzazione della moneta
13- tso di massa
14- desacralizzazione
15- demenza da istruzione primaria
16- sociopatia da istruzione universitaria
17- distruzione della classicità
18- distruzione degli studi umanistici
19- demenza digitale
20- merdificazione delle arti
21- nichilismo e relativismo assoluto
https://www.facebook.com/100000248554468/posts/3062561217095467/
Americanizzare l’Italia
Francesco Erspamer 24 03 2020
In Italia la seconda repubblica ha espresso il tentativo di americanizzare l’Italia. I suoi fondamenti sono stati la liberalizzazione dell’editoria e dell’informazione, la sostituzione del proporzionale con un sistema elettorale maggioritario e personalistico (a cominciare da comuni e regioni), la frammentazione dello Stato in una federazione di pseudo staterelli regionali, la graduale privatizzazione di settori vitali per la sicurezza e sovranità nazionale quali la sanità, la scuola, i trasporti e l’energia. A iniziare il processo, già negli anni 80, erano stati i radicali; un’accelerazione gliel’ha data Berlusconi con le sue televisioni ma non avrebbe avuto successo senza l’attiva collaborazione di personaggi come Prodi, Veltroni, Bonino, Renzi, Salvini e parte della Lega.
Ma cosa significa americanizzare un paese? Per capirlo vi porto alcuni esempi di ciò che avviene negli Stati Uniti, anche in questi momenti di grave difficoltà per tanta gente.
Walmart, la più grande corporation per numero di dipendenti, non riconosce le assenze per malattia; chi sta male deve usare le sue ferie (che per tanti lavoratori ammontano a due giorni all’anno, per gli altri pochi di più) e quando finiscono smette di ricevere lo stipendio.
Amazon, una delle società più ricche del mondo, l’anno scorso è riuscita a non pagare praticamente nulla di tasse. Se infetti di coronavirus, i suoi dipendenti hanno diritto a un massimo di due settimane di congedo retribuito. A chiunque abbia altre malattie o sia infortunato, solo ferie non pagate. Inoltre gli straordinari sono obbligatori e chi li rifiuta viene licenziato.
Ancora più significativo il fatto che nel pacchetto per salvare l’economia attualmente in discussione, repubblicani e democratici siano d’accordo che dall’obbligo di offrire 14 giorni di congedo pagato ai malati di covid-19 (e solo a loro) vadano esentate le corporation con più di 500 impiegati. Sì, avete letto bene: non le piccole e medie imprese: quelle grosse. In modo che possano usare questa tragedia per espandere il loro monopolio. Cosa che Amazon sta già facendo sostituendosi all’intera struttura commerciale, chiusa per decreto.
E poi il sistema sanitario. Che rispetto all’Italia ha un vantaggio, per i benestanti; non essendoci di fatto strutture pubbliche, quelle private, quando non fossero in grado di accogliere tutti, selezioneranno chi può pagare di più. Quanto ai ricchi, si stanno comprando i loro ventilatori privati, da tenere inutilizzati finché non servissero a loro.
L’America non era così trent’anni fa: i liberisti si muovono in fretta e se vi distraete un attimo l’Italia finirà allo stesso modo. O magari questo modello vi piace: ricordo un giovane tassista milanese che la scorsa estate, prendendomi per uno straniero, mi disse in buon inglese che la cosa da vedere in città era Starbucks, altro che Duomo o Scala; e allora avete ragione a sostenere Salvini e a tollerare Renzi, i due amerikani de noantri: è lì che vi porteranno.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2758204020962803&id=100003196950060
DER ELEFANT IM RAUM (L’elefante nella stanza).
Pierluigi Fagan 23 03 2020
Un fantasma si aggira nelle statistiche mondiali sul fenomeno pandemico. Un solo Paese al mondo, mostra statistiche del tutto fuori logica tra i dichiarati contagiati ed i morti: la Germania.
E sì che la Germania è il Paese europeo più grande (demograficamente circa un terzo circa più grande dell’Italia, della Francia e dell’UK), ha un peso di popolazione anziana praticamente pari all’Italia ed in più, è il primo Paese europeo in cui si è accertata la precoce presenza del virus il che è ovvio visto che è anche il Paese con i maggiori contatti ed interscambi economici coi cinesi. Il virus è lì da più tempo che altrove, in un Paese pieno di anziani, un terzo almeno di più che in Italia, ma i tedeschi non muoiono. Lo “spread dei morti” tra ogni Paese del mondo e la Germania è ovunque alto ma si sa, quando si tratta di spread, ai tedeschi piace ben figurare.
Il mistero ha attratto i giornalisti anglosassoni, vi hanno scritto articoli a vario titolo il FT, the Guardian, the Indipendent, WSJ, ma molto meno la stampa europea. L’Espresso, l’altro giorno, vi ha posto ritardata attenzione confezionando un “the best of” di ragioni a spiegazione, copiato dagli articoli anglosassoni che avevano doverosamente riportato le risposte tedesche alle domande poste:
1) Il loro facente funzione di ISS, il Robert Koch Institute (RKI) afferma che i morti tedeschi sono più giovani quindi la popolazione anziana è stata misteriosamente per il momento evitata dal virus (a parte il medico della Merkel). Qualcuno sostiene che gli anziani tedeschi vivono più “isolati” dai giovani che non in Italia o Cina, ma francamente a me pare una stupidaggine insostenibile, anche perché andranno pur in giro a far la spesa come tutti, no? ma le spiegazioni arzigogolate hanno anche varianti;
2) i tedeschi sostengono che l’epidemia, da loro, si sarebbe sviluppata più tardi. Ma come? esistono studi pubblicati su the Lancet che confermano la precocità del paziente 0 in Germania come è ovvio che sia. Portano loro l’infezione in Lombardia ma non in Germania? Tutta Europa ha più morti percentuali di loro perché loro sono “in ritardo” nella diffusione del contagio? Incredibile … anche perché la stampa tedesca se ne uscì a gennaio e primi febbraio con notizie di una incredibilmente contagiosa e virulenta epidemia di influenza polmonare, rigorosamente diagnosticata come tale e non corona virus come probabilmente era. Alla domanda se RKI dispone di test Covid-19 post mortem, gli interessati hanno risposto sì ma i giornalisti inglesi hanno verificato che la strana struttura sanitaria tedesca che è iper-federale, crea notevoli asimmetrie tra centro e periferia, ognuno fa un po’ come gli pare. In più perché fare i tamponi ex post e non ex ante visto che dichiarano di farne in ognidove? Questa strana struttura della sanità tedesca darebbe anche conto del perché i tedeschi danno le cifre in ritardo mentre John Hopkins University che segue la pandemia dall’inizio, dà cifre diverse perché attinge direttamente ai Lander. Insomma, a voler pensar male si potrebbe notare una certa cortina fumogena di grande confusione fatta apposta per render difficile la comprensione reale degli eventi e sopratutto per darsi la libertà di sparare cifre ad estro;
3) poi c’è la versione secondo la quale i tedeschi farebbero molti più tamponi di chiunque altro, dichiarazione del RKI riportata anche dalla stampa inglese (in effetti RKI dichiara che “possono” far tamponi, non che li fanno). Non so, a me secondo altri dati non risulterebbe, o sono sbagliati i miei dati o la stampa inglese riporta dichiarazioni tedesche senza verificarle e chissà perché tutti fanno finta di crederci;
4) si arriva così alle note enormi capacità di ricovero ospedaliero e letti di terapia intensiva tedesche. Ma dati alla mano, è vero che la Germania sta messa meglio dell’Italia ma l’Italia starebbe comunque messa meglio di (in ordine) Francia, Svizzera, UK ed Olanda oltre a molti altri. Ma più che altro, questa spiegazione se sembra logica di primo acchito non lo è in approfondimento. In Italia il SSN ha retto botta per un bel po’ prima di andare in affanno ed è andato in affanno solo nell’area più colpita. I morti a casa perché gli ospedali son pieni, in Italia non compaiono nelle statistiche. In più i morti italiani censiti, passano dai letti di terapia intensiva e finiscono nella bara comunque, come per altro in tutto il mondo visto che non sembra esserci una cura effettiva ma solo un supporto terapeutico che è lo stesso in tutto il mondo. Cos’hanno i tedeschi di diverso? Letti più comodi? Respiratori fabbricati dalla Mercedes? Dottor House in ogni stanza? Non si sa …
Ma una rasoiata di Occkam comincia qui e lì a comparire a mezza bocca. Un portavoce del direttivo del’ISS che ogni sera affianca Borrelli in conferenza stampa, a precisa domanda, qualche giorno fa ha risposto qualcosa tipo “io so che noi contiamo sia “morti di” che i “morti con”, come contano gli altri, non lo so”. Da qualche giorno questo insistere sul fatto che noi contiamo -tutti- i morti è stata ripetuta da Borrelli, Brusaferro e altri membri dell’ISS che si alternano giornalmente anche fuori dal contesto della “questione tedesca”. Ieri hanno avanzato dubbi su questa differenza che è logicamente l’unica e per giunta auto-evidente statisticamente e logicamente parlando, un biologo su la Stampa ed uno sul Corriere.
Nessuno può ufficialmente accusare i tedeschi di contare i morti in modo scorretto è evidente, sarebbe guerra diplomatica ed anche improprio perché non lo si può dimostrare, ovviamente. E’ inoltre una questione più politica che non virologica o biologica, non sta a gli scienziati fare ipotesi di tal fatta anche se ogni biologo o virologo o statistico sa che quella sproporzione è talmente esagerata che non c’è altro modo per spiegarla. E così si spiega anche il silenzio pudico in Europa, chi va a fare una accusa così grave ed indimostrabile e pure antipatica perché politicizzare i morti è davvero brutto?
Abbiamo visto tutti come ogni cancelleria ha negato sin dall’inizio l’esistenza del problema del virus pur nota a tutti come ora viene fuori nei rapporti dati con grande anticipo tanto negli USA che in Francia, UK e non c’è motivo di non ritenere, anche Germania. E tutti abbiamo visto come i Paesi più ostinatamente difensori del mercato come ordinatore sociale abbiamo ritardato gli interventi a costo di mentire, inventare idiozie come “l’immunità di gregge”, modulare interventi ma salvaguardando l’operatività economica come plaudono anche molti insospettabili difensori del “market first”, forse involontari, qui da noi. Magari avanzando cautele costituzionali o biopolitiche o libertarie o sdilinquendosi davanti ai miracoli del “modello coreano” o solo perché ormai il far polemica su tutto gli parte di riflesso facebook-esistenziale. E vediamo tutti la reazione furibonda al decreto del Governo pur in ritardo, pur mal comunicato, pur pieno di difetti, quando tocchi la fabbrica ed il denaro scoppiano scintille, è ovvio.
Il governo tedesco non conta i morti reali per non spaventare la propria popolazione che lo costringerebbe a misure che vogliono ritardare il più a lungo possibile, come hanno provato a fare tutti, e questo avviene nel cuore dell’Europa, dell’Occidente democratico e trasparente che s’indigna per i ritardi cinesi e le nebbie russe. Il virus in Germania colpisce solo giovani alti, biondi e sanissimi, per questo le Merkel va in quarantena stanziando miliardi di miliardi per far fronte ai 90 morti dichiarati (cioè come gli svizzeri che sono otto volte di meno!) in un mese e mezzo su 82 milioni di individui. “Buying time”, comprare tempo pagandolo con morti non censiti. Berlino manipolando la sua opinione pubblica ed iniettando al contempo denaro nell’economia, si vuole garantire il suo rimaner al centro del sistema europeo anche nel “dopo”, perché è quella la sua “potenza”. Ed alla potenza si sacrifica tutto.
[Il post è della serie libere opinioni. Naturalmente seguo la faccenda da giorni ed ne ho letto e studiato il più possibile, per quanto mi è stato possibile. Se qualcuno ha da postare dati (le opinioni di articoli che si arrampicano sugli specchi per favore no), che facciano ulteriore luce, è il benvenuto. Vediamo chi mi fa cambiare opinione …]
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220503676797517&id=1100565428
BELPAESE DA SALVARE
Le multinazionali divorano l’Italia e la politica si gingilla su temi secondari
Paolo Maddalena – 14 febbraio 2020
Il pensiero neoliberista ha talmente invaso le menti degli italiani che, ad esempio, il preside del liceo Agnesi di Milano, scambiando la sua attività di dirigente scolastico con un attività commerciale, ha invitato gli studenti a comprare prodotti Nike (la più grande multinazionale di articoli sportivi) su Amazon, ricevendo in cambio dei crediti di acquisto per ulteriori acquisti sempre su Amazon.
Inoltre mentre l’ambiente è arrivato a una situazione di non ritorno (ieri la temperatura massima a Roma era 17 gradi e quella nell’Antartide era di 20 gradi, idonea a provocare un immediato scioglimento dell’intero continente antartico), e mentre l’Italia è stata classificata all’ultimo posto nelle previsioni dello sviluppo economico dell’Unione Europea, il Parlamento italiano, ad opera di Matteo Renzi, si gingilla su temi facilmente risolubili con un minimo di conoscenza giuridica, rimanendo insensibile ai gravissimi problemi sopra prospettati.
È invece su questi ultimi che bisogna concentrare l’attenzione: occorre soprattutto difenderci dal mercato generale e, purtroppo, anche dal mercato europeo che ci sta spogliando dell’intero patrimonio pubblico, tenendo presente che un Popolo senza un proprio patrimonio non può vivere e in particolare non può affrontare le emergenze che possono presentarsi, anche improvvisamente, come ad esempio l’infezione del Coronavirus, che è in aumento, secondo quanto comunicano le autorità cinesi, e che potrebbe richiedere un maggior impegno degli organismi sanitari italiani.
I nostri governi, ritenendo che nulla sia cambiato negli ultimi 40 anni, ignorano che il neoliberismo ha trasformato il precedente sistema economico produttivo keynesiano in un sistema economico predatorio, trasferendo la proprietà pubblica del Popolo nelle mani di soggetti e multinazionali che pensano solo ai loro interessi e non hanno nessuna preoccupazione di curare l’interesse pubblico.
È su questo punto che deve essere richiamata l’attenzione dei giornalisti e dei parlamentari come Gianluigi Paragone, il quale ha il coraggio di rendere pubblico agli italiani, con i suoi precisissimi interventi, qual è la nostra reale situazione in campo nazionale, europeo e internazionale e come sia opportuno tornare alle nazionalizzazioni che non sono affatto vietate dai trattati.
Siamo sicuri che esistono altri giornalisti e altri politici dotati di onestà intellettuale. Dunque invitiamo tutti a seguire questo luminoso esempio, per ora assolutamente solitario, ricordando che gli strumenti per risolvere tutti i problemi sono nell’attuazione della nostra Costituzione Repubblicana e Democratica, e soprattutto nell’attuazione degli articoli 1, 41, 42 e 43 Cost.
Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”
FONTE:https://www.attuarelacostituzione.it/2020/02/14/le-multinazionali-divorano-litalia-e-la-politica-si-gingilla-su-temi-secondari/
CONFLITTI GEOPOLITICI
L’assalto alla pace nel secolo della guerra ibrida

Carta di Laura Canali, 2018.
Il ritorno della politica di potenza tra Stati nell’èra dei conflitti asimmetrici può generare mostri.
Nel mondo post-guerra fredda diversi fattori hanno notevolmente ridotto la probabilità della guerra fra Stati: le missioni dei caschi blu, una nuova cultura promossa dalla mondializzazione degli scambi a tutto campo, un crescente ricorso alla giurisdizione internazionale e la rivoluzione digitale. Senza tuttavia che le potenze abbiano rinunciato all’uso della forza per ottenere vantaggi strategici, pratica oggi nota con l’espressione “guerra ibrida“.
Il termine stesso di guerra, che con l’opposto di pace costituisce – stando a Norberto Bobbio – “un tipico esempio di antitesi”, è stato istituzionalmente condannato e socialmente esorcizzato fino alla rimozione lessicale.
L’interdipendenza, in specie economica, ha creato una ragnatela di intrecci politici, diplomatici, industriali, finanziari tale da far sì che le potenze siano ormai divenute troppo grandi per farsi la guerra, per parafrasare una definizione coniata durante la crisi finanziario-economica del nuovo millennio. Tuttavia, come afferma Kenneth Waltz, “l’interdipendenza è una reciproca vulnerabilità […] accresce l’esigenza di gestire gli affari internazionali ma non produce un gestore capace di farlo […] davanti ai cambiamenti, il problema è quello di prevedere come varierà la possibilità di gestione costruttiva degli affari internazionali da parte delle grandi potenze” [1].
Purtroppo, a dispetto delle aspettative e dei codici, quella “gestione costruttiva” è tutt’altro che migliorata; come nel passato, il perdurare di tensioni e conflittualità del mondo reale dimostra che la sola professione di aderenza a principi universali e al diritto internazionale non implica in automatico comportamenti pacifici. Anticipando i tempi, il generale francese André Beaufre aveva pronosticato vent’anni fa che ci saremmo trovati in un contesto in cui “una lotta mantenuta su un registro minore sarà permanente. Allora la guerra grande e la vera pace saranno entrambe morte” [2]. È andata proprio così.
Dopo la fase bipolare, l’illusione della “fine della storia”, ancorché limitata alla fine delle ideologie, ha avuto breve durata: il mondo reale ha preso un’altra direzione. L’organizzazione simbolo del multilateralismo, l’Onu, è rimasta sempre assertiva sulle tematiche trascendenti. Eppure, sprovvista dagli stessi Stati membri di potere coercitivo, è apparsa in difficoltà di fronte ai rapidi cambiamenti globali. E così quando la soluzione di temi sensibili ha iniziato a interessare forti interessi degli Stati membri, al Palazzo di Vetro sono emersi il disaccordo e lo stallo. Manifestando come l’idea di ordine mondiale incarnata dalle Nazioni Unite sia ormai superata.
In questi frangenti, il processo decisionale diventa complicato e persino inconcludente: difficile quindi immaginare che in sede Onu si possano produrre decisioni capaci di incidere concretamente sul corso degli eventi. Questo guasto strutturale, riconducibile anche e soprattutto alla volontà dei suoi membri, non è purtroppo contemplato nella carta fondativa delle Nazioni Unite. È senza dubbio anche un problema generale di qualità e caratura delle classi dirigenti [3]: la défaillance dell’autorità suprema chiamata a governare gli affari internazionali ingenera un clima di insicurezza e sfiducia tra gli Stati nonché di incertezza e imprevedibilità delle relazioni internazionali. Non a caso il nuovo segretario generale António Guterres, all’apertura della 73ª sessione dell’Assemblea Generale, ha parlato di “disordine da deficit di fiducia” e invocato il “ripristino della solidarietà tra le nazioni”, chiedendo di “riparare la fiducia infranta”.
Due tendenze si stanno intrecciando nel nuovo millennio, in particolare a partire dal tragico 11 settembre 2001. Da un lato si è modificata e ampliata la gamma e la geografia dei rischi e delle minacce, le cui dinamiche evolutive sono divenute sempre più rapide, intrecciate e complesse. Dall’altro, l’incremento delle manifestazioni di tensione internazionale e di conflitto si è saldato con la crisi palese di governo planetario basato sugli Stati.
Oggi campeggia la minaccia non convenzionale di carattere ormai internazionale, come quella portata avanti dalle varie correnti del fanatismo religioso. Mentre l’irruzione sulla scena mondiale di al-Qa’ida nel 2001 ha presentato l’ulteriore novità degli “attori non statuali autonomi” [4] che svincola il quadro conflittuale da una regolamentazione equa. Anche perché, a differenza del passato, quest’ultimo è ora animato da attori sciolti dalle norme comportamentali e vincoli disciplinari che prima imbrigliavano gli Stati.
A rendere il confronto asimmetrico ci pensa l’enorme divario fra i mezzi a disposizione, simbolizzato dall’ordigno improvvisato, confezionato con gadget tecnologici contro il carro di ultima generazione dagli insorti iracheni durante l’occupazione americana. Si tratta di una variazione di non poco conto, che ha cambiato la stessa natura della guerra, passando dalla violenza organizzata e regolata, fino a quella barbarica e gratuita: trucidare per comunicare, come ha fatto lo Stato Islamico, andando ben oltre la trasgressione sistematica.
A peggiorare il tutto, il ritorno in auge della guerra per procura, che mette in risalto il ruolo degli attori esterni. Nelle aree calde di crisi, una parte di rilievo delle potenze esterne ha riscoperto questo metodo fondato su tecniche di terrorismo e guerriglia messe in atto da attori armati locali e agevolate con operazioni “coperte” dei mandanti. C’è sempre qualcuno che trae vantaggio dalla situazione di confusione. A ben vedere, é una vecchia storia: negli anni Ottanta si ricordano lo scandalo Iran-Contra e quello più noto dell’intervento di Usa, Francia, Italia, Regno Unito in Libano. Quest’ultimo fu ostacolato dalle potenze regionali (Siria e Iran) mediante il ricorso a una lotta strisciante costellata da attentati terroristici condotti da organizzazioni come Hezbollah e altri gruppi, fino a causare il ritiro degli occidentali.
Nel frattempo, oltre alle lunghe “guerre tra poveri” come quella tra Eritrea ed Etiopia, la gamma della conflittualità si è ampliata con la comparsa della “guerra cautelativa” (preemptive war) di provenienza statunitense, concepita contro un attacco imminente ma non ancora sferrato. Contrariamente a quanto avvenuto nella guerra del Golfo nel 1991, quando il presidente Bush padre non si era spinto fino a Baghdad e fu per questo rimproverato dai neoconservatori, l’invasione e il successivo cambiamento di regime in Iraq nel 2003 hanno sconvolto l’intero Medio Oriente, rafforzando il ruolo dell’Iran.

Carta di Laura Canali
In questo scenario di crisi del multilateralismo e di diffusione della violenza, la guerra è ora diventata “ibrida” e le dimensioni interessate dal conflitto si sono decisamente ampliate [5]. In questo ambito rientrano le teorie di marca cinese (guerra senza limiti) e russa (dottrina Gerasimov) volte al perseguimento degli obiettivi strategici mescolando, fino a confonderle, le linee divisorie tra guerra e politica, combattenti e non combattenti [6]. Nell’epoca della rottura degli schemi esse rappresentano la risposta alla precedente rivoluzione negli affari militari (Rma, nell’acronimo in inglese) che aveva portato gli Stati Uniti alla strabiliante vittoria del 1991 contro l’Iraq. Un successo figlio proprio delle evoluzioni tecnologiche che avevano reso i sistemi di comunicazione e integrazione veri e propri “moltiplicatori di forza” [7]. Oggi, i mezzi della tecnologia dell’informazione e della comunicazione digitale fanno sì che “piccoli gruppi possono finanziare, pianificare, rifornire [di armi] e coordinare attacchi su scala planetaria senza curarsi di leggi e governi” [8]. E ogni ambito della vita, anche quello più neutrale, può essere impiegato come arma o campo di battaglia.
In definitiva, la guerra tradizionale, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra in forme degenerate. Lo sviluppo dei conflitti del nostro tempo sembra seguire lo schema del modello teorico di insurrezione popolare elaborato da Mao Zedong – indiretto, articolato sulla “lotta totale prolungata e di debole intensità militare” e volto all’usura del morale e alla stanchezza del fronte avversario [9]. A mente dell’immagine clausewitziana del camaleonte, la guerra, con il suo marchio tipico inconfondibile dell’aggressione, ha dunque assunto sembianze diverse. A volte meno violente ma altrettanto dannose nei loro effetti, come quelle nei campi economico-finanziario, cibernetico e socio-politico-mediatico, in un possibile mélange di combinazioni varie. Alle tensioni si abbina un incremento generalizzato delle spese militari.
Questo nuovo modo del guerreggiare, marcato dal deliberato rifiuto di limiti e vincoli, segna dunque la dipartita dal bellum “civilizzato” all’occidentale. Il quale, peraltro, con la comparsa di entità non statuali è oramai “senza regole” e alla portata di chi vuole sfidare il sistema in dimensioni diverse, possibilmente inattese, da quelle che l’avversario vorrebbe imporre, forte di una superiorità quasi assoluta.
Con riferimento all’essenza della teoria clausewitziana, possiamo allora dire che nella prospettiva contemporanea che ha visto cadere ogni barriera, dove le alleanze non sembrano più scontate, la guerra appare ora come “continuazione della politica con l’immissione di qualsiasi mezzo”. Dove l’aggettivo indefinito qualsiasi sostituisce quello precedente, altri, che l’autore riferiva sì a mezzi distinti – in specie militari – ma pur sempre contemplati negli ordinamenti sulle relazioni tra Stati. Durante le crisi, i mezzi appartenenti alle categorie del qualsiasi sono invece capaci di ben altro effetto rispetto a quelli tradizionali diplomatico-politico-economici. Volendo fare un paragone storico, si tratterebbe di una condizione analoga all’impiego dei gas asfissianti nella prima guerra mondiale. È vero che la sorpresa, se non si dimostra capace di sortire effetti strategici, dura poco. Normalmente, la vittima prima o poi si adegua e si dimostra capace di rispondere a tono: a quel punto, i contendenti li accantonano e si riprende a guerreggiare come prima.
In questo nuovo contesto, gli scenari di guerra mettono in risalto due aspetti. Primo, la necessità di affrontare la guerra stessa con una gamma allargata di strumenti operativi, come gli interventi “umanitari” del nostro tempo. Secondo, non hanno affatto funzionato i metodi impiegati nella parte significativa della ricostruzione (state o nation building) anche definita “ingegneria sociale”. Ciò accade quando l’intervento armato, anche il meglio intenzionato, è percepito dalla popolazione locale come imposizione con le baionette di un sistema politico estraneo alla cultura autoctona.
Il nodo da sciogliere è costituito ancora dall’individuazione e dall’uso appropriato dei mezzi necessari. In breve, il venir meno di quel potere incorporeo e immateriale, non visibile ma pur sempre presente, definito nella letteratura anglosassone come soft power (in francese puissance douce), ha alzato i costi dello hard power. Chi interviene si trova a operare in un ambiente reso complicato dalla brutalità, divenuta una sorta di leitmotiv che spiralizza i conflitti all’interno, rendendoli sempre più “guerre incivili” [10]. Può capitare allora di dover combattere dei mostri, come il sedicente Stato Islamico; ma qui, come ha ricordato l’Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Ra’ad al-Hussein citando Nietzsche, “quando si combatte un mostro bisogna prevenire il rischio di diventare nel frattempo come lui”.
In un’epoca che sembra non conoscere più zone franche di sicurezza, gli interventi militari sono sfociati in una sorta di “guerre a metà”, in cui il fronte è stato spostato perlopiù nelle città. In ambito militare, chi le conduce deve possedere la flessibilità di passare adeguatamente da un tipo di intervento ad altri più sofisticati – come nel caso afghano, dall’antiterrorismo alla controinsurrezione. Un fattore questo che concorre alla notevole durata degli interventi, come nello stesso Afghanistan (oltre 17 anni), nei quali imbastire una strategia di uscita sembra altrettanto complicato che ottenere vittorie decisive.
Emblematico è l’intervento in Libia del 2011, avvenuto un secolo dopo la conquista italiana. Un’operazione che era stata presentata nell’ambito della dottrina umanitarista della responsabilità di proteggere. Ma che è miseramente fallita in fase applicativa. Sia perché il baricentro politico ha finito per spostarsi sul cambio di regime. Sia perché, lasciando un imperdonabile vuoto di potere, ci si è dimenticati che la predetta responsabilità implica anche quella di ricostruire – “chi rompe paga”.
Questo precedente, combinato con l’analoga avventura irachena, aiuta a capire perché il presidente “riluttante” Barack Obama abbia sempre preferito dirigere dietro le quinte (leading from behind) e non impelagarsi in un ulteriore conflitto nel mondo islamico, nonostante il superamento della soglia dell’impiego dell’arma chimica da parte del governo siriano di Bashar al-Asad. Aiutato in questo dai mezzi di nuova generazione per guerreggiare a distanza (remote warfare) a suon di droni, potere aereo, facilitatori sul campo e selezionati contingenti di forze speciali. Un dispositivo che sembrava obbedire più all’indirizzo politico che non alle esigenze tattiche sul terreno.
Oggi, dunque la dinamica ciclica di guerra e pace mostra la prevalenza di uno stato di provvisorietà tra i due assoluti. Fonte, a sua volta, di un contesto grigio di incertezze e stati di tensione continua. Una situazione di “pace negativa” [11]. Le guerre, non più addomesticate da regole e principi, continuano a rivelarsi pertanto come realtà con cui fare i conti. Viste le difficoltà nel portarle a termine, si possono solo gestire.
A queste dinamiche rischiano di non sfuggire nemmeno i cambiamenti politici interni alle nostre società. Come ha osservato recentemente Ken Endo dell’università di Hokkaido, con l’ascesa di paesi sviluppati qualificabili come democrazie illiberali si profilano i rischi di un ritorno in voga dell’autoritarismo che, con le sue “ripercussioni socio-economico-politiche” divenute oramai concrete, travalica i confini nazionali [12] e rende più competitivo che mai il panorama mondiale. In questo quadro, si è determinato un divario nel modo stesso di concepire lo “strumento” della guerra. Da un lato le democrazie rappresentative tradizionali con il retroterra giuridico del pensiero occidentale, che vedono il contesto in termini alternativi – pace o guerra. Dall’altro i loro sfidanti che sfumano le distinzioni fra l’una e l’altra.
Siamo in un’epoca in cui minacce, modi e metodi trasgressivi di imposizione con la forza appaiono tollerati, veri e propri faits accomplis, come se tutto fosse permesso finché non si superano certe soglie. Il rischio maggior risiede negli abbagli e negli assunti inesatti sulla reazione delle controparti – un fatto confermato dalle cronache della guerra in Siria. Proprio attorno alla Siria martoriata da oltre 7 anni di guerra civile si è formato un nuovo quadro politico “regionale”, che Jean-Marie Guéhenno ha etichettato come “alleanza non-santa” composta da Iran, Russia e Turchia e che intende presentarsi come foro ristretto in sostegno alla debole azione delle Nazioni Unite a Ginevra [13]. Se da un lato si deve rilevare che questa intesa appare geopoliticamente fittizia e dunque strutturalmente fragile, dall’altro la novità di questa iniziativa sul Vicino Oriente, sinora appannaggio occidentale, suscita un certo interesse [14]. Resta quindi da vedere se e in quale misura potrà sortire risultati concreti.
In questa cornice, la “guerra a pezzi” cui fa riferimento papa Francesco non può essere paragonabile a quelle di marca occidentale e totalizzanti del Novecento. L’incalzare di fatti strategici e la spiralizzazione delle crisi, i cui effetti si sono amplificati, mettono a dura prova le capacità gestionali di qualsiasi sistema. E sembrano indicativi di un nuovo corso della storia, in cui la possibilità di deflagrazione di conflitti maggiori è ammessa all’unisono dai vari leader mondiali. In questa prospettiva, lo storico francese Philippe Fabry propone uno schema articolato su grandi cicli che potrebbe facilitare le capacità di previsione. Lo studioso individua gli imperi revanscisti (revanchard) “napoleonico, hitleriano, putiniano” ai quali si oppone “un campo democratico condotto da una talassocrazia, cioè una potenza marittima che vuole difendere una certa visione del diritto internazionale” – ieri l’Inghilterra oggi gli Usa [15].
Oggi abbiamo una “talassocrazia americana” (termine non associabile allo status di impero), che si confronta con un “nuovo impero russo” definito tellurocratico (termine di derivazione latina, nella letteratura classica “epirocrazie”). Il quale, a differenza del modello talassocratico (democratico, aperto, cosmopolita), è caratterizzato da “una visione globalmente autoritaria, continentale, tradizionalmente dirigista, protezionista”. Ne nasce un clima di tensione prossima allo stadio bellico, da terza guerra mondiale per l’appunto.
Un monito per l’Italia, affinché conservi la tradizionale vocazione marittima che la geografia e la storia ci hanno assegnato nel Mediterraneo: le cose non sono andate bene quando abbiamo lasciato quel campo per seguire direzioni continentali. L’autore identifica un possibile scontro tra gli alleati e la Russia entro il 2020 nei paesi baltici [16]. Che tuttavia appare poco plausibile, alla luce dell’esperienza della guerra fredda.
Stiamo semmai assistendo a una competizione implacabile tra le grandi potenze del momento a vocazione espansiva: gli Usa e la Cina. Washington ha impresso una escalation alla guerra dei dazi con Pechino per timore che quest’ultima accumuli – in barba alla proprietà intellettuale americana – la tecnologia necessaria a sospingere la propria ascesa. Il piano noto come Made in China 2025 suscita timori di una nuova generazione di accordi che potrebbero dare alla Cina il controllo sulle tecnologie del domani. E per questo non è passato inosservato. Non resta esclusa dalla contesa la minaccia atomica, con l’ammodernamento degli arsenali prefigurato dall’annunciato ritiro di Washington dal Trattato Inf fra Usa e Russia.
Nel Mar Cinese Meridionale – un “altro Mediterraneo” di 1,4 milioni di miglia quadrate, dove transita circa un terzo del commercio mondiale – Pechino ha cementificato e quindi militarizzato le minuscole isole contese, dalle Spratly alle Paracel [17]. Il tutto all’insegna del motto “nascondere la forza e guadagnare tempo”, che in questo caso si sostanzia nel consolidamento delle capacità anti-accesso e diniego d’area (a2/ad nella sigla in inglese). Nella dimensione marittima, l’impianto di tale capacità d’interdizione si materializza nel dispiegamento di forze simboliche e nell’uso di una combinazione di mezzi offensivi e difensivi, attivi e passivi, al fine di impedire l’accesso a uno spazio fisico o il movimento al suo interno. Con la postura cinese divenuta più aggressiva, gli “innocent passages” dei cacciatorpediniere della Marina Usa – volti a ribadire il principio della libertà di navigazione in quegli spazi ora fortificati – si iniziano a complicare. Manca, peraltro, una linea rossa tra Stati Uniti e Cina.
Come conclude Lawrence Freedman, “solo il drammaturgo conosce, sin dal principio, se sta scrivendo una commedia oppure un tragedia. Lo stratega mira a una commedia, ma rischia la tragedia” [18]. Peraltro, dal palcoscenico delle politiche di potenza retrocede sempre più un altro attore: la diplomazia, ridotta a operare “sotto la protezione del cannone” in una vera e propria “guerra alla pace” [19].
Davvero la pace, come sostiene Luttwak a proposito dell’approccio dei romani d’Oriente alla strategia, è una perenne “interruzione temporanea dello stato di guerra” [20]?
NOTE
1. K. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, New York, 1979, pp. 139 e 210.
2. A. Beaufre, Introduction à la Stratégie, Hachette, Paris 1998, pag 143.
3. R. Cohen, “The Age of Distrust”, New York Times, 19/9/2016. L’autore riprende analisi che affrontano i temi scottanti del momento rimarcando l’inadeguatezza delle leadership politiche, scollate da società che dovrebbero rappresentare e incapaci di rispondere pubblicamente. In definitiva, la sfida della democrazia è il suo rinnovo, dato che l’attuale “sistema è divenuto taroccato” e non rappresenta la base.
4. J. Robb, Brave New War, John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2007, p. 31.
5. Termine coniato da James Mattis, Generale dei Marines, attuale segretario alla Difesa nell’amministrazione Trump, e dal Colonnello Frank Hoffman per definire una miscela personalizzata di armi convenzionali, tattiche irregolari, terrorismo, comportamento criminale e campi di contrasto per ottenere obiettivi politici.
6. Rimando al mio “Il Dilemma Mediterraneo: contenere o affrontare i conflitti in atto?”, Osservatorio Strategico 2016, Centro Militare Studi Strategici (Cemiss), Il Ritorno della Geopolitica, dicembre 2015.
7. È definita come “una capacità che, se aggiunta e utilizzata da una forza combattente, aumenta significativamente il suo potenziale di combattimento di quella forza e quindi la probabilità di successo della missione”, pubblicazione del dipartimento della Difesa Usa, JP1-02, ed. aprile 2001, rivista 2007, p. 211.
8. Robb, op. cit., p. 30.
9. Ibidem, p. 143.
10. Rimando al mio “La terza guerra mondiale a pezzi e la bagarre multipolare”, Rivista Marittima, luglio/agosto 2015.
11. V. “Les notions de paix et guerre”: https://goo.gl/PwYeCg. Quella positiva, nella definizione di Joahn Galtung, beneficia della presenza di fattori di sviluppo, cooperazione e integrazione tra le parti.
12. Si pensi all’influenza sulle elezioni Usa della Russia, o all’astensione della Grecia dalla votazione no sui diritti umani contro la Cina.
13. J.-M. Guéhenno, The Fog of Peace, The Brookings Institution, Washington D.C. 2015, p. 287.
14. Rimando al mio “Gli Spazi Trans-Mediterranei Contemporanei à Vol d’Oiseau”, Rivista Marittima, marzo 2018.
15. P. Fabry, Atlas Des Guerres à venir?, Institut Diderot, Paris, 2017.
16. Ibidem p. 112.
17. Rimando al mio “Il Caleidoscopio dei Mediterranei”, Rivista Marittima, luglio/agosto 2017.
18. L. Freedman, Strategy: A History, Oxford University Press, New York, 2013, p. 629.
19. R. Farrow, War on Peace, The end of Diplomacy and the Decline of American Influence, Norton & Company, New York, 2018, p. xxxii.
20. E.N. Luttwak, La Grande Strategia dell’Impero Bizantino, Rizzoli, Milano 2009, p. 74.
https://www.limesonline.com/lassalto-alla-pace-nel-secolo-della-guerra-ibrida/108881?refresh_ce
CULTURA
Uno si divide in due
di Alain Badiou
In Il secolo, Cap. 6, 7 – aprile 1999
Il secolo, dunque, non è in alcun modo un secolo di “ideologie” nel senso dell’immaginario e delle utopie. La sua determinazione soggettiva principale è la passione del reale, di ciò che è immediatamente praticabile qui e ora. Abbiamo dimostrato che l’importanza della finzione non è che una conseguenza di tale passione.
Che cosa dice il secolo, a proposito del secolo? Che, in ogni caso, non si tratta del secolo della promessa, ma del compimento. È il secolo dell’atto, dell’effettivo, del presente assoluto, non quello dell’annuncio e dell’avvenire. Dopo millenni di tentativi e di insuccessi, il secolo vive se stesso come il secolo delle vittorie. È al secolo precedente, all’infelice romanticismo del xix secolo che gli attori del xx riservano il culto del tentativo vano e sublime, e quindi l’asservimento ideologico. Il xx dice: basta con i fallimenti, è l’ora delle vittorie! Questa soggettività vittoriosa sopravvive a tutte le apparenti disfatte, in quanto non è empirica, ma costituente. La vittoria è il motivo trascendentale che organizza il fallimento stesso. Uno dei nomi di tale motivo è “rivoluzione”. La rivoluzione d’Ottobre, le rivoluzioni cinesi e cubana, e poi le vittorie degli algerini e dei vietnamiti nelle lotte di liberazione nazionale valgono tutte come prova empirica del motivo e sconfiggono i fallimenti, riparano i massacri del giugno 1848 o della Comune di Parigi.
Il mezzo della vittoria è la lucidità, teorica e pratica, nei riguardi di uno scontro decisivo, di una guerra finale e totale. Dal fatto che tale guerra sia totale deriva che la vittoria sia veramente vittoriosa.
Come abbiamo detto, sotto questo aspetto il secolo è il secolo della guerra. Ma tale enunciato mette in gioco parecchie idee concernenti la questione del Due, o della scissione antagonistica. Il secolo ha decretato che la sua legge era il Due, l’antagonismo, e in questo senso la fine della guerra fredda (l’imperialismo americano contro il campo socialista), che è l’ultima figura totale del Due, è anche la fine del secolo. Il Due, tuttavia, si declina secondo tre significati:
- Un antagonismo centrale, due soggettività organizzate su scala planetaria in un combattimento mortale di cui il secolo è la scena.
- Un antagonismo non meno violento tra due modi diversi di considerare e di pensare l’antagonismo. È l’essenza stessa dello scontro tra comunismo e fascismo. Per i comunisti, lo scontro planetario è, in ultima istanza, quello tra classi, mentre per i fascisti radicali è quello tra nazioni e razze. Qui il Due si divide in due. Vi è un intreccio tra una tesi antagonistica e più tesi antagonistiche sull’antagonismo. Questa seconda divisione è essenziale, forse anche più della prima. In fondo gli antifascisti erano più numerosi dei comunisti ed è caratteristico che la seconda guerra mondiale si sia fatta su questo sfaldamento derivato e non su una concezione unificata dell’antagonismo, la quale ha prodotto solo una guerra “fredda”, tranne che in periferia (guerre di Corea e del Vietnam).
- Il secolo è convocato come secolo produttore, attraverso la guerra, di un’unità definitiva. L’antagonismo verrà superato attraverso la vittoria di uno dei campi sull’altro. Possiamo quindi anche dire che, in questo senso, il secolo del Due si anima del desiderio radicale dell’Uno. Ciò che dà nome all’articolazione dell’antagonismo e della violenza dell’Uno è la vittoria come attestazione del reale.
Notiamo una volta di più che non si tratta di uno schema dialettico. Niente lascia prevedere una sintesi, un superamento interno della contraddizione. Al contrario, tutto si orienta verso la soppressione di uno dei due termini. Il secolo è una figura di giustapposizione non dialettica del Due e dell’Uno. La questione, qui, è di sapere quale bilancio fa il secolo del pensiero dialettico. Nell’esito vittorioso, la forza motrice è l’antagonismo stesso, o il desiderio dell’Uno?
A questo proposito vorrei evocare un episodio, a suo tempo famoso e oggi dimenticato, delle rivoluzioni cinesi. Verso il 1965 in Cina si apre quella che la stampa locale, sempre inventiva nella definizione dei conflitti, chiama “una grande lotta di classe nel campo della filosofia”. La lotta contrappone coloro per i quali l’essenza della dialettica è la genesi dell’antagonismo, espressa nella formula “uno si divide in due”, a coloro per i quali l’essenza della dialettica è la sintesi dei termini contraddittori e per i quali, quindi, la formula giusta è “due si fondono in uno”. Scolastica apparente, verità essenziale. Si tratta infatti dell’identificazione della soggettività rivoluzionaria, del suo desiderio costituente. È il desiderio della divisione, della guerra, oppure il desiderio della fusione, dell’unità, della pace? In Cina, comunque, a quell’epoca vengono dichiarati “sinistrorsi” quanti sostengono la massima “uno si divide in due”, e destrorsi quanti predicano che “due si fondono in uno”. Perché?
Che la parola d’ordine della sintesi (due si fondono in uno), intesa come formula soggettiva, come desiderio dell’Uno, venga considerata destrorsa dipende dal fatto che per i rivoluzionari cinesi essa è assolutamente prematura. Il soggetto di tale massima non ha attraversato il Due fino in fondo, non sa ancora che cosa sia la guerra di classe integralmente vittoriosa. Ne consegue che l’Uno di cui nutre il desiderio non è ancora neanche pensabile, vale a dire che, sotto il pretesto della sintesi egli si richiama all’Uno antico. Questa interpretazione della dialettica è quindi restauratrice. Non essere conservatore, essere un attivista rivoluzionario al presente, significa obbligatoriamente desiderare la divisione. La questione della novità si pone subito come quella della scissione creatrice nella situazione specifica.
La rivoluzione culturale cinese, soprattutto negli anni 1966 e 1967, contrappone con una furia e una confusione inimmaginabili i sostenitori dell’una o dell’altra versione dello schema dialettico. In verità vi sono coloro che, al seguito di Mao (in quel periodo praticamente minoritario nella direzione del partito), pensano che lo stato socialista non debba essere la fine ripulita e poliziesca della politica di massa ma, al contrario, uno stimolo al suo scatenarsi all’insegna dell’avanzata verso il comunismo reale. E coloro che, al seguito di Liu Shaoqi e soprattutto di Deng Xiaoping, pensano che, essendo la gestione economica l’aspetto principale della faccenda, le mobilitazioni popolari siano più nefaste che necessarie. La gioventù scolarizzata sarà la punta di diamante della linea maoista.
I quadri del partito e numerosi quadri intellettuali vi si opporranno più o meno apertamente. I contadini resteranno nell’aspettativa. Alla fine gli operai, forza decisiva, saranno talmente frantumati in organizzazioni rivali che, a partire dal 1967-1968 e con il rischio che lo stato venga travolto dalla tormenta, si dovrà fare intervenire l’esercito.1 A questo punto si apre un lungo periodo di scontri burocratici quanto mai complessi e violenti, che non escludono irruzioni popolari e che saranno protratti fino alla morte di Mao (1976), rapidamente seguita da un colpo di stato termidoriano che riporta Deng al potere.
Questo tornado politico è così nuovo e nello stesso tempo così oscuro circa le poste politiche in gioco, che molte delle lezioni che esso senza dubbio comporta per il futuro delle politiche di emancipazione non ne sono ancora state desunte, sebbene esso abbia fornito un’ispirazione decisiva al maoismo francese tra il 1967 e il 1975, l’unica corrente politica innovatrice e coerente del dopo-maggio ’68. Certo è, in ogni caso, che la rivoluzione culturale segna la chiusura di tutta una sequenza, quella il cui “oggetto” centrale è il partito e il concetto dominante il proletariato.
Tra parentesi, va oggi di moda, tra i restauratori del servilismo imperiale e capitalista, qualificare tale episodio senza precedenti come una bestiale e sanguinosa “lotta per il potere”, ossia come il tentativo di Mao (allora in minoranza nell’ufficio politico) di risalire a ogni costo la china. Rispondiamo anzitutto che qualificare come “lotta per il potere” un episodio politico di questo tipo equivale a rendersi ridicoli, sfondando una porta già spalancata. I militanti della rivoluzione culturale non hanno cessato di citare Lenin, quando dice (magari non è proprio quanto ha fatto di meglio, ma questo è un altro problema) che, in definitiva, “il problema è quello del potere”. La posizione minacciata di Mao era una posta esplicita ed era stata indicata dallo stesso Mao. Le “trovate” dei nostri interpreti sinologi2 non sono che i temi immanenti e pubblici della quasi- guerra civile in corso in Cina tra il 1965 e il 1976, guerra la cui sequenza propriamente rivoluzionaria (nel senso dell’esistenza di un pensiero politico nuovo) non ne è che il segmento iniziale (1965-1968). Del resto, da quando mai i nostri filosofi politici considerano orrendo il fatto che un dirigente in pericolo tenti di riacquistare la propria influenza? Non è forse ciò di cui parlano dalla mattina alla sera, giudicandolo l’essenza dilettevole e democratica della politica parlamentare? In secondo luogo va detto che il significato e l’importanza di una lotta per il potere si giudicano dalle poste in gioco. Soprattutto quando i mezzi di tale lotta sono classicamente rivoluzionari, nel senso che faceva dire a Mao che la rivoluzione “non è un pranzo di gala”, ma una mobilitazione senza precedenti di milioni di giovani e di operai, una libertà di espressione e di organizzazione praticamente inaudita, manifestazioni gigantesche, assemblee politiche in tutte le sedi di studio e di lavoro, discussioni schematiche e brutali, delazioni pubbliche, uso ricorrente e anarchico della violenza, ivi compresa la violenza armata ecc. Chi, oggi, può mai negare che Deng Xiaoping (qualificato dagli attivisti della rivoluzione culturale come il “secondo dei massimi responsabili impegnati, pur all’interno del partito, nella via capitalista”) si trovasse in effetti su una linea di sviluppo e di costruzione sociale diametralmente opposta a quella, collettivista e innovatrice, di Mao? Non lo si è forse visto (dopo essersi impadronito del potere con un colpo di stato burocratico alla morte di Mao) attuare in Cina, per tutti gli anni ottanta e fino alla sua morte, una sorta di neocapitalismo selvaggio, corrotto e tanto più illegittimo in quanto, oltretutto, manteneva il dispotismo del partito? In tutte le questioni, e soprattutto nelle più importanti (rapporti tra città e campagne, tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra partito e masse ecc.) si ritrovava quello che i cinesi, nel loro colorito linguaggio, chiamavano una “lotta tra le due classi, le due vie e le due linee”.
Ma le violenze, così spesso estreme? E le centinaia di migliaia di morti? E le persecuzioni, in particolare contro gli intellettuali? Ripeteremo la stessa cosa detta a proposito di tutte le violenze che nella Storia hanno accompagnato fino a oggi i tentativi allargati di politica libera, di ribaltamento dell’ordine eterno che sottomette la società alla ricchezza e ai ricchi, alla potenza e ai potenti, alla scienza e agli scienziati, al capitale e ai suoi servi, senza tenere conto né di ciò che la gente pensa, né dell’intelligenza collettiva operaia né di qualsiasi pensiero non omogeneo all’ordine perpetuante l’ignobile regola del profitto. Il tema, oggi praticato, dell’emancipazione totale nell’entusiasmo del presente assoluto, è sempre situato al di là del Bene e del Male in quanto, nelle circostanze dell’azione, l’unico Bene conosciuto è quello con cui l’ordine stabilito dà il nome prezioso alla sua sussistenza. A quel punto, l’estrema violenza ha il suo corrispondente nell’estremo entusiasmo, dato che, in effetti, si tratta di trasmutare tutti i valori. La passione del reale non ha morale. La morale, come ha ben visto Nietzsche, ha statuto solo come genealogia. E un residuo del vecchio mondo. Di conseguenza, la soglia di tolleranza per ciò che, visto dal nostro vecchio e pacifico presente, è il peggio, è estremamente alta, qualunque sia il campo in cui si milita. È questo, evidentemente, che induce certuni a parlare oggi della “barbarie” del secolo. Tuttavia non è giusto isolare questa dimensione della passione del reale. Anche nel caso della persecuzione degli intellettuali, per disastrosi che ne siano lo spettacolo e gli effetti, occorre ricordare che, a renderla possibile, è il fatto che non sono i privilegi del sapere a determinare l’accesso politico al reale. Come disse Fouquier-Tinville durante la rivoluzione francese giudicando e condannando a morte Lavoisier, creatore della chimica moderna: “La Repubblica non ha bisogno di scienziati”. Parole barbare se mai ve ne furono, estremiste e irragionevoli quant’altre mai, ma che bisogna intendere, al di là di loro stesse, nella forma assiomatica abbreviata di: “La Repubblica non ha bisogno”. Non è dal bisogno, dall’interesse o dal sapere privilegiato (suo correlato) che deriva la cattura politica di un frammento di reale, ma dalla presenza, e solo da essa, di un pensiero collettivizzabile. In altri termini: la politica, quando esiste, fonda il proprio principio di realtà, e non ha bisogno di nient’altro se non di se stessa.
Ma forse, oggi, viene considerato barbaro ogni tentativo di sottoporre il pensiero alla prova del reale, politico o meno che esso sia? La passione del reale, alquanto raffreddata, cede (provvisoriamente?) il campo all’accettazione, ora gioiosa, ora scialba, della realtà.
È vero, e credo di averne chiarito il meccanismo, che la passione del reale si accompagna a una proliferazione della finzione, e che quindi occorre ricominciare sempre daccapo l’epurazione, la messa a nudo del reale.
Quello che oggi vorrei sottolineare, è che epurare il reale significa estrarlo dalla realtà che lo avviluppa e lo occulta. Da cui il gusto violento della superficie e della trasparenza. Il secolo tenta di reagire contro la profondità. Instaura felicemente una forte critica del fondamento e dell’aldilà, promuove l’immediato e la superficie sensibile. Propone, sulla linea di Nietzsche, di abbandonare i “retro- mondi” e di stabilire che il reale è identico all’apparire. Il pensiero, proprio perché ciò che lo anima non è l’ideale ma il reale, deve cogliere l’apparire come apparire, o il reale come evento puro del suo apparire. Per arrivare a ciò occorre distruggere ogni spessore, ogni pretesa sostanziale, ogni asserzione di realtà. È la realtà che fa ostacolo alla scoperta del reale come superficie pura. In ciò consiste la lotta contro la finzione. Ma poiché la finzione-di-realtà aderisce al reale, la distruzione della finzione si identifica con la distruzione pura e semplice. Alla fine della sua epurazione, il reale come assenza totale di realtà è il nulla. Tale via, imboccata durante il secolo attraverso innumerevoli tentativi politici, artistici e scientifici, verrà chiamata la via del nichilismo terrorista. Poiché la sua animazione soggettiva è la passione del reale, non si tratta di un consenso al niente, ma di una creazione, e conviene riconoscervi un nichilismo attivo.
A che punto siamo oggi? La figura del nichilismo attivo è considerata completamente obsoleta. Ogni attività ragionevole è limitata, limitativa, ristretta dal peso della realtà. La cosa migliore da fare è quella di evitare il male, e la via più breve per arrivarci è di evitare ogni contatto con il reale. In sostanza, si ritrova il nulla, il nulla-di-reale e, in questo senso, si è sempre nel nichilismo. Ma poiché si è soppresso l’elemento terrorista – il desiderio di epurare il reale -, il nichilismo è disattivato. E diventato nichilismo passivo, o reattivo, vale a dire ostile a ogni azione come a ogni pensiero.
L’altra via abbozzata dal secolo, quella che tenta di mantenere la passione del reale senza cedere al fascino parossistico del terrore, l’ho definita, come già sapete, la via sottrattiva: esibire come punto reale non la distruzione della realtà, ma la differenza minima. Epurare la realtà non per annientarla nella sua superficie, ma sottraendola alla sua apparente unità per scoprirvi la differenza minuscola, il termine evanescente che ne è costitutivo. Ciò che ha luogo differisce appena dal luogo in cui ciò ha luogo. L’affetto sta tutto nell’”appena”, in questa eccezione immanente.
In entrambe le vie, la questione cruciale è quella del nuovo. Che cos’è il nuovo? Una questione che ossessiona il secolo visto che, fin dai suoi albori, il secolo si è posto come figura dell’inizio. E, innanzitutto, come (re-)inizio dell’Uomo: l’uomo nuovo.
Questo sintagma ha due sensi opposti.
Per tutta una serie di pensatori, soprattutto dalle parti del pensiero fascista e senza eccettuare Heidegger, “l’uomo nuovo” è in parte la restituzione di un uomo antico, obliterato, scomparso, corrotto. L’epurazione è in realtà un più o meno violento processo di ritorno di un’origine svanita. Il nuovo è una produzione di autenticità. In sostanza, il compito del secolo è la restituzione (dell’origine) attraverso la distruzione (dell’inautentico).
Per un’altra serie di pensatori, in particolare dalle parti del comunismo marxistizzante, l’uomo nuovo è una reale creazione, qualcosa che non è mai esistito, in quanto sorge dalla distruzione degli antagonismi storici. E al di là delle classi e dello stato.
L’uomo nuovo è sia restituito, sia prodotto.
Nel primo caso, la definizione dell’uomo nuovo si radica in totalità mitiche quali la razza, la nazione, la terra, il sangue, il suolo. L’uomo nuovo è una collezione di predicati (nordico, ariano, guerriero ecc.).
Nel secondo caso, invece, l’uomo nuovo si declina contro tutti gli avviluppamenti e tutti i predicati, in particolare contro la famiglia, la proprietà, lo stato-nazione. È il programma del libro di Engels L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Marx sottolineava già che la singolarità universale del proletariato è di non portare alcun predicato, di non avere niente e, in particolare, di non avere, in senso forte, alcuna “patria”. Tale concezione antipredicativa, negativa e universale dell’uomo nuovo attraversa il secolo. Un punto molto importante è l’ostilità verso la famiglia, come nucleo primordiale dell’egoismo, del radicamento particolare, della tradizione e dell’origine. Il grido di Gide: “Famiglie, vi odio”, partecipa dell’apologetica dell’uomo nuovo così concepito.
Colpisce molto il vedere che, in questa fine secolo, la famiglia è ridiventata un valore consensuale e praticamente tabù. I giovani adorano la famiglia, in seno alla quale si attardano peraltro sempre più a lungo. Il partito tedesco dei Verdi, considerato contestatario (ma tutto è relativo, vista la sua presenza al governo…), voleva a un certo punto autodefinirsi il “partito della famiglia”. Perfino gli omosessuali, portatori nel secolo, come lo si è visto con Gide, di una parte della contestazione, oggi reclamano il loro inserimento nel quadro familiare, nell’eredità, nella “cittadinanza”. Questo per dire il punto a cui siamo. Quando si era progressisti, essere un uomo nuovo, nel presente reale del secolo, significava innanzitutto sfuggire alla famiglia, alla proprietà, al dispotismo di stato. Oggi sembra che la “modernizzazione”, come si compiacciono di dire i nostri maestri, sia quella di essere un buon papà, una buona mamma, un buon figlio, diventare un dirigente competitivo, arricchirsi il più possibile e giocare al cittadino responsabile. Adesso lo slogan è: “Denaro, Famiglia, Elezioni”.
In effetti il secolo si chiude sul tema della novità soggettiva impossibile e del conforto della ripetizione, tema appartenente alla categoria dell’ossessione. Il secolo si chiude nell’ossessione garantista, all’insegna della massima, alquanto abietta, del: “Non si sta poi così male: da altre parti c’è e c’è stato ben di peggio”. Mentre, a partire da Freud, la sostanza di questi cent’anni si era posta sotto il segno dell’isterismo devastatore: che avete di nuovo da farci vedere? Di che cosa siete creatori?
Ecco perché sarà bene addentrarsi nel secolo anche attraverso la psicoanalisi.
Note
1 Dato che, trattandosi della rivoluzione culturale, tutto viene dimenticato o coperto dal giornalismo calunniatore, bisogna risalire a fonti che siano contemporanee all’evento, ma anche imparziali e ponderate. Un libro che consente di farsi un’idea sintetica del periodo iniziale (l’unico che contenga insegnamenti universali) di ciò che i cinesi chiamarono allora la Grande rivoluzione culturale proletaria (in breve, la GRCP) è quello di Jean Esmein, La Revolution culturelle, Seuil, Paris 1970 (Storia della rivoluzione culturale cinese, tr. it. di Giovanni Ferrara, Laterza, Roma-Bari 1971).
2 II principale organizzatore della sinologia antimaoista, peraltro persona di talento, è Simon Leys che nel 1971, all’apice della popolarità intellettuale della rivoluzione culturale, fece scoppiare una bomba iconoclasta con il suo saggio Les habits neufs du président Mao (Champ Libre, Paris). Il fatto che Simon Leys sia onorato come avanguardia coraggiosa dello spirito rinnegato e controrivoluzionario rende certo giustizia al suo coraggio d’opinione (di cui i suoi seguaci, tutti maoisti pentiti, non fecero mai prova: né allora, quando “tutti”, loro compresi, erano maoisti, né oggi che questi “tutti” sono dal primo all’ultimo dei pentiti, come non mancano di dichiarare), ma non può convincerci che i suoi libri siano buoni. Il lettore li legga e giudichi di persona.
https://www.sinistrainrete.info/teoria/17177-alain-badiou-uno-si-divide-in-due.html
Non ci sono intellettuali
Francesco Erspamer 16 02 2020
La crisi del nostro tempo deriva in gran parte dal fatto che non ci sono intellettuali che abbiano il coraggio e la lucidità di chiamarla tale: crisi, decadenza. Tutti troppo ansiosi di compiacere i ricchi e i potenti, che hanno interesse a far credere che vada tutto benissimo (e per loro effettivamente va tutto benissimo), o magari di piacere alla gente ordinaria, milioni di individui incapaci di sentirsi parte di qualcosa più grande e duraturo di loro – un popolo, una comunità, una famiglia, una nazione, una religione, una civiltà, una cultura, un partito – e dunque disperatamente in cerca di conferme che l’attualità che stanno vivendo abbia senso e sia la migliore possibile. A questo servono ormai gli intellettuali: a vendere il presente e in modo divertente, intrattenente, se no gli altri, ricchi e poveri, si annoiano e neanche li stanno a sentire. E allora gli intellettuali si deprimono, si sentono inutili, soli, perdono fiducia in sé stessi e nelle proprie idee: come all’inizio degli anni novanta, quando di fronte alla sconfitta del comunismo, in cui avevano creduto, invece di serrare le fila e di organizzare una resistenza contro il più pervasivo e distruttivo regime della Storia, si convertirono in massa e istantaneamente alla fede liberal e liberista, ottenendo in cambio visibilità nei talk show e sui giornali e di conseguenza le prebende che la società dello spettacolo assicura alle celebrity.
Hanno anche paura di mostrarsi pessimisti, in un mondo in cui, a imitazione degli Stati Uniti, l’ottimismo euforico e giovanilistico è obbligatorio mentre dubitare nelle magnifiche sorti e progressive e nel destino manifesto della crescita economica e civile è politicamente scorretto.
Invece il compito degli intellettuali è quello di dire verità scomode e non di moda: e se ricevono pochi “mi piace”, tanto meglio, vuol dire che erano opportune. Perché il punto non è persuadere la gente a salvare il mondo: il punto è offrire alla gente la possibilità di prendere coscienza, ma se non la vuole, perché troppo distratta, superficiale, insicura o semplicemente in disaccordo, cazzi suoi, chi non vuole salvarsi non va salvato e non si salverà – i miracoli succedono solo nelle favole.
Quando a mia volta sono sfiduciato o stanco, rileggo alcuni autori a me cari: Machiavelli, Leopardi, Gramsci, Pasolini. Ma anche Petrarca, un grande italiano che gli italiani ignorano, preferendogli autori stranieri più pubblicizzati. Per esempio la sua lettera “de mutatione temporum”, uno straordinario manifesto del coraggio dell’inattualità, oggi introvabile in libreria. Ecco l’inizio: “So che mi verrà contrapposta quella frase di Orazio che, parlando del comportamento dei vecchi, li chiama queruli, incontentabili e lodatori del tempo della loro giovinezza. Ma per quanto io a volte rimpianga e lodi i tempi antichi, sono fondate sulla verità sia la mia lode del passato che la mia critica del presente”. Sono poche pagine, ve le consiglio.
https://www.facebook.com/frerspamer?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAAv24UmUR5fe9fANl5nDsrjhRL1ALMIabH35sX6847X39jvApJVoeEXwl7eWDc0DOSaEdEhxiaBoTr&hc_ref=ARQwo_3QE2fFi3kAacHCrS4qezlsEx_nLU1suwzZpRb8OStBmccV6ZvFXl-kh4SABjo&fref=nf
CYBERWAR SPIONAGGIO INFORMAZIONE DISINFORMAZIONE
Bruno Vespa contro le Ong?
Esposto della Rai contro di lui: “Roba da regime sovietico”, è guerra
25 marzo 2020
Bruno Vespa. fa ancora discutere. Nei suoi confronti è partito “un doppio esposto, al Comitato per il Codice etico della Rai e al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio” presentato dal consigliere di amministrazione della Rai, Riccardo Laganà, e dal segretario dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani. “La richiesta – spiegano in una nota – è quella di valutare, ciascuno per le proprie competenze, profili disciplinari e deontologici rispetto alle accuse rivolte da Vespa nei confronti della ong Medici Senza Frontiere, seccamente smentite dai diretti interessati. Questo fatto – sottolineano – ha esposto la Rai a rischi di immagine da parte di un proprio collaboratore. Inoltre, nei giorni precedenti, Vespa ha rivolto gravi accuse nei confronti del proprio datore di lavoro, accusandolo di aver sospeso la sua trasmissione (Porta a Porta ndr) ‘senza un motivo ragionevole’ ipotizzando una decisione dal ‘sapore politico’”.
Una scelta che ha immediatamente visto la replica del diretto interessato che, durissimo, ha ribadito: “Il consigliere Laganà e il segretario dell’Usigrai Di Trapani stanno programmando un sistema di censura sovietico, ma non ce la faranno” ha chiosato più definitivo che mai.
FONTE:https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/21615389/bruno_vespa_doppio_esposto_rai_infondate_accuse_datore_lavoro_ong_msf.html
Il provvedimento sulle intercettazioni è legge
La Camera ha approvato definitivamente e con voto segreto il decreto legge. Ecco le novità
28 febbraio 2020
Caro lettore, se sei arrivato fin qui seguendo un messaggio allarmistico, devi sapere che questo articolo non ha alcun collegamento con quanto hai letto poco prima. Questo è un servizio di cronaca politica del 28 febbraio scorso che riporta correttamente quanto deciso dal Parlamento italiano in materia di intercettazioni. Questo articolo è vero, quello che hai letto prima è falso.
La Camera ha approvato definitivamente e con voto segreto il decreto legge sulle intercettazioni. Con 246 sì e 169 no, il provvedimento è legge. Ma cosa prevede? Norme più rigide a tutela della privacy: sarà il Pm – e poi il Gip – a decidere sulla rilevanza delle intercettazioni; l’utilizzo dei trojan sarà consentito anche per gli ‘incaricato di pubblico servizio’ e fin dentro le mura di casa, ma dovrà essere motivato e giustificato; divieto di pubblicazione degli ‘ascolti’ irrilevanti.
Sono alcune tra le novità introdotte nel decreto intercettazioni il cui testo ha subito diverse modifiche, in un percorso non privo di ostacoli. Non sono mancati momenti di tensione all’interno della maggioranza, con vertici e trattative che hanno portato i giallorossi a trovare solo all’ultimo momento un punto di mediazione.
DIVIETO PUBBLICAZIONE PER INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI: giro di vite sulla diffusione delle telefonate. Il decreto introduce una più chiara disciplina del trattamento giuridico a cui vengono sottoposte le intercettazioni cosiddette ‘irrilevanti’, rispetto agli ‘ascolti’ rilevanti. Le intercettazioni irrilevanti sono coperte dal segreto, quindi non saranno mai pubblicabili. Quelle rilevanti, invece, essendo inserite nel fascicolo, saranno pubbliche e quindi possono essere diffuse.
SU RILEVANZA DECIDE PM (E POI GIP): la valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni viene rimessa al pubblico ministero e, poi, al giudice per le indagini preliminari. Sarà dunque il pm – e non la polizia giudiziaria come previsto dalla precedente riforma Orlando – a dover selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini e quelle, invece, irrilevanti.
STRETTA SU PRIVACY: il pubblico ministero dovrà vigilare affinche’ nella trascrizione delle intercettazioni non siano riportate espressioni ‘sensibili’. La norma vale anche per le intercettazioni rilevanti, che dovranno essere depurate dai cosiddetti ‘dati sensibili’.
INTERCETTAZIONI E ‘REATI DIVERSI’: le intercettazioni si potranno utilizzare come prova di reati diversi rispetto a quelli per cui erano state disposte solo se “rilevanti e indispensabili” per l’accertamento del reato. E, comunque, solo per quei reati intercettabili.
TROJAN: è una delle norme che piu’ ha suscitato le critiche delle opposizioni. I captatori informatici sono equiparati alle intercettazioni ambientali e viene introdotto l’obbligo di motivazione ulteriore che ne giustifichi l’utilizzo. Tuttavia, sarà possibile utilizzare i trojan non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche per quelli commessi dagli ‘incaricati di pubblico servizio’, purché si tratti di reati punibili con la reclusione oltre i 5 anni. Inoltre, l’intercettazione attraverso captatore, come avviene nel caso di reati che coinvolgono pubblici ufficiali, potrà avvenire anche dentro le mura di casa.
FONTE:https://www.agi.it/politica/news/2020-02-28/intercettazioni-legge-novita-7247955/
ECONOMIA
La fantaeconomia anticipa la realtà?
Pubblicato il 3 Aprile 2015 · in Segnalazioni ·
di Gian Filippo Pizzo
Il Prezzo del Futuro [Quella che pubblichiamo è l’introduzione a AA. VV., Il prezzo del futuro, a cura di Vittorio Catani e Gian Filippo Pizzo, La Ponga edizioni, 2015, € 16,90).

Non ha avuto molta fortuna il termine “fantaeconomia”, usato per indicare un sottogenere della fantascienza (come fantapolitica, fantastoria, fantabiologia, eccetera). In effetti lo si ritrova più spesso negli articoli sui quotidiani, per confutare le tesi economiche espresse da qualche ministro esperto in “finanza creativa” o da altri uomini politici. Il motivo di ciò è banale: la fantaeconomia è un argomento molto ma molto marginale rispetto alla massa della produzione fantascientifica. Passa quindi inosservato, anche perché le ipotesi immaginarie sull’economia del nostro futuro si trovano spesso all’interno del genere utopico o di quello sociale, e l’attenzione dell’autore e dei lettori si concentra di più su altri aspetti quali la struttura politica, la morale, l’organizzazione della società. Inoltre, come vedremo, molta produzione classificata come fantaeconomia è in realtà più vicina alla satira politica da una parte e alla narrativa di spionaggio dall’altra, piuttosto che alla fantascienza.
L’espressione “fantaeconomia” ha comunque una origine ben precisa: fu coniata nella seconda metà degli anni Settanta per etichettare un romanzo di un certo successo, I soldi in Paradiso (Rizzoli 1976). L’autore di questo libro era presentato come “Anonimo” (si saprà più tardi che si trattava del giornalista fiorentino del “Corriere della Sera” Gianfranco Piazzesi) e aveva avuto pochi anni prima un enorme successo con un altro romanzo satirico, Berlinguer e il Professore (Rizzoli 1974), che fu classificato di fantapolitica perché raccontava come in Italia si sarebbe arrivati al “compromesso storico” tra il segretario del Partito Comunista e quello della Democrazia Cristiana Amintore Fanfani (il “Professore” del titolo). I soldi in Paradiso aveva come protagonista il presidente della FIAT Gianni Agnelli e metteva alla berlina gli intrecci politico-finanziari della maggiore industria italiana.
Questo filone narrativo ebbe in quegli anni un certo successo e altri libri furono definiti con la stessa etichetta. Per esempio Greggio e pericoloso (Mondadori 1976) di Roberto Vacca, che prendeva spunto dalla coeva crisi petrolifera e cercava di immaginare come i paesi industrializzati avrebbero potuto condizionare quelli produttori di petrolio in modo da avere sempre la disponibilità dell’“oro nero” a prezzi ragionevoli (come dimostra la storia recentissima, il problema è senza soluzione). Se questo romanzo, come dicevamo sopra, è maggiormente vicino alla spy-story che alla fantascienza, è più fantascientifico il successivo, dello stesso Vacca: La suprema Pokazuka (Sugar 1980), che raccontava la “vera” storia della Rivoluzione Russa d’Ottobre, spiegando come un paese quale l’Unione Sovietica restasse povero nonostante la grande disponibilità di risorse naturali, mentre un paese privo di risorse come la Svizzera fosse ricchissimo. Roberto Vacca è noto come futurologo e il suo approccio, più che squisitamente economico, è globale, basato sulla storia e sull’analisi del presente in tutti i campi: ciò nulla toglie alla validità dei suoi romanzi, sempre scorrevoli e appassionanti.
Ancora in quegli anni, un certo successo mondiale lo ottenne anche Paul Erdman, un economista di professione che aveva ben presente lo scenario che doveva considerare. Il suo romanzo Il crack del ’79 (Rizzoli 1976) prendeva sempre spunto dalla crisi petrolifera degli anni Settanta e si proiettava solo di un triennio avanti nel tempo per mostrare i risultati catastrofici di quella crisi. Per fortuna gli scrittori dell’immaginario non sono profeti, ma si limitano a speculare sulla realtà contemporanea soprattutto a scopo didattico: cioè per mettere in guardia l’umanità dal proseguire secondo una certa tendenza. Erdman ha continuato in tal senso la sua attività narrativa e nel corso degli anni ci ha dato altri romanzi, speculativi ma sempre basati su premesse concrete: Gli ultimi giorni dell’America (Rizzoli) nel 1981, Il panico dell’89 (Mondadori, 1986), che è una specie di remake letterario del primo romanzo, e Zero coupon nel 1992. Quest’ultimo sarebbe arrivato in Italia solo nel 2003, pubblicato non a caso da “Il Sole 24 ore” (nella collana di gialli edita dal nostro maggiore quotidiano finanziario, a ulteriore dimostrazione del fatto che la fantaeconomia è meno fantascientifica di quanto si possa credere). Sulla stessa linea si muove un romanzo più recente, Il gioco estremo, di Adriano Casassa (Fanucci 2008), che ben mostra le relazioni internazionali tra economia, finanza, gioco politico, servizi segreti, gruppi terroristici, governi corrotti e nazionalità in rivolta; come Erdman, anche Casassa è un economista di professione (anche se ha abbandonato l’attività finanziaria per gestire un ristorante a Barcellona) che conosce la materia di cui parla, pur se trasformata dalla finzione narrativa.
Abbiamo parlato finora di scrittori che non sono specialisti della science fiction: questi ultimi in genere non hanno dato molta enfasi all’aspetto economico. Nei romanzi e nei film vediamo i personaggi pagare regolarmente con carte di credito (anzi, l’unità monetaria si chiama spesso “credit”) o con altri sistemi ancora più futuristici (a volte basta comunicare verbalmente il proprio nome al robot o al computer di turno, perché l’importo relativo al pagamento venga scalato dal conto corrente, come succede in molte opere di Philip Dick), ma non ci viene spiegato come il reddito venga prodotto, come la ricchezza sia ridistribuita, quale sia l’incidenza delle tasse, insomma tutte le piccole questioni che assillano noi cittadini. C’è qualche eccezione, marginale e per nulla significativa: per esempio nel romanzo La società Amaranto di Jack Vance (Editrice Nord) i pagamenti avvengono con gettoni colorati, e ogni colore consente di pagare certi prodotti e non altri (chissà perché, la social card istituita qualche anno fa dal nostro Governo ci ha ricordato questa idea). In genere si tratta di particolari inseriti nel testo solo per arricchire la narrazione con dettagli curiosi o folkloristici (come nel caso citato), ma non c’è nessuna vera spiegazione di come l’economia sia organizzata nel mondo futuro descritto dai fantascrittori.
Tra le eccezioni più rilevanti ci sono sicuramente alcune opere di Robert Sheckley e del duo Pohl & Kornbluth, anche se il loro lavoro non è direttamente sull’economia ma su alcuni suoi aspetti, quali la pubblicità, il consumismo, il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, la mercificazione, il potere dei media, e quindi gioca più sul “sociale”. In ogni caso, se pur vecchie di almeno mezzo secolo, queste opere conservano una loro vitalità e la loro lettura può ancora oggi essere illuminante per comprendere come il potere economico possa condizionare le masse. In particolare segnaliamo, i romanzi I mercanti dello spazio e Gladiatore in legge, del duo Pohl-Kornbluth, e i racconti “Le ragioni di Rafferty” e “Buon compleanno caro Gesù”, oltre a Il morbo di Mida e Il tunnel sotto il mondo del solo Frederik Pohl; e “Il costo della vita” di Robert Sheckley. Da ricordare anche “Il boom delle bovine” di Damon Knight e “Pioggia di stringhe” di Lloyd Biggle jr., entrambe molto ironiche. Queste opere sono apparse quasi tutte negli anni Cinquanta sulla rivista “Galaxy”, rimasta famosa per ospitare storie dal taglio satirico e estremamente critiche nei riguardi della società, ivi compreso quindi l’aspetto economico. Nella fantascienza degli ultimi tempi, talora viene sfiorato – ma non più di tanto – il tema dell’economia o della finanza, e d’altronde oggi non è più possibile ignorarlo. Accade per esempio in alcune storie di autori emersi più di recente, quali Greg Egan o Charles Stross.
La principale eccezione è costituita da Mack Reynolds, uno scrittore spesso non particolarmente profondo, ma in grado di costruire narrazioni ben architettate e piacevolissime da leggere, che a volte si elevano sopra lo standard, rivelandosi impegnate e valide. Autore molto prolifico, aveva iniziato la sua carriera come giornalista economico ed era membro attivo del Partito Socialista Americano, quindi le sue storie avevano sempre un sottofondo sociale progressista con particolare riguardo all’aspetto economico. Aspetti che, sebbene presenti in svariate opere (i romanzi Vacanze a Satellite City, Genoa-Texcoco: zero a zero, Le comuni del 2000, Ed Egli maledisse lo scandalo, considerato il suo capolavoro) trovano la migliore espressione nei racconti Interesse composto (come arricchirsi con gli interessi viaggiando nel tempo!) e soprattutto La congiuntura, quest’ultimo ampliato a romanzo con il titolo Effetto valanga, ripubblicato poi da Delosbooks, e addirittura ampiamente citato da Milena Gabanelli in una puntata della trasmissione televisiva di RaiTre “Report” (novembre 2011) basata sull’attuale crisi. Riassumiamo in poche parole la trama del romanzo: nell’America ultraconsumistica dell’immediato futuro (grosso modo ai tempi nostri, visto che la prima stesura del racconto è del 1968) Marvin Sellers si rende conto che non può pagare le rate del nuovo frigorifero che ha ordinato: quello vecchio funziona benissimo, e non c’è motivo reale di cambiarlo con uno più moderno. Lo rimanda quindi indietro, ma ciò costringe il proprietario del negozio di elettrodomestici – che a sua volta non naviga in buone acque – a rinunciare all’acquisto della terza automobile; a sua volta il concessionario auto decide di fare a meno di una nuova casa, e questo provoca il licenziamento di alcuni dipendenti della società edile… Si innesca quindi un “effetto domino” che nel giro di pochi mesi arriva a mettere in ginocchio l’economia americana e poi a rischio quella mondiale. Un meccanismo, in sostanza, simile a quello delle “bolle speculative” di cui ormai ben sappiamo. Nel finale, il problema verrà risolto in modo brillante ma paradossale tramite lo stesso Marvin Sellers.
Per l’economia reale non sarà così semplice…
Poscritto
Tra la stesura di questa introduzione e la pubblicazione della relativa antologia è passato del tempo e nel frattempo sono apparsi un paio di libri che avrei potuto citare (se mi fosse venuto in mente di rivederla).
Uno è Crisis, a cura di Alberto Cola e Francesco Troccoli (Edizioni della Vigna, 2013), l’altro Terra promessa, a cura del sottoscritto (Tabula fati, 2014); in entrambi sono presenti alcuni degli autori che appaiono anche ne Il prezzo del futuro. Nessuno dei due, per la verità, ha il taglio ampio di quest’ultima, che vorrebbe affrontare nel complesso il tema dell’economia futura, ma non è colpa nostra se l’economia è in questi anni un elemento molto negativo e dunque i racconti siano molto problematici! Crisis, come denunciato dal titolo, si occupa della crisi che stiamo vivendo, dovuta all’immigrazione, alle politiche sociali, alla globalizzazione, e ovviamente anche all’economia (che poi è il motore di tutto) quindi una citazione ci sta. Terra promessa, che come sottotiolo recita Racconti di fantadecrescita, affronta un problema particolare dell’economia con importanti risvolti nel campo dell’ecologia, dell’ambiente e della qualità della vita – aspetti questi che sono in primo piano nelle tesi degli autori – cioè quello della “decrescita felice” teorizzata tra gli altri da Serge Latouche, e anche qui pur essendo il tema economico più secondario (ma, ripeto, è questo all’origine di tutto il resto) la citazione è doverosa.
Fonte:https://www.carmillaonline.com/2015/04/03/la-fantaeconomia-anticipa-la-realta/
I trogloditi del pareggio di bilancio, cavalieri della catastrofe
Scritto il 26/3/20
Una mozione d’ordine, anche se inutile. Un lettore ha commentato così la proposta (che ho riportato) da Bagnai e Molinari di cancellare l’obbligo di pareggio di bilancio nella Costituzione: «Il pareggio è una regola di buon senso soprattutto per un paese sull’orlo del baratro. Lei, Blondet, dovrebbe studiare un po’ di economia». Ora, questo signore essendo un abisso di ignoranza, ignora che mi sono occupato professionalmente di economia su “Il Giornale” quando lo dirigeva Montanelli, e ho scritto sui pericoli della globalizzazione un saggio, “Schiavi delle banche”. Ma se questo può essere perdonabile, perché si tratta di cose di oltre un decennio fa e il neo-primitivo vive nel presente totale, meno perdonabile è che l’ignorante ignori gli articoli di tema economico che scrivo sul blog. E anzitutto quello che ho scritto, freschissimo, su come Boris Johnson affronta il blocco economico da coronavirus: assicurando l’80 per cento del salario ad ogni dipendente d’azienda, e il sussidio malattia ad ogni lavoratore autonomo, e ciò sull’unghia (la gente ha già cominciato a vedere i soldi accreditati sul proprio conto), incurante del “pareggio di bilancio” e accettando di far aumentare il suo debito pubblico di un 20-30%.
Ciò non solo perché ha una banca centrale e la sua valuta (al contrario di noi schiavi dell’euro tedesco), ma perché è noto – a chi non è ignorante – che le ricostruzioni dopo le guerre mondiali sono avvenute proprio così, spendendo al di là del pareggio, Montifacendo grossi deficit e grossi debiti pubblici – sapendo che poi la ripresa economica, conseguente a queste misure, avrebbe permesso di chiudere, diminuire il debito pubblico. All’ignorante ho risposto, sotto il suo commento, con questo testo: nel 2011, i premi Nobel Kenneth Arrow, Peter Diamond, William Sharpe, Eric Maskin e Robert Solow, in un appello rivolto al presidente Obama, hanno affermato che «inserire nella Costituzione il vincolo di pareggio del bilancio rappresenterebbe una scelta politica estremamente improvvida. Aggiungere ulteriori restrizioni, quale un tetto rigido della spesa pubblica, non farebbe che peggiorare le cose»; soprattutto, «avrebbe effetti perversi in caso di recessione. Nei momenti di difficoltà diminuisce il gettito fiscale e aumentano alcune spese tra cui i sussidi di disoccupazione. Questi ammortizzatori sociali fanno aumentare il deficit, ma limitano la contrazione del reddito disponibile e del potere d’acquisto».
Nell’attuale fase dell’economia, aggiungevano i Nobel, «è pericoloso tentare di riportare il bilancio in pareggio troppo rapidamente. I grossi tagli di spesa e/o gli incrementi della pressione fiscale necessari per raggiungere questo scopo danneggerebbero una ripresa economica già di per sé debole». Ma inoltre, «anche nei periodi di espansione dell’economia, un tetto rigido di spesa potrebbe danneggiare la crescita economica, perché gli incrementi degli investimenti a elevata remunerazione – anche quelli interamente finanziati dall’aumento del gettito – sarebbero ritenuti incostituzionali se non controbilanciati da riduzioni della spesa di pari importo. Un tetto vincolante di spesa, poi, comporterebbe la necessità, in caso di spese di emergenza (per esempio in caso di disastri naturali), di tagliare altri capitoli del bilancio pubblico mettendo in Krugmanpericolo il finanziamento dei programmi non di emergenza». Critico anche l’economista e premio Nobel Paul Krugman, il quale ritiene che l’inserimento in Costituzione del vincolo di pareggio del bilancio «possa portare alla dissoluzione del Welfare State» (che è proprio lo scopo perseguito dagli “europeisti”).
La fonte di questo testo? Forse un trattato che ho nella biblioteca? No, è la voce di Wikipedia. Quindi qualcosa di accessibile anche all’ignorantissimo. Ma questo non è il peggio. Quello che nel suo commento l’ignorante rivela, è di essere neo-primitivo. Ossia di far parte di una massa enorme, e purtroppo imperante, decisiva in Italia per come vota. Chi è il neo-primitivo? Colui che, come l’uomo del dodicesimo secolo, o il tribale del Mato Grosso, vive di certezze dogmatiche. Non ha capacità di pensiero critico, e riceve queste certezze da “fuori”, da quelle che crede “autorità”. Esattamente come il contadino medievale, che credeva ai dogmi cristiani. Invece il neo-primitivo crede nella Scienza. E nella Tv da cui la riceve. La Scienza con la maiuscola. La Scienza in cui non distingue se sia chimica, fisica, farmaceutica, virologia, economia e sociologia o la fantomatica “Scienza delle Comunicazioni”: tutto è Scienza e degno della sua fede assoluta e indiscussa.
Nel caso qui esposto, l’ignorante – essendo anche neoprimitivo – crede che il Pareggio di Bilancio sia un dogma scientificamente provato. Per cui, vieta che se ne discuta. Ignora lo stato della questione nel campo scientifico. Ignora che il dogma è messo in discussione da manciate di Premi Nobel, con argomenti perfettamente comprensibili (a chi sia capace di pensare un minimo). E che la discussione, non affatto segreta, è facilmente reperibile persino su Wikipedia. Il neo-primitivo ignora che la scienza (senza maiuscola, e ammesso che l’economia sia scienza) è essenzialmente “discussione” delle certezze, tentativo di non stare ai dogmi, superamento di essi. No. L’ignorante essendo neo-primitivo, fa della Scienza un insieme di dogmi. Ad essi confida tutta la sua “fede”, esattamente come il contadino del medioevo aveva fede nei dogmi cristiani e nel sangue di San Gennaro. Ma per di più, crede di essere moderno – invece è al corrente di qualche punto superato della Scienza – e quindi, imperiosamente, impone il suo non-sapere a chi sa più di lui. «Blondet, lei dovrebbe studiare un po di economia», dice il saputello. E mi è andata ancora bene: non mi ha segnalato alla psicopolizia per il trattamento di rieducazione o Tso.
Ma nella dittatura perfetta della Scienza dogmatica che si sta instaurando, le torme di neoprimitivi accenderanno i roghi per chi mette in discussione il Pareggio di Bilancio e tutti i altri dogmi in corso, infurianti con la scusa della lotta “scientifica” al coronavirus. La restrizione delle libertà politiche, così palesemente in corso, ha il neo-primitivo come entusiasta promotore; i poteri occulti sanno di poter contare sulle masse neo-primitive per bollare i critici e dissidenti rispetto al Sistema, e punirli – togliere loro il voto, e magari la vita. E per far arretrare il livello di civiltà, di cultura, di intelligenza dei popoli occidentali, che è il loro scopo reale, servono appunto i neo-primitivi, adepti di qualche dogma superato e arretrato, non più vigente nel Blondetdibattito scientifico reale. Un caso plateale di primitivismo s’è concluso tragicamente in Arizona: due anziani coniugi, letto che la clorochina è raccomandata e usata per contrastare gli effetti peggiori del coronavirus nei ricoverati, s’è somministrata dosi di fosfato di clorochina: un composto chimico in libera vendita, perché è un additivo che serve a pulire gli acquari e le piscine.
A trarre i due nel tragico inganno è la loro credenza “scientifica” che il termine “clorochina” indichi in tutti i casi la stessa realtà: purtroppo, la clorochina farmaco è “idrossido di clorochina”; una formulazione del tutto diversa dal lava-acquari, e un medicinale usato da 50 anni come anti-malarico. I due sono morti. E qui si vede la differenza fra i neo-primitivi americani e quello italiano, a tutto vantaggio dei primi: il primitivo americano si avvelena da sé, privatamente; e non pretende – come quello italiano – di partecipare al dibattito pubblico su temi di cui ignora tutto, anzi peggio, di voler far prevalere imperativamente nel dibattito pubblico le sue vedute arretrate e dogmatiche come nel caso del commentatore, la su ignoranza come superiore certezza. Il neo-primitivo italiano ha votato Pd e 5 Stelle, il movimento creato da un noto neo-primitivo che promuove la decrescita come dogma scientifico… Il neoprimitivo italiano avvelena anche te. Ma dirgli di smettere è inutile: ritorna sempre, e in massa.
(Maurizio Blondet, “Il pericolo del neo-primitivo scientifico”, dal blog di Blondet del 25 marzo 2020).
Articoli collegati
La via italiana all’epidemia: chi andrebbe isolato è Conte
Galloni: il virus smaschera il rigore. Ma come affrontarlo?
Magaldi: ma Conte dovrà pagare, per aver rovinato l’Italia
Mes e virus, Guzzi: orrore, questa umanità deve insorgere
Il Mes e i Miserabili: come siamo caduti in basso, e perché
https://www.libreidee.org/2020/03/i-trogloditi-del-pareggio-di-bilancio-cavalieri-della-catastrofe/
PANORAMA INTERNAZIONALE
Christine La “gaffe” (!?!)
di Carlo Formenti
La prima pagina del Corriere del 13 marzo dedica alla cosiddetta “gaffe” della presidente della BCE, Christine Lagarde, uno spazio assai più contenuto di quello di altri quotidiani nazionali, a ulteriore conferma della sua linea Europa uber alles. Tuttavia, dal momento che l’uscita della cinica rappresentante degli interessi della finanza globale è stata di portata tale da suscitare, oltre a pesanti effetti depressivi sulle borse, reazioni stizzite persino da parte del tremebondo Mazzarella e del dirigente della Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, il quotidiano milanese non ha potuto esimersi dal dedicare due pagine (la 8 e la 9) alla scandalosa battuta della segaligna Lagarde (“Non siamo qui per chiudere gli spread”). Così come ha indotto il pur inossidabile europeista Federico Fubini – nel taglio basso di pagina 8 – a farsi scappare alcune verità ormai troppo evidenti per essere ignorate.
Non si è trattato di una gaffe, spiega Fubini, bensì dell’imbarazzante ammissione di quali interessi guidino certe scelte: non a caso quelle parole ricalcano alla lettera una frase di Isabel Schnabel, rappresentante tedesca nel comitato Bce; non impreparazione o lapsus dunque, bensì rigorosa applicazione dei dettami della Bundesbank. La battuta in questione rivela l’auspicio che l’Italia, in odore di recessione a causa dell’epidemia, sia prima o poi obbligata a chiedere un “salvataggio” dalla Ue, avviandosi a subire il destino della Grecia (anche se questo, naturalmente, Fubini si astiene dall’esplicitarlo). Mentre la stizza della Confindustria è un sintomo evidente della paura che la Germania (e in misura minore la Francia) colgano l’occasione per arraffare altre fette del nostro apparato produttivo e dei nostri mercati, riducendo definitivamente l’Italia allo status di semicolonia degli “imperi centrali” (a tale proposito ricordo che il direttore del Sole24Ore, qualche giorno fa, si è spinto ad affermare che se l’Europa insiste a comportarsi in un certo modo, “è giusto che l’Italia vada per conto suo”).
https://www.sinistrainrete.info/europa/17203-carlo-formenti-christine-la-gaffe.html
30 milioni morti per malaria
Nino Galloni 19 03 2020 WhatsApp ore 19.39
Signori riflettiamo anche su questo ….ora tutti gli stati si stanno allertando e stanno decretando provvedimenti eccezionali perché la vita umana e ‘più importante di qualunque altra cosa cioè più dell ‘economia , della produzione ecc ecc e siamo d’accordo ma la vita umana è indissolubilmente legata al benessere del pianeta. Perciò perché adesso che stanno morendo degli umani ci mobilitiamo in questo modo mentre se muoiono i pesci , gli alberi, gli oceani ecc ecc no ?? Tutto l ‘ l’ecosistema è a forte rischio di distruzione e non si ferma niente e nessuno per questo. Perché?
A me sembra che in pochi sembrano rendersene conto veramente e ancora facciamo troppo poco o cmq provvedimenti che ancora non sono sufficienti. Pochi ancora usano le tecnologie che abbiamo per non inquinare e distruggere l ‘ambiente mentre ancora usano il lavoro nero dei bimbi ecc ecc e chi più ne ha più ne metta.. tanto è una storia che conosciamo tutti . Penso che se non capiamo finalmente anche questo all ‘unanimità l’universo ci metta veramente poco a toglierci per sempre dal sistema anche prima di estinguersi per motivi di equilibrio naturale o antropologici ….diciamo così per abbreviare ….il nostro Giorgio è sicuramente più esperto di noi in questo perciò non voglio andare avanti , perciò dicevo che se non facciamo qualcosa.di serio subito iniziando da questa grande lezione che la natura ci sta dimostrando credo ci sarà l ‘ autodistruzione del nostro stesso pianeta che ormai troppo malato si autoespellerà da.solo per consentire invece l’infinità dell” Universo .Le leggi universali ancora contano come ci sta ricordando madre natura perciò voglio vedere come la metteremo quando ancora e se misericordiosamente ci farà uscire da questo inghippo che ci siamo costruiti da soli …voglio vedere se dopo stiamo un po ‘ più accorti perché potrebbe sempre accadere un flagello peggiore e per certi flagelli non ci sono vaccini che tengano come purtroppo non ce ne sono nemmeno per alcuni pochi umani che detengono il potere e che si credono dei Padreterni senza aver fatto i conti con il grande Oste, senza aver fatto i conti con Dio !
Mi sembra interessante!! Aggiungerei solo: perché non si parla di 30 milioni all’anno di morti per malaria?????
IN CINA VIRUS TI BATTO. FORSE …
Emanuele Sgaramella 21 03 2020
Paolo Cannavaro è un ex calciatore italiano. Vive in Cina … e ha detto che in Cina quando arrivi in Aeroporto ci sono 4 controlli da superare tra medici che ti misurano la febbre, poliziotti e personale sanitario che ti fanno altre mille domande.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina DEVI utilizzare un’app tipo whatsapp in cui controllano tramite Gps se vai davvero a casa e se davvero ci resti per 14 giorni in Quarantena.
In Italia prima di andare in Quarantena passi a salutare a mammà, papà, gli amici più stretti e la signora del piano di sotto. Poi resti in Quarantena, tranne per fare la spesa, buttare la spazzatura, scendere il cane, fare i flashmob, comprare le sigarette o per fare jogging.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina il portiere del Condominio ti misura la febbre quando entri ed esci. Sempre. E la polizia ti fornisce un termometro, il disinfettante per le mani e le mascherine. E in ascensore cambiano la pellicola vicino ai tasti ogni 24 ore.
In Italia quando entri nel Condominio, dai un bacio al portiere perché lo conosci e sai che non ha il virus. Termometro, disinfettante e mascherine poi si vedrà, tanto mantieni la distanza di 1 metro. E in ascensore puoi premere il piano che vuoi, tanto il sabato viene la signora delle pulizie.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina il Governo ha obbligato tutte le fabbriche, anche a quelle che producono Automobili, a fare le mascherine. Stesso il Governo poi le distribuisce a farmacie, negozi e ospedali. Se un farmacista aggiunge 10 centesimi sul costo di vendita delle mascherine rispetto al prezzo imposto, viene arrestato, paga una multa e perde la licenza.
In Italia si ordinano le mascherine dalla Germania. Quelle pezzotte. Qualcuno le fa scomparire e le vende per arrotondare. In farmacia, chi le ha, le mette anche a 60 euro.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina durante la lotta al Coronavirus le autostrade erano gratis per evitare contatti con monete e macchinari. E chi è a casa riceve lo stipendio dallo Stato. Per i medici invece spese, mutui e fitti bloccati fino a dicembre 2020.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina sei costretto in Quarantena a misurare due volte al giorno la febbre e comunicare la temperatura sempre su quella famosa applicazione.
In Italia devi chiamare il 1500 ed aspettare che qualcuno ti risponde per dirti che non hai niente. Chiama il medico di base.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina durante il coprifuoco non puoi uscire. Non c’è bisogno della Polizia. Se trasgredisci ti trovano comunque con l’applicazione. E sei in galera.
In Italia puoi portare l’autocertificazione e dire quello che vuoi. Quelli che invece stanno in galera vogliono uscire per stare a casa durante la quarantena. E fuori ci stanno le mogli ad assediare i poliziotti.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina durante la Quarantena dopo i medici, sono diventati eroi i fattorini che, sempre tramite quella cazzo di applicazione, portano la spesa a casa a tutti.
In Italia durante la Quarantena sono i cittadini ad andare a fare la spesa. Toccando soldi, buste, confezioni, pacchi, superfici. Uno addosso all’altro.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina non c’era nessuno in strada. NESSUNO!
In Italia solo oggi ho beccato almeno 50 persone a cazzeggiare mentre ho fatto la spesa in 20 minuti.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina quella famosa applicazione ti dice per ogni indirizzo se e quanti positivi al Coronavirus ci sono, così se stai andando a trovare la zia in quel palazzo, non ci vai per non rischiare.
In Italia i positivi vengono dichiarati sui social. E se non sei famoso e qualcuno ti vede portare via dall’ambulanza, sui social iniziano a chiedere chi è, quanti anni aveva, da quanto tempo non lo vedevi ecc ecc.
Paolo Cannavaro ha detto che in Cina durante la Quarantena le persone impegnavano il tempo a parlare e giocare con i propri familiari.
In Italia ci sono i cantanti, i tenori dai balconi, i comici, gli attori teatrali, i truccatori, i poeti, chi canta l’inno, i flash mob, gli applausi alle 18, le luci accese alle 21, i collegamenti con Barbara D’Urso, le videochiamate a 4 su whatsapp, le dirette su Facebook, i challenge per la foto su quello che stai cucinando, la canzone neomelodica, i palleggi con la carta igienica ecc ecc …
In Cina ci hanno messo 58 giorni per battere il Coronavirus. Anzi stanno ancora combattendo.
In Italia … ma poi alla fine questi play off scudetto vi piacciono o no?
FACCIAMOCI UN ESAME DI COSCIENZA!
https://www.facebook.com/groups/Finanzcapitalismo/permalink/1271158356406475/
DRAGHI ORDINA. MA LO STATO CHE ESEGUE, non c’è più
Maurizio Blondet 26 Marzo 2020
Spendere. E presto. Draghi ha lanciato (ambiguamente 1) lo stesso allarme che hanno lanciato Bagnai, Borghi, Molinari , Garavaglia, i leghisti competenti, per i quali hanno raccolto gli scherni, i rabbuffi e gli strilli degli “economisti PD” (non si può, non ci sono le coperture), di Visco e Bankitalia al completo, del Quirinale (che voleva Cottarelli mani di forbice:), i media: tagliare tagliare… .
Il risultato è che ora tutti (persino alcuni sovranisti) dicono che l’opposizione è debole, non è stata forte e rivoluzionaria come Draghi. E’ timida, al confronto. Ed è vero: è timida perché intimidita.
Certo, Bagnai e Borghi non sono “autorevoli”, mentre Draghi è “autorevole”, dicono i media e i Cottarelli. Draghi è autorevole perché, fin dall’incontro sul Britannia, ha fatto il contrario di quel che dice Bagnai. Ha distrutto il nerbo della potenza economica-industriale dell’Italia, svenduto i gioielli, disperso le competenze, privatizzato i monopoli naturali, presieduto alle delocalizzazioni in Cina: perché questo era il Vangelo. Fino a ieri.
Oggi il Vangelo è cambiato. E’ il contrario di quello di prima. Ed è sempre Draghi a dettarlo. Dicendo cose “di un buonsenso che un normodato di provincia ha già”; ma la stampa, dopo un attimo di smarrimento cognitivo, lo spaccia già come Dio in terra.
PUBBLICITÀ
Draghi avrà il potere. “Sarà il nostro Badoglio, venderà il popolo italiano (con bravura e grande maestria tecnica) per salvare le elites che a breve lo incoroneranno” (Giuseppe Masala).
Ma l’alternativa? Sono Gualteri-Conte. Il Gualtieri dei 600 euro una tantum. O Giuseppe Conte che ”sta affamando gli italiani: non solo ha rifiutato di aiutare imprese e famiglie, ma continua ad esigere le tasse da coloro che non guadagnano un soldo perché sono chiusi in casa per coronavirus. Ma in compenso vuol dare decine di miliardi alla UE, per portare i soldi attraverso il MES, ossia la Troika” (Cita. LuMan)
Draghi invece ha ordinato:
Fare Debito Pubblico
Cancellare la regolamentazione bancaria
E “Fate presto”
E fate una rivoluzione mentale ! Addirittura
Ora, l’affamato popolo italiano, fra cui cominciano i suicidi di quelli che sanno che non riapriranno il negozietto, la fabbrichetta, ristorantino o centro benessere con cui campavano, cosa volete che scelgano? L’uomo delle Elites, e subito!
Ha purtroppo ragione Franco Bechis il direttore del Tempo (l’unico così intelligente da mettere Draghi in prima, gli altri giornali parlano d’altro, confermando l’ottusità del giornalismo italiota:
Consegnamoci a Draghi, è il solo modo di restare vivi
Portiamoci avanti, diamo per scontato che il governicchio e Visco facciano quello che Dio in terra ordina: ossia cosa? Quello che ha fatto la burocrazia inglese su ordine di Boris Johnson: pagare l’80 % dei salari a tutti i lavoratori, senza distinzione, che sono inoperosi causa coronavirus; l’indennità di malattia a tutti gli autonomi; 17-25 mila sterline sul conto corrente a tutti i ristorantini e piccole imprese. Senza distinzione e senza discussione.
E subito, perché Draghi ha ragione su questo: “La velocità è essenziale per le misure di sostegno, “il costo dell’esitazione può essere irreversibile”.
Ora, provate a pensare: quale apparato dello stato o parastato esiste, capace di agire così rapidamente, da versare sull’unghia i salari e i soldi alle piccole e grandi imprese? Non riesco a immaginarne nessuno. Non solo le nostre burocrazie sono inefficienti, e corrotte; hanno la lentezza come filosofia aziendale. Per qualunque disposizione, il loro impulso è “rallentare”, vedere come applicarla nel modo più sgradevole e ostile agli interessi del popolo.
L’ufficio stampa del premier
E “versare i soldi” alla gente,come fa la burocrazia britannica, è proprio il contrario della postura mentale degli statali, comunali, provinciali, regionali; loro, i soldi alla gente “li prendono”, e non li danno. Mai. Lo sa chiunque abbia da reclamare un rimborso dall’apparato pubblico.
E’ più forte di loro, è appunto una postura mentale (“intellettuale” sarebbe di troppo).
Guardate i 600 euro che Gualtieri ha promesso, invece dell’80% dei salari ai britannici. Non solo sono una volta sola. Non è che vengono versati a chi ne ha diritto sul conto o sulla carta postale. No, è il cittadino che deve chiederlo, andando sul sto ministeriale scritto in gergo statale, capire dove e come cliccare …. E attenzione, non ce n’è per tutti, chi primo arriva avrà i 600, tutti gli altri no. In questa “modalità” sento forte la filosofia della burocrazia pubblica, dirigenziale: sicuramente è lei che l’ha suggerito a Gualtieri. Il cittadino va umiliato, deve stendere la mano –per partecipare alla lotteria.
O sarà l’Inps? Probabilmente ha i dato per procedere almeno al grosso dei pagamenti della maggioranza di dipendenti privati (ed oggi privi di stipendio). Ma guardate quello che il presidente dell’Inps, Tridico, ha appena dichiarato: “Le pensioni le garantisco solo fino a maggio” – allegri pensionati, fra due mesi non avrete più nulla. E il motivo? “Coi contributi sospesi, l’Inps non ha liquidità”.
Er Tridico.
Vedete come ragiona Tridico, massimo e pagatissimo dirigente pubblico? Le aziende private non mi pagano i contributi, dunque io non pago più le pensioni. Nemmeno gli viene in mente di esigere da Bankitalia le decine di miliardi per continuare, almeno nell’emergenza a non far morire i pensionati – che spesso mantengono i nipoti disoccupati.
Non solo non gliene frega niente delle famiglie italiane, che sarebbe già qualcosa; li odia, li vuole spaventare e umiliare. E la colpa, la vuole dare alle aziende che non possono pagare i contributi perché chiuse per ordine del governo Casalino: sono private, quindi spregevoli contribuenti sempre in cerca di trucchi per evadere.
Ed ora volete che l’INPS si metta a versare l’80 per cento dei salari , poniamo, al milione e mezzo di metalmeccanici che sono chiusi in casa? Non sia mai: vediamo, prima, chi merita e chi no. Chi fa il furbo. Quindi, ciascuno deve fare domanda, riempire il formulario, che abbiamo sparso di trabocchetti in burocratese.: ha fatto un secondo lavoro in nero, magari…magari ha la badante in nero per il nonno …bisogna scoprirlo, prima… Con calma e lentezza. Fra sei mesi, forse, arrivano i soldi…In fondo come le mascherine della Protezione Civile. Non sono arrivate, e gli ospedali sono diventati degli incubatori dell’epidemia, muoiono i medici, si suicidano le infermiere – colpa loro, non hanno cliccato per avere i 600. Una tantum. Ma voi cantate sui balconi, mentre il presidente celebra il 76 mo anniversario (e 3 mesi) delle Ardeatine, e ne approfitta per dare un calcetto all’opposizione. Debole, timida in onfronto a Mario Dio in terra.
Andrà così. Sarà questo a far fallire il piano Draghi.
Nota 1
Ambiguità:
“eh no! Aspetta, dove corri? Devi prima aderire al #MES dove l’amico Klaus ti fa firmare una letterina che ci garantisce tutti. Sai com’è: i tedeschi non si fidano e temono che quei BTP restino in eterno sui nostri libri. Tu firma e noi facciamo pure OMT, un PEPP più forte…” (Liturri)
Le banche, non lo Stato, distribuire i soldi.
Commento di Valentino lettore:
Il diavolo si sa è nei dettagli: 1) ” il debito pubblico non è un problema. Fate distribuire i soldi dello Stato alle banche”, non alle aziende, lavoratori, autonomi alle banche? 2) “Livelli più elevati di debito pubblico diventeranno una caratteristica dell’economia e saranno accompagnati dalla cancellazione
del debito privato”, cioè lo Stato s’indebita (con le banche), dà i soldi alle banche e queste prestano ai privati (tutto il settore, banche incluse?) a tasso zero (mentre per lo Stato, lo dice lui successivamente, a qualsiasi prezzo?) però al settore privato è permessa la cancellazione del debito la quale resta in seno allo Stato. Il come lo Stato deve intervenire è successivamente spiegato: i governi garantiscono tutte le immissioni monetarie atte al salvataggio del settore privato (Titoli di Stato), poichè come dice il dragone bisogna salvare la base fiscale, cioè il recupero crediti dello Stato tramite tassazione. Morale della favola tutto ciò che sarà salvato lo pagheremo noi (persone comuni) tramite tasse, e ricadiamo nellla socializzazione del debito.
Lorenzo:
Credo che Draghi si riferisca invece, nella frase immediatamente precedente il Suo commento, alla cancellazione del debito privato assunto dalle imprese per il mantenimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti, trasferito direttamente o indirettamente al debito pubblico perché coperto (ad erogazione diretta per le imprese o tramite garanzia statale delle linee di credito concesse dagli istituti) dal bilancio dello Stato, a sua voltà finanziato in entrata con emissione di nuovi titoli di debito.
Quindi non credo che Draghi stia dicendo che si può cancellare il debito pubblico, come ha sostenuto Borghi, ma un’altra cosa: che si può cancellare il debito privato, trasferendolo. Per Draghi vale il principio di Lavoisier in tema di debito: niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma.
Infine: molto bene tutto il ragionamento di Draghi, davvero interessante ancorché contraddittorio, come lei fa notare, rispetto a dichiarazioni ed azioni precedentemente fatte dallo stesso. Una sola pecca (sed nihil sub sole novi): tutto il sistema di trasferimento del debito da privato a pubblico non prevede, nell’idea di Draghi, la possibilità di uscita dal sistema inaugurato nel 1979 con lo SME e il conseguente divorzio tra Bankitalia e il Tesoro. Si parla ancora di finanziamento a debito sui mercati privati (infatti si circostanzia anche riferendosi agli attuali tassi di interessi), senza ammettere quella che sul lungo termine è l’unica possibilità di sostenibilità economica e politica (perché taglia alla radice le dinamiche di ricatto politiche associate alla gestione di grossi quantitivi di debito da parte dei fondi e dei gruppi finanziari): emissione di denaro dalle banche centrali con acquisto di titoli direttamente dal Tesoro a tassi più che ridotti. Anzi, Draghi qui non allude neanche, mi pare, al piano di emissione BCE con acquisto titoli nazionali.
Sta forse proponendo una terza via? Né emissione denaro BCE, né MES (né eurobond…), ma revoca dei vincoli ordinari di Maastricht e indebitamento aumentato ma direttamente sui mercati privati?
Lorenzo Gasperini, Livorno
FONTE:https://www.maurizioblondet.it/draghi-ordina-ma-lo-stato-che-esegue-non-ce/
POLITICA
CONTE E LA VIA ITALIANA ALL’EPIDEMIA
Pubblicato il 19/03/2020 da admin
(Un’epidemia senza pianificazione)
Già il 31 gennaio il governo Conte bis sapeva benissimo che stava arrivando un’epidemia, come prova il fatto che in quel giorno Conte firmò il decreto di stato di emergenza sanitaria, in cui si dice che occorrono misure eccezionali di prevenzione (1); poi però, per oltre un mese, non ha preso le misure per contenere il contagio. Perché? Fu un errore? Una coincidenza?
Anzi, assieme a Zingaretti e altri, diffondeva dichiarazioni rassicuranti e minimizzanti: tutto è sotto controllo: un errore? Una coincidenza?
Ha bloccato i voli in arrivo direttamente dalla Cina, non però gli arrivi indiretti, via qualche scalo, quindi il blocco era inutile: un errore? Una coincidenza?
Il 30 gennaio Salvini aveva chiesto il blocco degli arrivi dalla Cina e la quarantena per i già arrivati, nonché altre misure urgenti. Reazione di Conte: : “Qualcuno dovrebbe pagare per le sciocchezze. “ Fu un errore? Una coincidenza?
Intanto Zingaretti, capo del principale partito di governo, incitava alla fiducia e ad abbracciare i cinesi, mentre la sinistra imprecava contro il razzismo dei fascio-leghisti. E Speranza, ministro della salute, appena qualche settimana fa dichiarava: “L’Italia è un grande Paese, con il più alto livello di salvaguardia e sorveglianza sul coronavirus”. Era un errore? Una coincidenza?
Questo per oltre un mese. Quando il governo Conte ha deciso di istituire le zone chiuse di Lombardia, mezzo Veneto e altre province, lo ha fatto sapere pubblicamente con un giorno e mezzo di anticipo, e così ha indotto migliaia di persone a fuggire dalle zone rosse verso il Sud, a propagare il contagio. Un altro errore, un’altra coincidenza?
Due giorni dopo, ha dichiarato zona rossa o zona protetta non più solo la Lombardia e le altre 11 province, ma tutta l’Italia. Perché ha aspettato due giorni? Per permettere che quelli che scappavano dalle zone rosse diffondessero il contagio nel resto d’Italia, oppure per un errore o per una coincidenza?
Tutto questo va a costare migliaia di morti.
Se quel salernitano che si è filmato e messo in rete mentre sputa sulla frutta in un supermercato, con la scritta: “Infettiamo!” dovrebbe essere in galera, dove dovrebbe essere questo governo? Chi ha fatto più danni, più morti?
I provvedimenti di restrizione della libertà di movimento, costituzionalmente sancita in modo rafforzato dall’art. 16, e del diritto di riunione, possono essere opportuni per contenere il contagio. Ma con che faccia, con che legittimazione li emette un governo Conte, dopo aver commesso tutti quegli errori e quelle coincidenze? Con che faccia minaccia ulteriori restrizioni e vanta decine di migliaia di controlli e migliaia di denunce contro supposti trasgressori del suo decreto sospensivo delle libertà costituzionali? E minaccia il carcere contro persone che non fanno nulla, rispetto al danno che ha causato il governo stesso? E continuamente chiede all’opposizione di non fare polemiche? Chi ha commesso il reato di epidemia (art. 438 CP), se qualcuno lo ha commesso? E se i morti di questo virus non sono solo tre, come dicono fonti ufficiali.
E come potranno i nostri bravi Giudici giudicare legittimamente i trasgressori al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la libertà di spostamento, se nessun procedimento e nessuna condanna saranno disposti per i colpevoli di tutti quegli errori e coincidenze?
Ora mi immagino i complottisti abbandonarsi alle loro esorbitanti speculazioni. Mi aspetto che bercino qualcosa come: “Ecco, non possono essere tutti errori e coincidenze, in politica niente avviene per caso, un governo con tutti i suoi consiglieri tecnici e il dialogo col Quirinale non può commettere errori e coincidenze così numerosi e grossolani. Evidentemente la diffusione dell’epidemia era voluta e pianificata, e pianificata allo scopo di creare una situazione di emergenza che consentisse una sospensione della Costituzione e la sua sostituzione con un regime di controllo zootecnico della popolazione, dii evitare elezioni che avrebbero messi in crisi il governo, creare le condizioni per poter rinchiudere, isolare e tracciare elettronicamente la gente, una grande prova del domani tecnologico. E in più un disastro economico per la gioia degli speculatori internazionali a danno dell’Italia.”
Ebbene, dichiaro che queste sono tutte fantasie morbose, e che si è trattato solo di errori scusabili e di coincidenze sfortunate, di governanti un po’ improvvisati, un po’ brocchi, che la Natura, senza loro colpa, non ha dotato delle facoltà necessarie a governare. Ma li abbiamo scelti noi, quindi queste cose, questo danno, rientrano nei costi della democrazia.
I complottisti mi permettano di insegnare loro una cosa. Bisogna guardarsi dall’ incorrere in un errore molto comune in coloro che non hanno esperienza di ricostruzione forense dei fatti: l’errore che ci porta, esaminando e collegando i fatti a posteriori, a interpretarli in un modo o nell’altro, ravvisando questa o quella intenzione nei loro autori, a seconda dei nostri pregiudizi o dei nostri scopi.
Però, nel caso in esame, con tutto il rispetto per il prof. Conte e per il suo governo, allo scopo di ridare autorevolezza alle istituzioni in questa fase molto critica e di decisioni impegnative, soprattutto quelle di sospendere i diritti costituzionali e il funzionamento costituzionale del Parlamento e le votazioni, sarebbe bene che andassero subito a casa (anzi, in quarantena sotto chiave) e venissero sostituiti con coloro che, sin dall’inizio, tempestivamente, hanno invocato quei provvedimenti che ora, tardivamente ,alla spicciolata, il governo prende, ma che, se assunti a quel tempo, avrebbero risparmiato molti morti e molta rovina economica, soprattutto nelle regioni portanti del Paese.
Dopo questa sostituzione, potremmo anche dirci, senza ridicolo, orgogliosi che il modello Italia di gestione dell’epidemia venga adottato in tutto il mondo.
20.03.2020 Marco Della Luna
1- Ecco nel testo ufficiale, estratto dalla Gazzetta Ufficiale, la prova che Conte e soci sapevano che si dovevano prendere i provvedimenti che hanno poi iniziato a prendere solo 33 giorni dopo:
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 31 gennaio 2020
… …
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;
Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della ,Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;
Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul
territorio nazionale;
Considerata la necessità di supportare l’attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
… …
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), e dall’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Roma, 31 gennaio 2020 Conte
FONTE:http://marcodellaluna.info/sito/2020/03/19/conte-e-la-via-italiana-allepidemia/
Quale Karl Polanyi?
di Michele Cangiani
Negli ultimi anni, è potentemente ripresa a livello scientifico la discussione sull’eredità di Karl Polanyi. Ma la maggior parte dei suoi interpreti contemporanei elude la questione, fondamentale per lui, delle caratteristiche più generali che distinguono la società contemporanea. È da qui, però, che bisognerebbe ripartire
Tempo di crisi
A un giornalista, che nel settembre 2007 gli chiedeva quale candidato preferisse per la presidenza degli Stati Uniti, Alan Greenspan, Presidente della Federal Reserve fino all’anno precedente, rispose che non importava molto: «Il mondo è governato dalle forze di mercato»[1]. Con quali risultati? Era in vista la crisi, che tuttora non si può dire superata. Teoria e pratica neoliberali restano in auge, benché dannose per l’ambiente umano e naturale e persino controproducenti rispetto al loro scopo “economico”. Continua, infatti, ad essere stentata e precaria la ripresa dell’accumulazione capitalistica, anche perché la svalutazione globale della forza lavoro e l’aumento della quota di reddito assorbita dalle rendite, finanziarie ma non solo, hanno un vantaggio immediato, ma poi un effetto deflattivo. Inoltre, la “crescita” sempre auspicata si scontra con quei «limiti dello sviluppo»[2], che non sono più una previsione, ma una realtà.
C’è chi parla di crisi ‘sistemica’ e chi ricorre a Karl Marx (Il Capitale, L. III) per spiegarla. Ben più assiduo riferimento viene fatto all’opera di Karl Polanyi, la fortuna del quale ha continuato a crescere nel tempo della nostra sfortuna, a partire dalla crisi degli anni 1970 e soprattutto con il successivo affermarsi della globalizzazione neoliberista.
La sensazione che i tentativi di superare le difficoltà in cui la nostra società si trova siano poco efficaci o addirittura controproducenti porta alla questione cruciale, rappresentabile con una metafora cibernetica: se correggendo la mira l’errore aumenta, è il sistema di puntamento che va modificato. Ma come? In The Great Transformation (1944)[3], Polanyi sostiene che la crisi del capitalismo liberale (ottocentesco, «vittoriano») era inevitabile e definitiva.
Trovandosi in un’impasse, la società ha dovuto trasformare le proprie istituzioni. Il capitalismo si è salvato, quasi sempre a scapito della democrazia. La soluzione alternativa sarebbe stata il socialismo, cioè, per Polanyi, la piena realizzazione della democrazia. Ludwig Mises e Friedrich Hayek, suoi avversari della Scuola austriaca di economia neoclassica, contribuivano già a delineare i tratti di quello che sarà chiamato neoliberismo.
Appena finita la Seconda guerra mondiale, Polanyi torna a interrogarsi sul futuro. L’alternativa si ripresenta. Il socialismo rimane, per lui, la via verso la realizzazione di una società «veramente democratica», in cui «il problema dell’economia si risolverebbe mediante l’intervento programmato degli stessi produttori e consumatori». Egli sa, tuttavia, che probabilmente verrà seguita la via opposta, propugnata da coloro che «credono nelle élites e nelle aristocrazie, nel managerialismo e nella grande impresa» e ritengono che «la società nel suo complesso debba essere adattata sempre più intimamente al sistema economico, che vorrebbero conservare immutato»[4]. In seguito, l’impegno politico, che aveva sempre animato il suo lavoro di giornalista e d’insegnante ad allievi adulti, specialmente operai, resta alla base delle sue ricerche sulle economie antiche e primitive, svolte presso la Columbia University di New York. Nell’Introduzione di un’opera incompiuta sul metodo della teoria economica e sull’economia antica, pubblicata dopo la sua morte, egli tiene ad avvertire il lettore che studiare le diverse forme sociali dell’economia, anche lontanissime nella storia, mettendo in questione la scienza economica, gli sembra necessario «per accrescere la nostra libertà di adattamento creativo e in tal modo aumentare le nostre possibilità di sopravvivenza»[5]. Il motivo di fondo, più o meno consapevole, dell’attuale interesse per Polanyi dev’essere la sensazione che la nostra società, nella quale il sistema economico è determinante, rischi una deriva entropica a causa dell’incapacità di gestire il proprio rapporto con l’ambiente umano e naturale.
Quanto più grave è la crisi, tanto più necessaria è la conoscenza: e tanto più si accende la lotta nel campo dell’ideologia. È dunque comprensibile che convivano o si scontrino modi differenti d’intendere e applicare il pensiero di Polanyi, anche perché esso spazia in vari campi, è complesso e talvolta non abbastanza esplicito. Un’ulteriore difficoltà è che il significato dei suoi scritti dipende dal loro contesto: non solo quello costituito dal loro insieme, ma anche quello di un’esperienza intellettuale e politica vissuta dall’autore in diversi paesi, in situazioni storiche ormai lontane.
Questione di metodo
Nel 1958, sei anni prima della sua morte, Polanyi scriveva a un’amica: «L’opposizione che le mie idee hanno finalmente suscitato è un buon segno». Trade and Market in the Early Empires[6], il volume del 1957 che riuniva saggi suoi e di colleghi e allievi della Columbia University, aveva riaperto la “controversia sul metodo” delle scienze economico-sociali.
Polanyi contesta la possibilità di applicare alle società precedenti categorie e leggi della scienza economica neoclassica. Esse, egli afferma, non sono valide in generale, ma rispecchiano – superficialmente – il modo in cui la società di mercato riproduce e rappresenta se stessa. Proiettate su altre società, ne danno un’immagine fallace. E anche riguardo alla nostra società, esse ostacolano la comprensione delle sue caratteristiche fondamentali, quindi della sua specificità storica e della sua dinamica. Polanyi riprende, così, la «critica dell’economia politica», assumendo, come Marx, il difficile compito della nostra epoca: la visione da fuori della scatola sociale dentro la quale ci troviamo.
Lo studio dell’antropologia e della storia antica serve anche ad assolvere quel compito. L’analisi di sistemi economici tanto diversi consente di mettere in questione il nostro, passando per la critica della scienza economica convenzionale e la riformulazione del concetto stesso di economia.
Secondo Polanyi, la definizione «sostanziale» dell’economia, quel che di essa si può dire in generale, è che essa è il modo in cui gli individui umani si procurano i mezzi materiali per soddisfare i propri bisogni, interagendo con l’ambiente naturale e sociale. Egli contrappone questa definizione a quella «formale» adottata dall’economia neoclassica, che postula la razionalità “economizzante” e la “scarsità” come attinenti all’agire economico in sé. Per Polanyi, invece, occorre distinguere il significato generale, generalissimo, che la razionalità e la scarsità hanno in riferimento alla condizione umana dopo la cacciata dall’Eden, dalla loro determinazione come istituzioni di un particolare modo storico di produzione: il capitalismo. Esse connotano, allora, una data forma sociale, in cui si tratta di produrre il massimo con il minimo, dato che il profitto è lo scopo; in cui ogni reddito deriva dalla vendita sul mercato, della propria forza lavoro se non altro; in cui, quindi, il denaro – scarso in sé, poiché vale secondo la sua quantità – è diventato il medium universale.
La definizione «formale» trasfigura questa realtà storica in false generalizzazioni, che impediscono di conoscerla come tale. L’individuo umano bisognoso e razionale viene messo direttamente in rapporto con le risorse di cui dispone, prescindendo dalle determinazioni storico-istituzionali di tale rapporto. Polanyi contrappone a questo metodo individualistico ed «economicistico» quello «sociale», riconducendolo esplicitamente alla «critica» di Marx: si tratta di comprendere il modo in cui l’economia è storicamente organizzata, cioè istituita socialmente, di volta in volta in modo specifico. Questo, egli scrive, è il problema, inevitabilmente comparativo, del «posto dell’economia nella società». Ed è seguendo questo metodo che egli elabora il concetto di “società di mercato” – cioè di “società di mercato capitalistica”, come precisa Ron Stanfield, suo precoce e attendibile interprete[7].
Le brillanti ricerche di Marshall Sahlins sull’«economia dell’età della pietra» fanno esplicitamente riferimento a Polanyi, che egli incontrò in occasione del proprio dottorato presso la Columbia University. Sahlins dimostra – prendendo qualche distanza dalla precedente formazione alla scuola evoluzionista di Leslie White – che la scarsità dei mezzi non esiste nelle società di cacciatori e raccoglitori, poiché i bisogni che implicano un’attività lavorativa sono culturalmente limitati, in un ambiente relativamente ricco di risorse. Al contrario che in quelle «originarie società dell’abbondanza», è nella nostra che non solo la scarsità, ma anche la fame divengono istituzionali[8].
Antropologi e archeologi furono i primi a dividersi riguardo al metodo di Polanyi, riproposto in un articolo del 1961[9] da George Dalton, suo allievo alla Columbia. Dalton spiega bene la cesura, la differenza di specie e non di grado, fra la nostra società e quelle studiate dagli antropologi. Non si possono quindi tradurre i processi economici primitivi in «equivalenti funzionali» dei nostri; in generale, non sono applicabili ad essi le categorie della scienza economica, che rispecchiano la nostra specie di economia. In seguito, Dalton estende al marxismo la sua critica «sostantivista», disapprovando l’uso di concetti come rapporti di produzione, surplus, sfruttamento, sovrastruttura ecc. nell’analisi antropologica[10] – concetti appartenenti, in effetti, alla teoria della società capitalistica. Egli, d’altra parte, non critica il formalismo neoclassico, lasciando supporre che esso sia valido per lo studio della società contemporanea e anche per quelle “in via di sviluppo”, nella misura in cui adottino istituzioni “di mercato”.
Il rapporto fra Polanyi e Marx, con particolare riferimento all’antropologia economica, viene analizzato in modo rigoroso e approfondito in un saggio di Rhoda Halperin. Ella sostiene che il «sostantivismo» di Polanyi non può essere dissociato dal pensiero di Marx – come, a suo avviso, Dalton vorrebbe – e anzi una lettura parallela consente una migliore comprensione di entrambi[11].
Il dibattito sull’opera di Polanyi ha coinvolto storici e antropologi marxisti. Qui è possibile solo accennare alla decisiva riformulazione del materialismo storico compiuta, grazie all’influenza di Polanyi, da Maurice Godelier, formatosi in precedenza nell’ambito del marxismo e dello strutturalismo di Claude Lévi-Strauss e Louis Althusser. Quel che resta, secondo Godelier, della “determinazione in ultima istanza” da parte dell’economia è che, nelle forme premoderne di società, sono sempre le istituzioni sociali di volta in volta dominanti – la parentela, la gerarchia politica, la tradizione religiosa – quelle che espletano la funzione economica (definita in modo «sostantivo») e motivano l’attività economica degli individui. Istituzioni specificamente economiche non esistevano o erano irrilevanti per la riproduzione della società. Solo nella nostra la funzione economica è istituita “economicamente”, cioè è svolta da una struttura autonomamente economica e, quindi, dominante[12]. Si può dire che questa soluzione salvi Marx dall’economicismo e dal determinismo marxista; inoltre, essa avvalora l’insistenza di Polanyi nel sottolineare la specificità della società di mercato capitalistica rispetto ad ogni altra.
La questione di tale specificità – quindi del grado in cui le caratteristiche della nostra società vengono determinate – è fondamentale in tutta la discussione che, fino ai nostri giorni e nei vari campi delle scienze sociali, fa riferimento all’opera di Polanyi. Per esempio, posizioni contrapposte sono rappresentate, riguardo alla storia antica, dagli studi di Moses Finley sulla Grecia, che seguono il metodo di Polanyi, e da quelli di Paul Veyne, che interpreta l’economia di Roma antica attenendosi alla definizione “formale” dell’economia quale condotta individuale «motivata dall’interesse», svolta impiegando razionalmente i mezzi disponibili. Per Veyne, insomma, l’economia sarebbe sempre l’economia: fra i tempi antichi e i nostri, la differenza sarebbe «solo di grado»[13].
Per Polanyi – come per Max Weber[14] e ovviamente per Marx – il generalizzarsi del mercato, parallelamente allo sviluppo della produzione capitalistica, costituisce una cesura storica. Nei primi decenni del XIX secolo, in alcune parti del mondo, il sistema di mercato capitalistico prende a determinare l’organizzazione dell’economia, scrive Polanyi, combinando esseri umani e risorse naturali «in unità industriali dirette da privati impegnati principalmente a comprare e vendere a fini di profitto»[15]. Si producono merci, e anche i mezzi di produzione – il lavoro e la terra – divengono merci. Si costituisce così «la nuova economia capitalistica»[16] e con essa una nuova società. «Non è questione di grado, ma di qualità», egli sottolinea: la cesura è netta – e «violenta» – rispetto alle società precedenti, in cui i mercati, occupando spazi «isolati», «non danno forma a un sistema economico»[17]. L’isolamento – ad esempio, nei ports of trade[18] – garantiva, anzi, che le pratiche di mercato rimanessero al loro posto, dato che erano, appunto, marginali rispetto all’organizzazione tradizionale della società, che avrebbero anche potuto compromettere.
Fernand Braudel – attenendosi, come Veyne, a una definizione generale dell’attività economica e del mercato nella «lunga durata» – sostiene che la concezione polanyiana del sistema di mercato come particolare modo storico di organizzare la produzione sia frutto di «un gusto teologico della definizione»[19]. Douglass North, a sua volta, contrappone al metodo di Polanyi quello della Nuova Storia Economica. Secondo North, non solo il comportamento economico segue norme costanti e motivi propri, ma le istituzioni premoderne – p. es. i ports of trade – e il loro evolversi si spiegano, fondamentalmente, in rapporto con la loro funzione di tenere relativamente bassi i “costi di transazione” e di aprire nuove possibilità di sviluppo economico[20]. Il sistema di mercato (con i suoi complementi, come il Codice civile) è insomma, per la Nuova Storia Economica, il punto d’arrivo della scala evolutiva delle istituzioni economiche, e quindi la chiave universale per comprenderle – non importa quanto remote esse siano.
Il metodo olistico di Polanyi consiste invece nel porre il problema delle diverse forme storiche di società e quindi del modo in cui, in ognuna, l’economia è organizzata. La comparazione a vasto raggio tra le diverse forme è intrinseca in tale metodo. La società in cui viviamo entra inevitabilmente nella comparazione, in quanto forma specifica, che va determinata come tale, al pari di qualsiasi altra. Il confronto, la cognizione della differenza, consentono di comprendere meglio le altre società, e anche la nostra, fuori dal quadro ideologico in cui essa si rappresenta.
È anche mediante la comparazione così intesa che La grande trasformazione fa risaltare le caratteristiche profonde della società capitalistica. Tale livello più generale dell’analisi è intrecciato, nel libro, con quello più specifico delle origini, dell’assetto istituzionale e del «crollo» della «civiltà del diciannovesimo secolo», cioè del capitalismo liberale. L’analisi più concreta – ad esempio la formazione storica del mercato del lavoro, sancita infine legislativamente in Gran Bretagna nel 1834, abolendo il sussidio concesso a tutte le famiglie che non raggiungessero un reddito minimo commisurato al numero dei loro componenti – conduce a concetti riguardanti in generale il capitalismo. Tali concetti – ad esempio, per richiamare un’espressione di Marx, il «lavoratore in forma così nuda»[21], liberato dai vincoli medioevali e anche dai mezzi materiali e sociali della propria sussistenza – consentono, a loro volta, di spiegare gli eventi storici concreti, definendone pienamente il significato. Ad esempio, la riforma del 1834 significa l’affermarsi di una società in cui – osserva Polanyi sulle orme di Max Weber – i motivi dell’agire economico diventano istituzionalmente «la fame e il guadagno». Si ha dunque una società in cui l’agire economico ha motivi che appaiono essenzialmente “economici”, e che è divisa non più in ceti, ma in classi: cioè, precisa Weber, in base al rispettivo rapporto che gli individui, quali liberi cittadini, hanno con l’attività economica. La divisione e il conflitto di classe rientrano, poi, nella spiegazione che Polanyi dà del fatto che, in media, almeno tre quarti di secolo passino prima che il lavoratore diventi libero anche nel senso di titolare del diritto di voto[22]. In effetti, come La grande trasformazione mette in rilievo, il potere delle classi lavoratrici, conquistato anche grazie all’allargamento del suffragio, contribuisce a determinare la crisi del capitalismo liberale e in particolare di uno dei suoi pilastri istituzionali, «lo Stato liberale».
Il posto dell’economia
L’economia è sempre socialmente istituita, organizzata. Si tratta di stabilire come: questo è, per Polanyi, il problema del «posto dell’economia». Egli sostiene che la particolarità della società di mercato capitalistica è che l’economia sia organizzata “economicamente”, cioè secondo norme e motivazioni specificamente economiche. Questo modo di essere istituita assegna all’economia un “posto” a sé, separato dalle altre sfere della vita sociale: una novità nella storia umana.
Max Weber parla in tal senso della moderna «razionalizzazione»: dell’economia in primo luogo, ma anche degli altri aspetti della vita sociale. Niklas Luhmann ha sviluppato il tema nella teoria della differenziazione del sistema sociale in sottosistemi relativamente autonomi, eventualmente autoreferenziali.
Quando il sistema di mercato si generalizza, parallelamente alla produzione capitalistica, l’economia diviene non solo «razionale», ma anche tendenzialmente autonoma. Secondo Polanyi, data l’importanza vitale della sfera produttiva, si realizza «una società “economica”» come mai in precedenza[23]. In effetti, le istituzioni fondamentali della società, quelle che la caratterizzano in modo non contingente, sono istituzioni peculiarmente “economiche”; esse determinano almeno in parte le altre sfere sociali e comunque le vincolano. Il sistema di mercato implica una società di mercato. Rispetto a tutte le società precedenti, la differenza appare radicale, una vera contrapposizione: «Non è più l’economia ad essere incorporata (embedded) in rapporti sociali – scrive Polanyi[24] – ma sono i rapporti sociali ad essere incorporati nel sistema economico».
Il senso di tale contrapposizione va colto al livello della comparazione antropologica. Bronislaw Malinowski – una delle fonti principali di Polanyi – osserva, a proposito degli indigeni delle isole Trobriand, che «norme tradizionali e giuridiche, concezioni magiche e mitologiche introducono un ordine sistematico nelle loro attività economiche e le organizzano socialmente»[25]. Walter Neale, allievo di Polanyi, dedica uno dei saggi che compongono Traffici e mercati… all’organizzazione dell’economia nella società indiana tradizionale. Egli spiega come la divisione del lavoro e la distribuzione del prodotto fossero organizzate mediante un complesso sistema di diritti, obblighi e divieti basato sulle caste, cioè su una tradizione religiosa, che includeva il principio della purezza come criterio gerarchico e la credenza nella metempsicosi come metodo di controllo sociale[26].
L’opposizione fra l’economia embedded in tutte le società precedenti e l’economia moderna, essenzialmente autonoma e autoreferenziale, disembedded, ha un ruolo centrale nel pensiero di Polanyi. Essa è parte integrante della sua critica della scienza economica convenzionale come di quella del materialismo storico, che sono a loro volta elementi significativi della sua teoria della società di mercato capitalistica. Su questa base teorica poggia, poi, il suo ideale politico del reinserimento nella società di un’economia non più fine a se stessa. Tale reinserimento sarebbe l’orizzonte verso il quale procedere per realizzare la libertà “positiva” dell’individuo moderno di collaborare liberamente, consapevolmente e responsabilmente al funzionamento delle istituzioni sociali, e anche al loro continuo rinnovamento. «Libertà socialista» Polanyi la definisce in un manoscritto del 1927[27].
La radicalità teorica e, corrispondentemente, politica del pensiero di Polanyi lo ha reso attraente nell’attuale epoca di crisi. D’altra parte, inevitabilmente, essa ha suscitato resistenze, manifestatesi non solo in critiche, come quelle sopra accennate di Braudel o North, ma anche in interpretazioni riduttive o “creative”.
Gran parte degli interpreti di Polanyi tendono a eludere la questione, fondamentale per lui, delle caratteristiche più generali che distinguono la società contemporanea. Ci si può azzardare a supporre che ciò accada perché si vuol evitare di mettere in questione il sistema di mercato capitalistico come tale. Questo è l’esito, sopra segnalato, dell’applicazione della teoria economica neoclassica da parte degli storici e degli antropologi “formalisti”[28]. Arrivano, tuttavia, allo stesso risultato anche gran parte di coloro che contestano l’adeguatezza della teoria neoclassica, sentendosi magari in dovere di far riferimento a Polanyi: adattandolo ai nostri tempi, in cui un cambiamento delle caratteristiche fondamentali dell’organizzazione sociale appare tanto irreale da rendere difficile, forse nevrotizzante, la mera visione di tali caratteristiche nella loro realtà. Occorre allora, per cominciare, levare di mezzo l’opposizione embedded/disembedded, nel significato che essa ha per Polanyi. Vi hanno provveduto sociologi, economisti neo-istituzionali, antropologi riformisti, neopolanyiani eclettici, adepti della solidarietà e del dono.
In un famoso articolo, Mark Granovetter[29] presenta la “Nuova sociologia economica” quale complemento necessario della teoria economica. Egli sostiene che l’agire economico, come non è totalmente determinato culturalmente nelle società premoderne, così, nella nostra, non è puro calcolo utilitario di individui atomizzati. Esso continua, dunque, ad essere embedded. La “scelta razionale” implica finalità e condizioni non strettamente economiche, motivi morali e sociali (p. es. il potere e il bisogno di approvazione sociale). Va tenuto conto di fattori quali la fiducia, la disonestà e il potere gerarchico. Vanno studiate le «reti sociali», utili, ad esempio, nella ricerca di un’occupazione; mentre l’iscrizione a un country club può procacciare affari.
La letteratura in questo campo è vasta[30] e non ha mancato di ispirare qualche economista, George Akerlof per esempio, che d’altronde già seguiva questa strada. Ovviamente, non si può vietare ai socio-economisti l’uso dell’aggettivo “embedded”, in ricerche del resto utili. Occorre, però, distinguere i diversi significati che esso assume a seconda del contesto analitico in cui viene impiegato. Il livello “micro” della sociologia economica o dell’economia neo-istituzionalista costituisce un determinato oggetto di ricerca, diverso da quello della comparazione a vasto raggio e a livello “macro” fra forme di organizzazione sociale. L’opposizione embedded/disembedded nel senso di Polanyi si colloca a questo secondo livello. Lo stesso Granovetter ha in seguito riconosciuto che, dato il tipo di questioni di cui egli si occupa, non sarebbe appropriato chiamare in causa Polanyi, come egli fa nell’articolo sopra citato[31]: nell’ultima parte del quale, d’altronde, in contraddizione con il riferimento a Polanyi nella prima parte, egli precisa che oggetto delle sue ricerche non sono «questioni generali riguardanti la natura della società moderna» (p. 506).
Il ripensamento di Granovetter non ha impedito la diffusione dell’attribuzione a Polanyi stesso dell’interpretazione “sociologica” del concetto di embeddedness, per cui l’economia sarebbe «sempre embedded», anche nella nostra società. Ci si appella al fatto che La grande trasformazione fa riferimento all’intervento pubblico: necessario per istituire il sistema di mercato e divenuto, in seguito a ciò, sempre più ampio e complesso. Inoltre, Polanyi afferma che un perfetto «mercato autoregolato» era «un’utopia», poiché la società non poteva non difendersi dalla riduzione a merci, potenzialmente catastrofica, delle «merci fittizie»: lavoro, terra e denaro. Si ha dunque un «doppio movimento»: l’estendersi del mercato viene contrastato da una reazione sociale che ottiene misure protettive. Insomma, l’economia non è mai stata disembedded, ma solo più o meno embedded, a fasi alterne.
Questa conclusione non regge. Secondo Polanyi, nella società di mercato economia e politica sono istituite come «sfere istituzionali» diverse, ma ciò non vuol dire che non interagiscano nella realtà concreta. Si pensi ad esempio all’imperialismo o al dominio della stessa classe in entrambe le sfere, benché formalmente separate, ognuna con la propria weberiana «razionalità». Il livello storico-concreto dell’analisi non solo non esclude quello più astratto, ma ne dipende. Le vicende storiche si spiegano mediante concetti più generali, che le rendono significative in quanto appartenenti a una data forma sociale. Il «doppio movimento» non esclude, dunque, che l’economia sia disembedded, ma ne è l’espressione, ed è condizionato dall’esigenza di riprodursi di tale forma sociale di economia: quindi del dominio di classe, della proprietà privata dei mezzi di produzione, della possibilità di ricavarne profitti e rendite. Esso dipende anche dalle alterne vicende – cioè dalla tendenza alla crisi – dell’accumulazione capitalistica. I successi del «contro-movimento» sono rimasti entro i limiti imposti da un’economia autonoma e dominante, cioè disembedded. Il rischio che tali limiti vengano superati provoca – secondo Polanyi, che visse il periodo rivoluzionario intorno alla Grande guerra, poi la Grande depressione e la diffusione del fascismo – una crisi dell’intero assetto istituzionale e una reazione antidemocratica, tanto più aspre quanto più gravi sono le difficoltà del sistema economico e più accesa la lotta di classe.
Il senso più profondo della concezione polanyiana della «utopia del mercato autoregolato» è che sia insostenibile un’organizzazione sociale la cui economia disembedded tenda a mantenere con il proprio ambiente umano e naturale un rapporto strumentale, autoreferenziale, quindi tendenzialmente distruttivo. Per questo, in questo senso e a questo livello egli auspica la reintegrazione dell’economia nella società. D’altra parte, in una conferenza del 1940 sull’argomento[32], egli denuncia «il dilemma in cui ci troviamo», fra l’esigenza di bloccare un sistema distruttivo e la difficoltà di farlo, poiché ne dipendiamo per la nostra sussistenza. Come se il «doppio movimento» fosse vincolato, preso in un «doppio legame».
Neoliberismo, ordoglobalismo
La divergenza teorica fra gli interpreti del pensiero di Polanyi corrisponde, ovviamente, a divergenti prospettive politiche. I sostenitori dell’idea dell’economia «sempre embedded»[33] confidano in un processo che la renda sempre più embedded, in direzione di una società più egualitaria e democratica, in cui l’intervento pubblico lasci il meno possibile in balia del mercato le «merci fittizie». Essi fanno riferimento al New Deal e al neo-corporativismo socialdemocratico del secondo dopoguerra e auspicano un congruo intervento dello stato. La «utopia del mercato autoregolato» viene, allora, riferita meramente al mito di un mercato tendenzialmente perfetto, in cui il meccanismo dei prezzi, lasciato a se stesso, risolverebbe ogni problema. Viene inoltre raccomandata la cura di quella specie di malattia ideologica o di deviazione etica che sarebbe il «fondamentalismo di mercato».
Anche il Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales (MAUSS)[34], così come le analisi e le iniziative favorevoli all’economia “sociale e solidale”, specialmente in Francia e Canada, e l’idea della “decrescita felice” partita da Serge Latouche hanno trovato ispirazione e sostegno in Polanyi. L’opposizione all’economicismo e all’utilitarismo, il perorare l’economia del dono e della convivialità al posto di quella di mercato sono encomiabili, specialmente nel sostenere organizzazioni alternative alla forma vigente di società. Tali iniziative, tuttavia, restano marginali. La critica dell’utilitarismo, a sua volta, resta incompiuta, illusoria, finché esso venga meramente inteso come un modo sbagliato di pensare, invece che come espressione di una realtà sociale organizzata “economicamente”, sulla base dell’ineludibile vincolo della valorizzazione: come chiaramente sostiene Polanyi. Anche Louis Dumont, peraltro antropologo di prim’ordine, autore dell’introduzione all’edizione francese di The Great Transformation[35], mantiene la critica nel regno delle idee e delle convinzioni etiche – delle «nebulose religiose» – cercando in tale direzione una conferma in Polanyi.
Esiste, tuttavia, una corrente minoritaria, benché recentemente rafforzata dalla constatazione che l’erosione della democrazia e la mancanza o la debolezza di alternative riformiste accompagnano la globalizzazione neoliberista. Essa interpreta la teoria di Polanyi nel senso di una “critica dell’economia politica” da accostare, non da contrapporre a quella di Marx. Wolfgang Streek fa riferimento in questo senso a Polanyi in un saggio in cui constata il dileguarsi delle illusioni e delle forze riformiste, e i circoli viziosi delle politiche neoliberiste. Egli teme che la mercificazione accentuata delle «merci fittizie» conduca il capitalismo a una «decadenza progressiva»[36], ma non necessariamente al superamento di esso.
Polanyi continua ad ispirare un numero crescente di articoli e libri sul destino delle «merci fittizie» in epoca neoliberale e sui tentativi di «contro-movimento». È naturale, dato il degrado delle condizioni del lavoro in un mercato globale in cui la circolazione è libera per i capitali, ma non per i lavoratori, e su cui incombono la tendenza alla crisi e la disoccupazione tecnologica. Note, drammatiche e finora vane sono, poi, le preoccupazioni per il disastro ecologico e la «grande finanziarizzazione»[37]. La conoscenza è stata aggiunta come quarta «merce fittizia»[38].
Un’attenzione minore è stata finora dedicata alla concezione politica di Polanyi[39]. La sua analisi della crisi del capitalismo liberale, nel corso della quale emerse la «incompatibilità fra capitalismo e democrazia», viene richiamata da David Harvey[40], a proposito dell’attacco neoliberale alla democrazia. Anche Quinn Slobodian[41] fa riferimento a Polanyi nella sua ben documentata e argomentata storia “lunga” del neoliberismo, a partire dal primo dopoguerra, cioè dalla crisi del capitalismo liberale e dall’esigenza di bloccare l’alternativa socialista. Non si trattava di ridurre al minimo l’intervento dello stato, ma semmai di ampliarlo e di inquadrarlo entro istituzioni sovra-nazionali per renderlo il più possibile funzionale alla libertà di circolare e alla possibilità di valorizzarsi del capitale a livello globale, proteggendolo, inoltre, dai rischi della democrazia e della decolonizzazione. Slobodian non rileva la corrispondenza di questa sua visione della storia del Novecento con quella di Polanyi, poiché tende a identificare il pensiero di Polanyi con le interpretazioni che lo riducono, come abbiamo visto, alla critica del «fondamentalismo di mercato».
NOTE
[1] Cit. da Wolfgang Streek, Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Verso, London 2014, p. 85.
[2] D. H. Meadows et al., The Limits to Growth, Universe Books, New York 1972. (I limiti dello sviluppo, Mondadori, 1972).
[3] K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974. Alfredo Salsano curò questa traduzione di un libro allora poco conosciuto nel mondo, ora tradotto in venti lingue. Salsano ha il merito di aver diffuso la conoscenza di Polanyi in Italia, pubblicandone le opere e ricostruendone intelligentemente il pensiero in diversi saggi. Cfr. p. es. A. Salsano, «La filosofia politica di Karl Polanyi», in AA. VV., Karl Polanyi, a cura di A. Salsano, Bruno Mondadori, Milano 2003.
[4] K. Polanyi, «La nostra obsoleta mentalità di mercato», in Id., L’obsoleta mentalità di mercato. Scritti 1922-1957, a cura di M. Cangiani, Asterios, Trieste 2019, p. 247.
[5] K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, a cura di H. W. Pearson, Einaudi, Torino 1983, p. 7.
[6] Traffici e mercati negli antichi imperi, Einaudi, Torino 1978.
[7] J. Ron Stanfield, «Institutional Economics and the Crises of Capitalism», Journal of Economic Issues, XI/2, 1977, pp. 449-460.
[8] M. Sahlins, L’economia dell’età della pietra, Bompiani, Milano 1980, in partic. p. 41. (Stone Age Economics, 1972).
[9] G. Dalton, «Economic Theory and Primitive Society», American Anthropologist, 63, 1961, pp. 1-25.
[10] G. Dalton, «Writings That Clarify Theoretical Disputes Over Karl Polanyi’s Work», Journal of Economic Issues, 24/1, 1990, pp. 249-261.
[11] R. H. Halperin, «Polanyi, Marx, and the Institutional Paradigm in Economic Anthropology», Research in Economic Anthropology, Vol. 6, 1984, pp. 245-272.
[12] Cfr. M. Godelier, «Economia», in Enciclopedia, vol. V, Einaudi, Torino 1978.
[13] Paul Veyne, Il pane e il circo, Il Mulino, Bologna 1984, p. 59. (Le pain et le cirque, 1976).
[14] Cfr. M. Weber, Storia economica, Donzelli Roma 1997, pp. 195-196.
[15] K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, cit., p. 32.
[16] La grande trasformazione, cit., p. 101.
[17] K. Polanyi, «Sulla fede nel determinismo economico», in Id., Una società umana, un’umanità sociale, a cura di M. Cangiani e C. Thomasberger, Jaca Book, Milano 2015, pp. 320 e 321.
[18] Porti franchi o “di tratta”; cfr. Traffici e mercati… e K. Polanyi, Il Dahomey e la tratta degli schiavi, Einaudi, Torino 1987.
[19] F. Braudel, I giuochi dello scambio, Einaudi, Torino 1981, p. 214.
[20] D. North, «Markets and Other Allocation Systems in History: The Challenge of Karl Polanyi», Journal of European Economic History, vol. VI, n. 4, 1977, pp. 703-716.
[21] K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Einaudi, Torino 1976, vol. I, p. 452.
[22] Thomas H. Marshall riprende la questione di tale distanza nel suo saggio del 1950, Citizenship and social class, citando il libro di Polanyi.
[23] «La nostra obsoleta mentalità di mercato», art. cit., p. 234.
[24] La grande trasformazione, cit., p. 74
[25] B. Malinowski, «The primitive economics of the Trobriand Islanders», The Economic Journal, XXXI, 1921, p. 7.
[26] W. C. Neale, «Reciprocità e ridistribuzione nel villaggio indiano», in Traffici e mercati…, cit., pp. 265-288.
[27] «Sulla libertà», in Una società umana, un’umanità sociale, cit., pp. 128-158.
[28] Cfr. p. es. S. Cook, «The Obsolete “Anti-Market” Mentality: a Critique of the Substantive Approach to Economic Anthropology», American Anthropologist, vol. 68, n. 2, 1966. Ripubblicato nel volume di consimile tendenza, Economic Anthropology: Readings in Theory and Analysis, a cura di E. E. LeClair Jr. e H. K. Schneider, Holt, Rinehart & Winston, New York 1968, pp. 208-228.
[29] M. Granovetter, «Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness», The American Journal of Sociology, vol. 91, n. 3, 1985, pp. 481-510.
[30] Un minimo riferimento: il volume curato da Sharon Zukin e Paul DiMaggio, Structures of Capital. The Social Organization of the Economy, Cambridge University Press, 1990. Inoltre, le opere di Viviana Zelizer.
[31] Cfr. G. Krippner et al., «Polanyi Symposium: a conversation on embeddedness», Socio-Economic Review, 2, 2004, pp. 114-115.
[32] K. Polanyi, «La tendenza verso una società integrata», in Id., Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958, a cura di G. Resta e M. Catanzariti, Il Saggiatore, Milano 2013, pp. 271-277.
[33] Cfr. F. Block and M. Somers, The Power of Market Fundamentalism. Karl Polanyi’s Critique, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2014. Questo libro, composto in gran parte da saggi precedentemente pubblicati dai due autori, è diventato un immancabile riferimento. Esso rispecchia d’altronde il punto vista della maggioranza degli interpreti di Polanyi. Cfr. p. es. gli articoli dichiaratamente “post-polanyiani” di diversi autori nel numero speciale di Economy and Society, vol. 43, n. 4, 2014. Inoltre, il volume curato da Chris Hann e Keith Hart, Market and Society. The Great Transformation Today, Cambridge University Press, Cambridge 2009. E quello curato da I. Hillenkamp e J.-L. Laville, Socioéconomie et démocratie. L’actualité de Karl Polanyi, Érès, Toulouse 2014.
[34] Pubblica dal 1981 la Revue du MAUSS.
[35] L. Dumont, «Préface», in K. Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, Paris 1983.
[36] W. Streek, «How Will Capitalism End?», New Left Review, 87, May-June 2014, pp. 35-64.
[37] From the Great Transformation to the Great Financialization (Fernwood, Halifax 2013) è il titolo del libro di Kari Polanyi Levitt, importante per la ricostruzione del pensiero di suo padre e della sua rilevanza attuale. A partire dai propri studi sui problemi e le teorie dello sviluppo, ella, inoltre, analizza la crisi presente del sistema capitalistico mondiale: la finanziarizzazione, certo, ma anche «l’emergere del Sud globale». A quest’ultimo tema è dedicato anche il saggio di Samir Amin, che chiude il libro.
[38] Alla questione è dedicata, p. es., una parte del volume che trae origine dalla decima Karl Polanyi Conference, tenutasi a Istambul nel 2005: Ayşe Buğra and Kaan Ağartan, eds, Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century, Palgrave Macmillan, New York 2007. Il Karl Polanyi Institute of Political Economy di Montréal sta organizzando il quindicesimo Convegno internazionale. Il primo ebbe luogo a Budapest nel 1986, centenario della nascita di Polanyi.
[39] Per una ricostruzione, dalla sua genesi a Budapest fino a La grande trasformazione, cfr. M. Cangiani e C. Thomasberger, «Introduzione. Costruire la libertà», in K. Polanyi, Una società umana, un’umanità sociale, cit., pp. 19-52.
[40] D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano 2007.
[41] Q. Slobodian, Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2018.
https://www.sinistrainrete.info/teoria/17169-michele-cangiani-quale-karl-polanyi.html
STORIA
QUANDO IL PADRE ERA SACRO
di Leandro Sperduti
La famiglia è stato il primo fondamentale organismo sociale della storia umana, non sorprende dunque che le civiltà e forme religiose si siano spesso ispirate ad essa e alle sue strutture fondamentali per la loro organizzazione e gestione interne.
Quasi tutte le più antiche culture mediterranee, sviluppatesi lungo i fiumi e fondate su un’economia agricola, erano caratterizzate da un sistema matriarcale e si riconoscevano nel culto preistorico di una grande madre tellurica, simbolo di fertilità, rigenerazione e protezione. Il potere, seppur amministrato sempre da uomini, era trasmesso per via matrilineare, come nel caso dei faraoni d’Egitto o dei sovrani micenei. Le cose mutarono però sensibilmente, almeno nelle terre sulla sponde settentrionale del Mediterraneo, a partire dalla fine del II millennio a.C., con l’arrivo delle genti definite genericamente indoeuropee.
Originari probabilmente delle regioni a nord del Mar Nero, questi popoli praticavano il seminomadismo ed erano dediti per lo più all’allevamento e alla pastorizia. Queste attività, che obbligavano gli addetti a lunghe permanenze lontano dalla comunità, spesso in completa solitudine, erano propriamente maschili perché svincolate dalla crescita della prole e dalla famiglia. A differenza delle genti agricole e stanziali, inoltre, i popoli indoeuropei collocavano i loro dèi nel cielo perché la loro presenza fosse costante qualunque fosse il paese in cui transitavano o si stabilivano. Queste divinità celesti dominavano la meteorologia e, in quanto apportatrici di pioggia, erano quasi sempre maschili per l’assimilazione dell’acqua fecondatrice allo sperma. Per le genti indoeuropee, la pratica della pastorizia e questa particolare visione del sacro si tradussero in una forma sociale fondata sul patriarcato e su un regime a dir poco fallocratico, dove la figura paterna riuniva in sé caratteri dominanti assoluti e perfino sacrali. Dalla radice pat-, atta probabilmente a designare la paternità, derivarono quei nomi che, nelle lingue storiche di ceppo indoeuropeo, passarono a indicare il padre (in latino páter, in greco patér, in gotico fadar, in persiano padar, in hindi pita, etc.). Nel giro di tre secoli, questi popoli nomadi apportatori del patriarcato irruppero con violenza sulle culture matriarcali del Mediterraneo portandone in molti casi l’assoggettamento o il totale annientamento.
Le genti latine, che tra tutti gli indoeuropei furono quelle che conservarono di più i loro caratteri culturali ancestrali, mantennero a lungo questo assolutismo paterno, cristallizzato nell’organizzazione gentilizia della società come nei precetti della religiosità tradizionale. La patria potestas rappresentò quindi il più assoluto e sacro dei poteri, fondato sul diritto naturale del genitore maschio e sulla sua facoltà dispotica. La figura del pater familias, com’è noto, era rivestita di una priorità giuridica, di un potere e di una sua sacralità intrinseca che travalicavano enormemente quanto sancito dal diritto naturale. Solo a lui spettava, oltre alla sovranità sulla famiglia, il riconoscimento dei figli, il diritto di venderli come schiavi e perfino di ucciderli, anche se queste eventualità erano più che altro valori formali e verranno spesso perseguite dalle leggi. Particolarmente importante era poi il suo diritto alla gestione del patrimonio, il cui nome deriva proprio dall’essere un dovere paterno (patrimonium da patris munus “compito del padre”). Questa dignità e sacralità era ben sancita già nel V sec. a.C. dalla più antica legislazione romana delle XII Tavole e si estrinsecava quotidianamente in tutta una serie di compiti e liturgie domestiche, dall’assegnazione delle consegne all’amministrazione dei riti religiosi a carattere privato famigliare. Perfino l’architettura della casa sembrava riflettere questa sovranità e sacralità, con il tablinium che era per il padre una sorta di sala delle udienze e la sella il suo trono. In quanto custode e signore della casa, la domus, il padre diveniva dunque un dominus, un “signore” e “padrone”, in una corrispondenza tra spazio fisico consacrato e figura preposta che era una delle caratteristiche più tipiche della civiltà romana. Col passare dei secoli l’aspetto sociale e giuridico si svincolò da quello naturale conseguente alla generazione dei figli e la patria potestas divenne un presupposto degli individui maschi di rango che, per la morte prematura del genitore, si trovavano a ereditarne i poteri; non era raro quindi imbattersi in bambini che fossero pater familias con potere sugli altri membri adulti della famiglia.
La funzione dominica e sacrale della figura paterna si rifletteva macroscopicamente sull’intera comunità e sullo Stato. Nei primi secoli della romanità, infatti, la persona del re assumeva in sé caratteri paterni su tutta la popolazione che era dunque governata sulla base di presupposti che si ispiravano a quelli della famiglia. Per la stessa ragione i membri anziani delle famiglie più antiche erano chiamati i patres e, riuniti nell’assemblea del Senato, costituivano l’organo politico più importante dello Stato romano.
In seguito la paternità simbolica del re andò scemando e scomparve completamente alla fine del VI sec. a.C., con la fine della monarchia. La sua funzione sacrale sopravvisse però all’interno di alcuni dei più antichi collegi sacerdotali, organizzati anche loro su modello gentilizio.
Un caso emblematico era quello del pater patratus (letteralmente “padre sancito”), una carica sacerdotale romana documentata però anche per la comunità di Alba Longa. Era questi il più importante dei sacerdoti feziali, cui era affidato il compito esclusivo di stipulare i trattati con le altre popolazioni ma anche quello di procedere direttamente e ritualmente alla dichiarazione di guerra contro di esse. Pare, anzi, che fosse proprio lui a piantare in territorio nemico la cosiddetta lancia bellica, compiendo l’atto formale che dava inizio alle ostilità. Questo diritto gli derivava dal fatto di esser simbolicamente il padre religioso di tutti i cittadini e dunque di poter parlare in nome di Roma, secondo un diritto che era stato in origine del re. È interessante notare, inoltre come la stessa parola latina che indica la conclusione rituale o sanzione di un accordo, patrare, derivi anche lei dalla radice pat- di padre, un elemento che le dava evidentemente forza sacra e giuridica.
La sacralità assoluta e fatale della figura paterna tornò a essere ribadita nel I secolo con l’avvento dell’impero, quando la struttura del nuovo potere sembrò ispirarsi ancora una volta al modello della struttura famigliare tradizionale. Per questo Augusto, che certo fece del recupero dell’identità latina uno dei fondamenti della sua idea di stato, assunse su di sé, oltre alle altre cariche politiche e istituzionali, anche il prestigio derivante dalla suprema patria potestas e, nel 2 a.C., fu salutato dal Senato come pater patriae. Da questo momento, dunque, l’imperatore romano avrebbe rivestito in sé tutti i poteri conferitigli dalle diverse magistrature, ma santificati da quello assoluto e naturalmente sacro del padre. Va sottolineato che, dopo di allora, diversi altri imperatori assumeranno la paternità della patria ma sempre su conferimento da parte del Senato, cioè degli altri “padri istituzionali”.
A partire dal II secolo, con la provincializzazione dell’impero, alcuni istituti e caratteri tradizionali della romanità subirono l’influenza delle culture orientali e vennero svuotandosi di molti dei loro significati arcaici; non fu però così per quelli che interessavano la figura paterna nel suo valore religioso. Anzi, alcune dottrine di origine anch’esse indoeuropee sembrarono perfino rinforzarne la sacralità e l’assolutismo. È il caso, ad esempio, del mitraismo, un culto originato probabilmente in Asia Minore su presupposti di natura iranica. Esso era fondato sulla venerazione di Mitra, un dio persiano minore preposto all’osservanza dei patti (torna dunque il concetto latino del patrare) e figlio del grande dio solare Ahura Mazda. I caratteri di questa religione, che si diffuse enormemente in quasi tutto l’impero romano e rimase attiva per almeno tre secoli, ci sono ancora in parte sconosciuti, ma è certo che essa fosse riservata ai soli maschi adulti e che, al suo interno, fosse organizzata in una rigida gerarchia con regole di ispirazione famigliare. Ogni comunità di fedeli, infatti, contava poche decine di individui e aveva al suo vertice una figura sacerdotale e carismatica cui era conferito il titolo di pater. Questi rivestiva il suo ruolo a vita, era il solo di cui risultava il nome nelle dediche, cui spettava il diritto di accogliere i fedeli all’interno della comunità, celebrare i riti e consacrare i luoghi di culto. La sua carica era posta sotto la protezione di Saturno, il dio padre di Giove cui era attribuito il merito di aver governato il mondo durante la mitica età dell’oro, quando gli dèi, gli uomini e gli animali vivevano insieme in una perenne pace e beatitudine. Il pater mitraico, dunque, era un autentico garante del bene e dell’ordine, un benevolo genitore custode dei riti e guida della comunità. In alcune iscrizioni votive il suo nome è accompagnato dalla epiteto di pater patrum (“padre dei padri”) o addirittura da quello arcaico di pater patratus (entrambi abbreviati in p.p.) in riferimento ai patti sacri cui era preposto originariamente il dio Mitra.
Come molti altri precetti rituali del mitraismo, anche questa funzione prioritaria del padre passò al cristianesimo fino a metterne in ombra alcune tendenze matriarcali che fin dai suoi primi secoli erano parse affermarsi, soprattutto in occidente. Anche nella nuova religione si costituirono dunque comunità di fedeli a capo delle quali si posero figure maschili cui era riservato l’esercizio del culto e a cui era riconosciuta un’autorità simile a quella del pater mitraico. Il caso senza dubbio più emblematico è quello della Chiesa di Roma, il cui vescovo assunse quelli che in precedenza erano stati alcuni titoli sacerdotali pagani, tra cui quello di pontefice massimo, o quello ancor più discusso di papa, usato a partire dal V secolo. È opinione comune che esso derivi proprio dall’abbreviazione p.p. di pater patrum e sia dunque un’eredità mitraica, anche se nel medioevo si pensava addirittura che fosse un acronimo della frase Petri Apostoli Potestatem Accipiens (“Avente il potere dell’apostolo Pietro”), con cui si intendeva ribadire il primato della Chiesa Romana. È ben più probabile, invece che esso derivi dalla parola greca πάππας, usata famigliarmente per indicare proprio la figura paterna, e derivante a sua volta dal semitico happa. Il suo uso religioso cristiano si trova per la prima volta nel De Pudicitia di Tertulliano per designare genericamente la persona del vescovo, e sopravvive ancora in Oriente nel nome pope dei sacerdoti ortodossi. Nella forma habba il titolo paterno si ritrova anche nelle comunità monastiche del Sinai per indicare il monaco anziano posto a capo del cenobio e a cui si doveva obbedienza (da cui il termine latino abbas “abate”). L’uso della parola papa come attribuzione del vescovo di Roma si trova invece già in una lettera di papa Siricio (384-399) ed è ribadito dallo scrittore ecclesiastico Ennodio in una sua epistola a papa Simmaco (498-514). Nella nomenclatura attuale, del resto, la si ritrova nel titolo “Santo Padre” usato specificatamente per il primate della Chiesa Cattolica Romana.
Dunque l’autorità paterna sembra essere stata, almeno nel mondo occidentale, una garanzia di potere assoluto e sacralità che, fin dalla protostoria e senza soluzione di continuità, ha accompagnato lo sviluppo di alcune delle più grandi civiltà e forme religiose per tutti i secoli della loro storia, costituendone senza dubbio uno dei caratteri e presupposti più importanti.
(Articolo comparso su “Tempi” XXIII, 34, Agosto 2017)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



