
RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI
Speciale PAUPERISMO – 28 SETTEMBRE 2021
A cura di Manlio Lo Presti
Esergo
Gli italiani prima hanno perso la guerra, poi hanno perso la pace
TOTÒ, Mal comune mezzo gaudio, Rizzoli, 2017, pag. 27
https://www.facebook.com/dettiescritti
https://www.instagram.com/dettiescritti/
Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.
I numeri degli anni precedenti della Rassegna sono disponibili sul sito www.dettiescritti.com
Precisazioni legali
www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com
Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.
Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com
La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SOMMARIO
Il climatismo. Ideologia di sottomissione e povertà.
Custodi dell’ambiente
Pauperismo: riflessioni su complessità ed emergentismo
La differenza tra il pauperismo e la povertà cristiana
Estinzione del Welfare State
Gas: le società tedesche iniziano a tagliare i contratti ai clienti
Ma la retorica pauperista non aiuta i poveri
pauperismo
Pauperismo
Crisi energetica: aziende forzatamente in ferie in Cina
Economia ecologica: signoraggio, debito pubblico, tasse…
Pauperismo o populismo digitale?
Pauperismo attraverso i secoli
IN EVIDENZA
Il climatismo. Ideologia di sottomissione e povertà.
Roberto PECCHIOLI
Nella temperie fulminea dei cambiamenti di questi anni frenetici, svolge un ruolo centrale una narrazione ripetuta sino allo sfinimento, creduta per bombardamento mediatico: l’ideologia del cambiamento climatico. Come insegnò Carl Schmitt, le ideologie sono concetti teologici secolarizzati e nel caso del “climatismo” (il termine fu coniato nel 2015 da Mario Giaccio) ciò è assolutamente evidente. E’ un’autentica fede religiosa, con i suoi riti (le conferenze internazionali periodiche), i suoi fedeli e discepoli, i suoi sacerdoti – scienziati e militanti – una Gran Sacerdotessa, Greta Thunberg, dal linguaggio apocalittico, il volto imbronciato e il tono ansiogeno. La divinità a cui prestare culto, femminile come prescrivono i tempi, è Gea, la terra, organismo senziente il cui nemico è l’homo sapiens.
I banditori non sono profeti disarmati o apostoli, ma i livelli alti del potere economico, finanziario e scientifico, che ha imposto la nuova ideologia nell’ambito di piani di dominio a lungo termine (Grande Reset, Agenda 2030) nascosti dietro la doppia cortina del cambiamento climatico e della transizione energetica, che ha già reso carissime le bollette elettriche e del gas.
Rispetto al passato, vi è un cambiamento di non poco conto: prima si parlava di riscaldamento globale, oggi i padroni delle parole hanno ripiegato sul più generico cambio climatico. In ogni caso, non si esce da un’ideologia il cui principale cortocircuito riguarda il ruolo della specie umana. Il dogma indiscusso, infatti, è l’origine antropogenica del cambiamento climatico del pianeta. E’ l’uomo, con la sua volontà di potenza, il predatore responsabile dello squilibrio naturale. Fin qui, nulla da eccepire: tesi proclamate da più parti senza successo.
La contraddizione è chiara: se il clima cambia, la ragione non sta nei cicli della natura, bensì nell’esclusiva opera dell’uomo. E’ un peccato di hybris, la dismisura invisa ai greci. Gea fa i capricci o semplicemente segue il suo cammino epocale? No, il responsabile è l’uomo. Con arroganza e volontà di potenza uguale e contraria, la religione climatica offre la soluzione: sia l’uomo a modificare Gea, a interrompere e ribaltare il cambiamento, attraverso la declinazione ecologica e “sostenibile” della tecnologia. La tecnica e la scienza umana restano i Demiurghi, gli strumenti di un Dio minore ma non troppo, l’Homo sapiens riconfigurato in alleato di Gea.
Il climatismo è volontà di potenza mascherata dalla proclamata bontà dei suoi obiettivi. Sarà l’Uomo a cambiare il corso del clima terrestre attraverso comportamenti, condotte, modelli di sviluppo che placheranno l’ira di Gea. A livello simbolico, è una captatio benevolentiae, il tentativo di farsi amica una potenza superiore, con la quale dialoghiamo da pari e pari. Sempre Prometeo, sempre Titano al potere, con la differenza che adesso non sfida più la collera degli dei, ma se ne fa alleato.
Il primo baco dell’ideologia climatica è l’impossibilità di verificarne – al tempo delle verità scientifiche- la veridicità. E’ infatti impossibile affermare o negare che il pianeta si stia riscaldando o raffreddando a lungo termine. Comincia ad ammetterlo lo stesso IPCC (International Panel for Climate Change, Gruppo Internazionale sul Cambiamento Climatico), foro mondiale creato nel 1998. Nonostante la tesi di fondo resti quella del cambiamento del clima, confortata da decenni di osservazioni e rilevamenti, l’IPCC ha concluso che “nella ricerca e creazione di modelli climatici, dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte ad un sistema caotico, e quindi la previsione a lungo termine degli stati climatici futuri non è possibile”. La ragione scientifica è che i modelli matematici complessi utilizzati non sono in grado di calcolare le infinite variabili del sistema. Anche il comportamento delle temperature future in riferimento alle emissioni di CO2 non è previsibile se non con approssimazione. Le previsioni meteorologiche restano affidabili entro l’arco temporale di quindici giorni. Per il resto, vale la regola dei nostri nonni: sotto i nostri cieli farà caldo in estate, freddo in inverno e in autunno pioverà.
La metodologia della predizione climatica soffre di un difetto irrimediabile che dimostrò sessant’anni fa Edward Lorenz, le infinite piccole variazioni nelle condizioni iniziali che rendono inaffidabile l’esito finale. L’atmosfera – scoprì – è un sistema deterministico caotico, dando inizio alla Teoria del Caos. Il calcolo determina una strana curva arricciata, a farfalla, di lunghezza infinita, detta attrattore di Lorenz. Di tutte le soluzioni matematiche finali, una sola è vera, ma ignota. E’ popolare la semplificazione detta effetto farfalla, dal celebre l’articolo di Lorenz intitolato Predittività: può il battito d’ali di una farfalla in Brasile determinare un tornado in Texas? Gli scienziati più seri parlano di probabilità, non di certezze. Le fedi come il climatismo, però, non conoscono sfumature. Il cambiamento climatico, per i suoi devoti, è certo, va nella direzione del riscaldamento globale ed è dovuto non a fattori naturali ignoti, ma all’azione umana.
Anni fa si diffuse l’acronimo LOHAS, (Lifestyle of Health and Sustainibility) stile di vita salutare e sostenibile. Oggi il fenomeno è diventato di massa, appoggiato da un gran numero di accademici, attori, politici, giornalisti, manager. Lo stile LOHAS rappresenta le più elevate classi sociali, domina i media e il dibattito politico. Incarna lo spirito dell’epoca e inclina a sinistra. Lontani i tempi in cui i partiti di sinistra volevano dare redditi migliori e opportunità ai più poveri. Oggi, solo l’élite progressista può permettersi viaggi costosi, mentre fa lucrosi affari con le lobby del clima. Per loro, il climatismo genera un doppio vantaggio. Possono elevarsi al di sopra della massa moralmente e materialmente: la folla proletarizzata viaggia in metropolitana, in bicicletta o su affollati treni di prossimità, loro si muovono in eleganti auto elettriche sovvenzionate dalle tasse di tutti. È la nuova morale, incurante che le batterie al litio della nuova mobilità siano frutto di attività estrattive di enorme impatto ambientale e dai drammatici costi umani (sfruttamento, salute, condizioni di lavoro).
Il secondo pilastro su cui si regge la politica climatica, dopo la dogmatica della colpa umana, è il ricatto della mancanza di alternativa, che sfocia nella proclamazione dell’emergenza. Lo stato di eccezione- lo verifichiamo con la dittatura sanitaria epidemica- esige sottomissione, che realizza combinando la paura della catastrofe con il timore di essere espulsi se non si è “fedeli alla linea” e la punizione per chi non si dichiara adepto della nuova fede. Funziona: crea vittimismo, conformismo e indignazione contro un potere “cattivo”, finalmente smascherato dai “buoni”, manipolati dai burattinai con consumato cinismo.
Annunciare la catastrofe non basta: bisogna che il messaggio sia incessante, caricato di urgenza e di paure sempre rilanciate. Ogni dubbio va combattuto costantemente su un ampio fronte. Funziona perché è stato creato un apparato di migliaia di funzionari “climatici” a tempo pieno nelle ONG, in fondazioni, agenzie, istituti di ricerca, autorità pubbliche, imprese, chiese e ovviamente nelle redazioni giornalistiche.
I lobbisti verdi, generosamente finanziati dai governi e dalle fondazioni private, tutte controllate da straricchi, primi responsabili dei guai ambientali, hanno una salda presa su tutto ciò che accade. E’ il potere di Fridays for Future, Amici della Terra, Greenpeace, WWF.Siamo investiti da un’informazione permanente a senso unico nei media pubblici e privati. Gli scettici – detti spregiativamente negazionisti come tutti coloro che dissentono dalle narrazioni imposte – non hanno praticamente alcun sostegno finanziario e diventano invisibili. Lo spirito del tempo verde è sacrosanto e onnipresente.
Nessuno è disposto a impegnarsi in un dibattito sulle incertezze della ricerca e dell’impatto sul clima, sui molti modi per affrontare il cambiamento climatico o sull’equilibrio tra costi e benefici. Nessuno riconosce pubblicamente che l’obiettivo di essere “climaticamente neutri” nel 2045 o nel 2050, è una fissazione arbitraria. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare.
Un quotidiano liberal, la Frankfuerter Allegemeine Zeitung, ha scritto: “i bilanci degli Stati sono importanti poiché superarli significa superare la temperatura della terra, che provoca danni irreversibili, cioè cambia il clima per sempre.” Il bilancio in questione riguarda un’altra credenza “per fede” della narrazione verde, la quantità di CO2. L’assurdo è che la Germania per raggiungere zero emissioni e limitare il riscaldamento globale a 1,75 gradi, può emettere in totale a 6,7 gigatonnellate sino al 2029, la metà della quantità annua cinese!
Per il fisico Matthew Crawford “una delle caratteristiche più sorprendenti è che siamo governati da tattiche intimidatorie inventate per ottenere il consenso del pubblico. Alle sfide politiche dei critici, presentate con fatti e argomenti, non si risponde in modo amichevole, ma con la denuncia. Quindi, minacce epistemiche per risolvere l’autorità in un conflitto morale tra buoni e cattivi”. Vale non solo per il clima, ma anche per la dittatura sanitaria e ogni altro punto dell’agenda oligarchica. E’ il meccanismo che permette alla narrativa della “catastrofe climatica da evitare con urgenza” di diventare la base permanente di politiche lontane dalla realtà.
Infatti, dopo quasi 30 anni di politica di protezione del clima, il vento e il sole forniscono in Europa circa il 6,5% dell’energia. Nessuno crede che raggiungeremo il 100 per cento di energia rinnovabile in 25 anni. In compenso spenderemo enormi somme di denaro fingendo che sia così. Il conto, lo attestano le bollette energetiche, è a carico nostro. Circa l’84 per cento dell’energia mondiale continua a provenire da fonti fossili. Venticinque anni fa era l’86. Si prevede che potrebbe scendere al 73 entro il 2040, lontanissimo dallo zero.
Il calo delle emissioni tedesche negli ultimi dieci anni è stato di 200 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo, la Cina ha aumentato le sue di 3 miliardi di tonnellate. L’inquinamento è trasferito da un’area all’altra di Gea, l’unico pianeta disponibile, come ripetono le anime belle.
Il cinque per cento dell’umanità ha un livello di ricchezza per il quale un sacrificio in cambio della piacevole sensazione di salvare il pianeta sembra un buon affare. L’altro novantacinque non è convinto che l’energia, gli alloggi, i viaggi, il cibo siano troppo a buon mercato e debbano diventare sempre più costosi. Siamo di fronte a un’egemonia culturale dell’allarmismo climatico senza alternative. I giovani sono educati nella minaccia di una catastrofe incombente. Se un politico affermasse che il cambiamento climatico è sì una sfida, ma che il mondo ha problemi più urgenti, penseremmo che è pazzo. La ricerca sul clima, che produce ogni giorno nuove scoperte e crea un panorama sempre più differenziato, è in gran parte ignorata. Rimane una sola politica: quella della paura.
Scienza significa valutare i dati, cercarne di nuovi ed essere pronti a esaminare ipotesi e prove con salutare scetticismo. L’ evidenza empirica può essere manipolata o utilizzata per mascherare l’ideologia e creare consenso a sostegno di tesi e ipotesi care al potere, lo stesso che finanzia le ricerche, sceglie e paga chi le esegue. Scienziati se supportano la volontà dei potenti, ciarlatani, negazionisti e ignoranti se si oppongono o chiedono chiarimenti.
La tendenza al riscaldamento globale e la sua natura sono messe in dubbio. Non molto tempo fa, esisteva consenso su una tendenza al raffreddamento a lungo termine delle aree terrestri del Nord America. Le affermazioni di consenso scientifico sul riscaldamento antropogenico non sono prive di controversie, ma nell’era dei divieti e delle verità di Stato non è più sorprendente che la versione ufficiale sia imposta punendo per via giudiziaria le opinioni dissenzienti.
Eppure il metodo scientifico prescrive di osservare, formulare ipotesi, prevedere, testare, analizzare e rivedere. La conferma sperimentale non può stabilire verità assolute poiché i test futuri potrebbero invalidare la teoria. In quanto tali, tutte le teorie sono provvisorie e soggette a revisione se appaiono prove migliori o contrarie. Piuttosto che applaudire la versione ufficiale, dovremmo celebrare l’incertezza e l’apertura alla base della scienza. L’ideologia fideistica del climatismo vuole che gli scettici vengano messi a tacere, perseguiti per crimini inseriti ex novo nei codici penali. Nel frattempo, l’insistenza sul “consenso scientifico” circa la natura e le cause dei problemi orienta i finanziamenti e le proposte di ricerca verso coloro che promuovono la visione dominante.
La regola è “follow the money”, segui il denaro. I finanziamenti affluiti a chi indaga sul cambiamento climatico hanno superato nel 2017, nei soli Usa, i 13 miliardi di dollari. La spesa totale per gli studi sul clima tra il 1989 e il 2009 ha raggiunto i 32 miliardi, più altri 79 in ricerca tecnologica e agevolazioni fiscali per energia verde. La perdita di sussidi e posizioni di potere sarebbe enorme se il riscaldamento globale o il cambiamento climatico fossero messi in dubbio, magari per le ragioni esposte riguardo la complessità e le infinite variabili.
Mentre la complessità del clima rende difficile valutare con precisione le tendenze, sembra che esistano meccanismi interni tendenti a stabilizzare, entro certi limiti, temperature e variazioni climatiche. Ad esempio, le nuvole e il vapore acqueo svolgono un ruolo dominante nel determinare le temperature globali medie. Ma non c’è un’idea chiara sulla risposta delle nuvole al riscaldamento attribuito a progressivi aumenti dell’anidride carbonica nell’atmosfera.
Le argomentazioni scientifiche sui cambiamenti climatici sono il fulcro delle imminenti politiche di “azione per il clima” nell’ambito del Grande Reset, la sedicente necessità dello sconvolgimento dell’economia globale. Le restrizioni alla libertà e all’attività privata imposte dai governi per la pandemia di Covid-19 sono probabilmente l’antipasto dell’espansione del controllo politico e tecnologico per affrontare il cambiamento climatico.
L’IPPC annunciò nel 1990 un “codice rosso” basato su vari fattori, tra cui l’aumento “irreversibile” del livello del mare. Sussistono prove dell’innalzamento del mare, ma interpretazioni alternative suggeriscono che l’effetto potrebbe essere di 3 pollici in un secolo, un tempo sufficiente per le contromisure. Il dibattito, invece, tende a enfatizzare il tono allarmistico, la scienza si fa ancella del potere. L’ esito è un neo feudalesimo in cui il dominio diventa assoluto, con la maggioranza ridotta a servi della gleba impoveriti per “buone cause”, narrazioni che si fanno fede: il climatismo, la sanitarizzazione della vita, nemiche della libertà e della prosperità. Leggiamo le nostre bollette e sarà chiaro: nessun concetto astratto o lontano, ma vita – e fregatura – quotidiana.
FONTE: https://www.maurizioblondet.it/il-climatismo-ideologia-di-sottomissione-e-poverta/
ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME
Custodi dell’ambiente
28 MARZO 2013
Il simbolismo pauperista ha conquistato gli italiani. Partiamo da qui. Negli ultimi tempi abbiamo potuto osservare Papa Francesco e lo stile neo-francescano e deputati italiani che salgono al Quirinale a piedi. Chiaramente il simbolismo è importante, ma quando cessa di avere un significato reale e diventa un esercizio di marketing a fini elettorali o propagandistici? Non la si prenda come una critica a chi usa i piedi per andare al Quirinale anzichè un’auto blu, ci mancherebbe. È un discorso molto più generale, sulla crescente esposizione di simboli pauperisti e sul loro utilizzo ad hoc, spesso fuori bersaglio, delle ultime settimane.
Parte uno: energia e povertà. Pochi giorni fa un articolo di The Oil Drum commentava il miglioramento delle condizioni di vita in India, dove fino a pochi decenni fa una larga parte della popolazione viveva in condizione di povertà disperata. Un po’ come in tutti i paesi del mondo, la transizione indiana è avvenuta grazie alla industrializzazione su larga scala del paese. Fondamentale è stato l’impiego di grandi quantità di energia e risorse naturali per la crescita continua del settore produttivo industriale. Tutto bello? Non proprio. Purtroppo i limiti fisici di approvvigionamento e accesso all’energia stanno causando non pochi problemi alla crescita indiana. Semplicemente detto, la rete elettrica indiana è fatiscente e non regge il carico crescente per l’aumento dei consumi. Il risultato è la generazione continua di black-out che rendono difficile gestire un qualsivoglia business in condizioni ottimali (i periodi di interruzione della corrente arrivano fino a 14 ore). La situazione è così critica che in alcuni luoghi i black-out sono entrati a far parte della quotidianità, con tutto ciò che ne consegue.
L’India è dunque alla disperata ricerca sul mercato di combustibili fossili per soddisfare il crescente fabbisogno energetico interno. A complicare le cose vi è il fatto che l’India è da tempo il più grosso acquirente di petrolio iraniano, tanto che le raffinerie indiane sono progettate per ricevere e lavorare il greggio iraniano, oggi oggetto di sanzioni internazionali. L’altro combustibile da cui l’India è dipendente è il carbone, di cui il paese possiede grandi riserve ma il cui sfruttamento non riesce a tenere il passo con l’incremento della domanda. Di conseguenza, l’India si trova a dover ricorrere sempre più all’importazione di carbone per usi termici e metallurgici con tutte le dipendenze dall’estero che questo comporta. Senza perderci nella geopolitica, le cose si riducono a questo: niente energia niente industrializzazione, niente industrializzazione niente miglioramento delle condizioni di vita (sanità migliore, scuole migliori, strade più sicure, pensioni più alte, eccetera). In altri termini, ed è il segreto di Pulcinella, senza disponibilità di energia e risorse naturali il meccanismo della crescita dell’economia produttivista moderna s’inceppa.
Parte due: Papa Francesco e il pauperismo francescano.
Vorrei chiedere, per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo.
Questo è uno dei primi discorsi di Papa Francesco dopo la sua elezione. Sostenitore dello stile neo-francescano, semplice e umile, il nuovo Papa ha saputo già guadagnarsi un larghissimo favore in credenti e fedeli, assieme a una buona quantità di lodi sperticate. Il neo-pauperismo papale è stato raccolto da un mondo in grave crisi economica con gran fervore e bisogno ma con scarso spirito critico e, almeno fin qui, con altrettanto scarsi elementi fattuali. L’incitazione a farsi “custodi dell’ambiente” di Papa Francesco fa infatti molto politically correct ma poco altro. Primo perché distingue chi ha “ruoli di responsabilità” da tutti gli altri, uomini e donne di buona volontà, quasi accettando passivamente una distinzione del mondo tra “noi” e “loro”, tra chi ha in mano le leve del potere e chi non le ha. La conseguenza implicita è una certa indulgenza all’auto-assoluzione per quegli uomini e donne di buona volontà che non occupano posizioni di responsabilità. Insomma, niente potere liberi tutti. Come se per vendere l’auto e andare a piedi servisse il permesso del direttore generale. Secondo perché è ovvio che ognuno ha a cuore l’ambiente attorno a sé, governanti inclusi, a meno di non abbandonarsi alla logica del siamo tutti peccatori, logica per la quale l’opportunità fa l’uomo ladro e che individua i maggiori peccatori in coloro che occupano ruoli di responsabilità (i ricchi, in pratica). Davvero a Dio importa quanti soldi ognuno ha sul conto bancario? Terzo, l’incitazione ad assumere uno stile di vita pauperistico nell’accezione comune si traduce in una esortazione papale ad accontentarsi di poco, a non esagerare, a essere dunque “custodi della natura” consumando di meno. Come se per una mucca d’allevamento o un pollo da batteria facesse una qualche differenza se m’accontento di acquistare un hamburger al supermercato invece che comperarne due. E come se l’aereo per volare in Brasile e partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù non fosse alimentato della stessa benzina o cherosene degli aerei per andare in ferie a Formentera.
Nel proclamarsi davvero seguace della dottrina di San Francesco, il Papa non potrebbe esimersi dallo schierarsi *apertamente* contro l’assioma fondamentale dell’economia moderna produttivista, e cioè che le risorse naturali sono lì per essere prese dall’uomo e trasformate in benessere umano. Assioma tutto umano, non privo di risvolti etici, che nella moderna società produttivista oggi tutti danno per scontato. Petrolio e inquinamento a parte, davvero si pensa che le mucche da cui vengono prodotti gli hamburger siano felici di passare la loro vita in un recinto di due metri quadrati aspettando la macellazione? Ovviamente una dichiarazione del genere equivarrebbe a mettersi contro l’intero sistema economico mondiale. Vallo a dire a un venezuelano, un argentino o un brasiliano – i cui capi di stato erano presenti all’elezione di Papa Francesco – che trivellare petrolio non è esente da implicazioni etiche e che il mondo non ruota attorno al bisogno umano, cosa che San Francesco predicava ma che la Chiesa Cattolica ben si guarda da fare da almeno dieci secoli. Semplicemente detto, la dottrina di San Francesco stabiliva che l’uomo non è al centro del creato come normalmente si interpreta dalla Bibbia, e che all’ambiente va portato il medesimo rispetto che portiamo a noi stessi. Per San Francesco, la scelta della povertà non rappresentava tanto un atto di rinuncia, quanto uno spogliarsi delle cose materiali prive di significato vero. Se questo vuol dire rinunciare a iPod, Facebook o volare in Brasile, beh, davvero scambiare commenti in tempo reale sulla fetta di torta che avete mangiato ieri mattina aggiunge un significato imprescindibile alla vostra vita? Così avrebbe risposto San Francesco.
Parte tre: decrescita pauperista. Inevitabilmente qualcuno ha tentato di etichettare il nuovo Papa come grillino o decrescista. Gira in metrò, non ha la croce d’oro, ha il pulmino, la chiesetta, paga il conto dell’hotel, eccetera. Questi tentativi derivano dal recente successo elettorale del Movimento 5 Stelle che ha portato all’attenzione dei media i temi economici e ambientali della decrescita. La recente partecipazione a Ballarò di Maurizio Pallante, fondatore del Movimento della Decrescita Felice, ne è la dimostrazione plastica. Sulla decrescita questo blog ha già dato. Certo è che, nonostante il successo elettorale del Movimento 5 Stelle, le ricette economiche della decrescita risultano ancora incomprensibili ai più – i balbettii e le imprecisioni di Pallante a Ballarò non hanno certo aiutato – con l’inevitabile risultato di tradurre la decrescita in una sorta di medioevalismo immiserito e utopico. Trainati dal successo di Grillo, un po’ tutti i partiti hanno rilanciato la green economy a colpi di sostenibilità. Peccato che la declinazione di sostenibilità usata dalla politica poco o nulla abbia a che vedere con l’ambiente e si riferisca invece alla sostenibilità per le finanze pubbliche.
Il punto che Pallante non riesce a chiarire è che la decrescita semplicemente non può essere perseguita nel sistema economico produttivista moderno, figlio dell’antropocentrismo social-economico-religioso per cui l’uomo è autorizzato in qualità di re del creato a possedere e disporre liberamente di terre, animali, vegetali e minerali, come meglio preferisce. Come detto, questa è una scelta di carattere etico, certamente quella adottata ma non l’unica, per la quale vendere una vacca al mercato è assolutamente normale ma vendere uno schiavo allo stesso mercato è moralmente inaccettabile. Semplicemente, la società (e l’economia) moderna accetta questa separazione perché a noi va bene così: la mucca non protesta (ma le mucche protestano?), viene macellata e trasformata in hamburger con le cui tasse dalle attività correlate si costruiscono le scuole. Tutti contenti, mucche a parte.
Conclusione. Ecco, forse a questo punto lo avrete capito, farsi custodi della natura inteso come opporsi alla costruzione di centrali a carbone non sposta poi molto del rapporto antropocentrico moderno tra uomo e natura, almeno non finchè fedeli e non fedeli continueranno ad alimentare loro malgrado il sistema economico produttivista basato sullo sfruttamento intensivo e sistematico dell’ecosistema terrestre. Anche abbracciassimo tutti il pauperismo papale e consumassimo meno, l’aumento del numero di persone porterebbe comunque il sistema a incocciare i limiti fisici. Per ergersi davvero a “custodi della natura” in ossequio al ruolo che compete loro, Papa Francesco e il Vaticano non potrebbero che schierarsi apertamente contro la possibilità da parte dell’uomo di possedere le risorse naturali. Questo equivarrebbe niente meno che a un nuovo viaggio verso la terra promessa sulle orme di Mosè, che trentacinque secoli fa rifiutò l’iniquità dell’etica umana del tempo che considerava normale la schiavitù del suo popolo e attraversò il deserto. Senza la ridefinizione del concetto di risorsa naturale nell’economia moderna, parlare di ambiente, sostenibilità e superamento dell’economia tradizionale è niente più che un pio desiderio, con buona pace di Pallante, decrescisti e custodi dell’ambiente.
Qualcuno deve cominciare
Questo articolo sarà letto da decine di migliaia di persone: perché è ben scritto, pensiamo, ma anche perché è gratis. Per essere gratis per tutti, per aiutare tanti a capire le cose e farsi un’idea corretta, serve il lavoro del Post e qualcuno che lo sostenga. Se ti abboni al Post, tu da solo contribuisci a far leggere i suoi articoli a migliaia di persone. Vedrai che un po’ alla volta si convinceranno anche loro.
FONTE: https://www.ilpost.it/filippozuliani/2013/03/28/custodi-dellambiente/
CULTURA
Pauperismo: riflessioni su complessità ed emergentismo
INDICE DEGLI ARGOMENTI:
Pauperismo: dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri
Pauperismo: una nuova immagine del povero
Pauperismo: una nuova analisi scientifica
Pauperismo: dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri
 Come tutti i fenomeni emergenti, anche il pauperismo non è pienamente “controllabile”, in quanto non semplicemente un “micro- fenomeno emergente” isolato, bensì rientrante in un sistema complesso – quello sociale e della mente umana – che evolve nel tempo, dotato di imprevedibilità e origine dal basso.
Come tutti i fenomeni emergenti, anche il pauperismo non è pienamente “controllabile”, in quanto non semplicemente un “micro- fenomeno emergente” isolato, bensì rientrante in un sistema complesso – quello sociale e della mente umana – che evolve nel tempo, dotato di imprevedibilità e origine dal basso.
Il pauperismo è un fenomeno associato alla globalità di un sistema complesso che impone vincoli alle parti, non è altro quindi in definitiva che il risultato dell’azione vincolante di un’organizzazione sistemica, pertanto riducibile ma non del tutto eliminabile (Morin).
Il pauperismo agli inizi della rivoluzione industriale è un fenomeno molto diffuso, se si pensa che nella sola Inghilterra circa il 25% della popolazione nel XVIII secolo era in stato di povertà.
La situazione cominciò a modificarsi con la rivoluzione industriale sebbene non vi sia una concordanza sui suoi effetti immediati in termini di ricchezza distribuita sulla popolazione a cavallo del secolo.
Le consuetudini vennero meno a partire dalla seconda metà del ‘700 e solo l’intervento legislativo sociale a partire dalla metà del XIX secolo permise la creazione di un nuovo status sociale per le classi più povere.
All’inizio il culto del lavoro porta ad una visione negativa del pauperismo quale causa di debolezza nazionale, con interventi di carattere punitivo quali le case di lavoro e l’esclusione automatica dei poveri da ciò che era puramente necessario al vivere materiale. Si crea pertanto la dottrina dei bassi salari quale mezzo per spingere al lavoro persone altrimenti portate all’ozio.
Queste concezioni durano fino alla fine del XVIII secolo, quando cominciò a farsi strada una nuova teoria che vede nei salari più alti un’occasione per l’espansione dei consumi e l’assorbimento di una sovrapproduzione che si sta manifestando, oltre che un incentivo al lavoro.
Pauperismo: una nuova immagine del povero
Si delineano una serie di movimenti riformisti che vanno dalla salute pubblica, alla cura scolastica dei minori, ai servizi municipali i quali si intrecciano con gli sviluppi scientifici, economici, filosofici e politici fino a delineare una nuova immagine del povero quale prodotto della società così come organizzata.
Tuttavia contemporaneamente vi è un incremento della povertà con il rischio del crollo del sistema assistenziale in tutti i paesi in via di industrializzazione: la risposta immediata dettata dall’allarme sociale è un nuovo massiccio ricorso alle case di lavoro il cui fallimento induce nuovamente alla tecnica dei sussidi esterni e alla allocazione dei poveri nelle nuove manifatture che stanno sorgendo.
Quale risposta all’individualismo – prima mercantilista e poi industriale – si manifesta e si diffonde a partire dall’Inghilterra il socialismo inteso in termini utopistici e non scientifici quale dittatura del proletariato. Si definisce, quindi, un nuovo concetto di giustizia sociale visto quale ordinamento in grado di perseguire la pace eliminando le tensioni frutto di eccessive diseguaglianze non temperate da meccanismi di assistenza.
Se nel sistema mercantilistico si crea un vasto mercato finanziario globale basato sul commercio di merci naturali o prodotte in termini semi-industriali, con l’industrializzazione si passa alla produzione tecnologicamente sempre crescente di merci, l’esaurirsi dei mercati comporta la necessità di superare le ricorrenti crisi con l’espansione del sistema sia in termini territoriali che su nuovi settori economici.
Nell’analisi marxiana (socialismo scientifico) la forza lavoro diventa una qualsiasi merce acquistata e venduta dal capitale e vi è una netta distinzione con il lavoro, quale attività umana creatrice, il sistema regge solo in quanto in continua espansione ma potenzialmente in conflitto con il suo ambiente naturale.
Pauperismo: una nuova analisi scientifica
Si passa da una valutazione teologico-moralista o più semplicemente empirica ad una analisi scientifica del problema del pauperismo, l’economista Brentano inizia ad affrontare il problema del lavoro e giudica quale migliore soluzione la promozione dei sindacati liberi.
Con il XX secolo la povertà diventa oggetto di studio nell’economia del benessere (Pigou), fino ad essere sviluppata nell’analisi dei problemi della giustizia distributiva, ricondotta tuttavia al concetto di ineguaglianza e all’individuazione di un livello di reddito chiamato linea di povertà.
Se a partire dagli anni ’30 a seguito della grande depressione emergono le teorie keynesiane sull’equilibrio della sotto-occupazione e pertanto matura l’intervento pubblico quale stimolo alla domanda, basti pensare al new deal, è nell’ultimo quarto di secolo che si adotta un diverso quadro teorico di riferimento costituito dai bisogni, dai diversi modi di appagarli, dai panieri di beni e dai servizi richiesti per appagarli (Sen).
Si ottiene una distinzione fra “povertà assoluta” quale indigenza e “povertà relativa”, intesa come disuguaglianza economica, nasce un approccio multidimensionale che unendo aspetti economici, sociologici e psicologici riesce ad indagare aspetti non soltanto materiali di privazione, ossia le “nuove povertà” quali manifestazioni di emarginazione socio-culturale.
Rinasce il dibattito tra liberalismo estremo e interventismo pubblico in cui si esaltano le forze di mercato e i liberi scambi per recuperare successivamente la necessità dell’intervento pubblico al fine di fornire i servizi pubblici di base quali infrastrutture, istruzione, sanità e innovazione tecnologica, i quali difficilmente sarebbero sviluppati dall’intervento privato senza prima il raggiungimento della massa critica necessaria e con esposizione verso le fasce più deboli economicamente non interessanti.
Si riscopre l’antico principio che un aumento della ricchezza complessiva non siglifica necessariamente benefici per tutti.
Gli stessi flussi migratori, visti inizialmente come dinamica esclusivamente positiva per i paesi più poveri al fine di ridurne la pressione interna e come rimessa economica stabile, sono ripensati in quanto non automatica fonte di crescita per i paesi di origine, se non accompagnati da un ritorno degli emigranti con il know-how necessario all’impianto di attività economiche, oltre che al naturale impoverimento del paese delle persone dotate di maggiore iniziativa.
Anche per questo fenomeno si recupera la necessità di una sua regolazione, non solo in termini di ordine pubblico, ma in un’ottica di allargamento dei mercati in termini di produzione e consumo. Dobbiamo tuttavia considerare che la povertà si manifesta non solo in termini quantitativi, ma nelle società economicamente avanzate anche in termini qualitativi.
La complessità del fenomeno e la sua dinamicità è tale che, come abbiamo all’inizio descritto, non potrà mai essere del tutto eliminata anche in società economicamente avanzate, ma fisiologicamente controllata e ridotta alle percentuali minime possibili, in quanto collegata – oltre che a dinamiche economiche quali disoccupazione ciclica, stagionale, tecnologica e frizionale – ad aspetti propri della relazionalità sociale della mente umana.
E’ l’ampiezza del livello socialmente accettato della povertà che ne determina la trasformazione da problema individuale a problema sociale, una soglia fisiologica che ad esempio nell’ambito lavorativo è fissata comunemente quale disoccupazione al 3-4% della popolazione attiva, uno scalino del tutto incomprimibile.
Bibliografia
– N. Abbagnano, Storia della filosofia, 1974.
– L. Pierre, Storia economica e sociale del mondo, 1980.
– A. C. Pigou, Economia del benessere, 1929.
– A. Sen, Povertà e carestia, 1981.
– J.D. Sachs, Cancellare la miseria, in “Le Scienze”, 60/69, 447, 11/2005.
– E. Morin, Il metodo. Ordine , disordine, organizzazione, 1983.
– T. Tinti, Il concetto di emergenza tre dualismo e materialismo, in ComplexLab.
– E. J. Hobsbawm, Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale, 1986.
FONTE: https://www.complexlab.it/Members/ssabetta/articoli/pauperismo-definizione-emergentismo
La differenza tra il pauperismo e la povertà cristiana
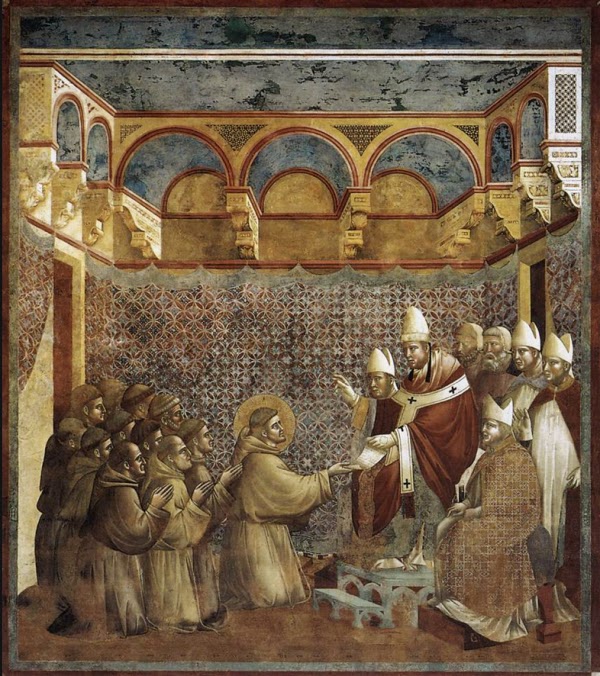
di Francesco Agnoli*
*scrittore e saggista
da Il Foglio 18/04/13
Quando si parla di san Francesco, il pensiero corre al Cantico delle Creature, che tutti abbiamo studiato come primo documento della letteratura volgare. Riassunto in soldoni, il Cantico insegna ad andare a Dio tramite le sue creature. Dice cioè di un amore per la realtà, per il mondo, per il suo essere portatore di tracce divine. Come osservando un quadro di Giotto o la Pietà di Michelangelo riusciamo a comprendere qualcosa dell’intelligenza, della genialità dei due artisti, così il Sole, la Luna, l’acqua, il fuoco sono doni di Dio, che a lui ci devono condurre.
Dalle creature al Creatore; dalle “perfezioni” visibili, a quelle invisibili. Poi il pensiero corre a Madonna Povertà, di cui ci parla Dante nell’XI canto del Paradiso, e tutti immaginiamo un uomo che rinuncia alle ricchezze del padre, alle glorie del mondo, per una vita all’insegna dell’amore di Dio, della semplicità, della povertà. Ma la povertà esteriore, il rude saio francescano, mi sembra, è solo l’aspetto più evidente, esteriore, della povertà francescana.
Per questo talora si può ridurre Francesco a un pauperista. In realtà avrebbe faticato di più, senza dubbio, a comunicarlo, ma Francesco sarebbe stato povero, in senso evangelico, anche se fosse stato costretto a vivere in una reggia, a fare il re, il principe o Papa. Del resto, quanti pontefici, quanti sovrani, nella storia, sono stati capaci di un distacco ascetico non solo dalle ricchezze (tentazione, per il vero, degli spiriti più rozzi), quanto dal potere? Ecco dunque che la povertà cristiana di Francesco è anzitutto povertà, diciamo così, dall’orgoglio. I catari, contemporanei di Francesco, vivevano anch’essi una povertà radicale; ma si consideravano “puri”, perfetti, facevano mostra della loro ascesi (in verità disprezzo per la realtà creata), presentandosi come santi. Erano, però, uomini orgogliosi, incapaci di accettare il limite imposto dalla realtà, i limiti della carnalità e della finitudine umana. Dèi, pretendevano di essere, incarcerati nel corpo e nel mondo, tesi a protestare la loro grandezza, la loro divinità, la loro santità, contro la caducità del Sole, della Luna, delle stelle, del corpo… e contro l’ingiustizia e la malvagità degli altri uomini e, a detta loro, di Dio.
In cosa consiste allora la povertà di Francesco? Oserei dire nella sua letizia. Così espressa in un celebre fioretto: «Avvenne un tempo che san Francesco d’Assisi e frate Leone andando da Perugia a Santa Maria degli Angeli, il santo frate spiegasse al suo compagno di viaggio cosa fosse la perfetta letizia. Era una giornata d’inverno e faceva molto freddo e c’era pure un forte vento e… mentre frate Leone stava avanti, frate Francesco chiamandolo diceva: “frate Leone, se avvenisse, a Dio piacendo, che i frati minori dovunque si rechino dessero grande esempio di santità e di laboriosità, annota e scrivi che questa non è perfetta letizia“. Andando più avanti san Francesco chiamandolo per la seconda volta gli diceva: “O frate Leone, anche se un frate minore dia la vista ai ciechi, faccia raddrizzare gli storpi, scacci i demoni, dia l’udito ai sordi… scrivi che non è in queste cose che sta la perfetta letizia…”. E così andando per diversi chilometri quando, con grande ammirazione frate Leone domandò: “padre ti prego per l’amor di Dio, dimmi dov’è la perfetta letizia”. E san Francesco rispose: “quando saremo arrivati a Santa Maria degli Angeli e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi per il fango e affamati per il lungo viaggio busseremo alla porta del convento. E il frate portinaio chiederà: chi siete voi? E noi risponderemo: siamo due dei vostri frati. E lui non riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente che ruba l’elemosina ai poveri, non ci aprirà lasciandoci fuori al freddo della neve, alla pioggia e alla fame mentre si fa notte. Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo con pazienza ed umiltà senza parlar male del nostro confratello, anzi penseremo che egli ci conosca… allora frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia…”.
Cosa dice Francesco? Che chi è povero di sé, chi è povero di orgoglio, cioè chi non lega la propria “autostima”, come si dice oggi, ai fatti, alle circostanze, al successo, alla fama, al riconoscimento degli altri, è veramente lieto. Nessuno infatti può portargli via nulla, perché ciò che gli sta a cuore non sono gli sguardi degli uomini, ma il sentirsi guardato, giudicato, amato da Dio. Cosa importa, alla letizia francescana, se i frati, che lui ha fondato, non aprono la porta? Se proprio chi dovrebbe essere riconoscente, non lo è? Se non solo i nemici, ma persino gli amici, criticano e denigrano ingiustamente? Cosa importa se gli altri esaltano, o se al contrario, diffamano?
Nulla di tutto questo è veramente importante. I francescani potrebbero dire “omnia mea mecum porto”, ma non alla maniera degli stoici: con una umiltà nuova, quella per cui la ricchezza che nessuno potrà mai toglierci è l’essere figli di Dio. E’ la fiducia totale nella sua vicinanza. Quanto più ci saremo spogliati di noi stessi, delle nostre presunzioni e pretese, persino, talora, di quelle giuste, tanto più saremo lieti.
FONTE: https://www.uccronline.it/2013/06/11/la-differenza-tra-il-pauperismo-e-la-poverta-cristiana/
ECONOMIA
Estinzione del Welfare State
La dottrina del welfare si contrappone decisamente alla dottrina marxista, eppure è per noi del massimo interesse, perché ci dimostra che l’avversario deve ormai accettare il combattimento aperto sulla teoria, e male si arrocca nella farragine del soggettivismo o del mercantilismo ondeggiante e inafferrabile. Matematicamente e storicamente parlando, quella modernissima dottrina mette in chiaro il bisogno di un’estrema difesa del capitalismo (cfr. Partito Comunista Internazionale, Vulcano della produzione o palude del mercato? 1954).
Nella società futura sarà immediatamente abolita la previdenza a tipo mercantile, che sarà sostituita da una forma superiore di produzione e riproduzione cui partecipano tutti i membri della società, anche quelli oggi non produttivi (cfr. punto “f” del Programma rivoluzionario immediato, riunione di Forlì del Partito Comunista Internazionale, 1952).
OGGI
Dal welfare allo “stato assistenziale”
Da un punto di vista storico generale, il capitalismo nasce con il problema dei poveri che esso stesso crea, nasce quindi con la sua politica sociale, che è in fondo il tentativo di trovare una soluzione alla povertà. E’ una sua caratteristica quella di produrre di continuo, oltre che merci e plusvalore, una popolazione in esubero. La quale però è ridondante e povera solo relativamente alla possibilità di soddisfare i propri bisogni. Siccome questi sono in rapporto allo stadio raggiunto dalla forza produttiva sociale, ecco che il confronto fra l’enorme quantità di valore prodotto dal proletariato e la quota che in totale (considerando cioè occupati e disoccupati) gli viene lasciata, permette di rilevare una legge, quella della miseria crescente, definita da Marx come “legge assoluta, generale, dell’accumulazione capitalistica”. In questo modo di produzione il pauperismo è dunque un fenomeno permanente che si accompagna allo sfruttamento, tanto che per lo stesso Marx è “l’ospizio di invalidità dell’esercito operaio attivo”.
Se nei paesi a vecchio capitalismo questa legge si presenta in modo relativo (il livello di consumo del proletario aumenta, ma non in proporzione al valore che egli produce), nell’insieme del sistema capitalistico tende ancora all’assoluto, dato che in alcune aree del pianeta una buona parte della popolazione muore letteralmente di fame per il fatto che l’accumulazione avviene altrove e produce un drenaggio di valore locale.
La teoria borghese soggiacente a quello che viene comunemente chiamato Welfare State inizia a svilupparsi nel periodo fra le due guerre mondiali e si afferma definitivamente nel secondo dopoguerra. Ma per quanto riguarda l’assistenza (e la coercizione) sociale ha origini ben più antiche. Già Malthus affronta il problema di quale atteggiamento lo Stato debba assumere nei confronti dei poveri, basandosi sulle apposite leggi che il capitalismo inglese si diede fin dalle sue origini, all’inizio del ‘600.
Nell’accezione attuale, il termine “Stato del benessere” viene utilizzato come sinonimo di “Stato sociale”, nel senso di una politica di spesa pubblica tesa a garantire sia la copertura economica degli strati poveri della popolazione, sia la distribuzione del reddito affinché non cadano i consumi di tutte le classi. Ciò viene ottenuto mediante leggi ed istituti con il compito di contrastare l’anarchia insita nel sistema capitalistico, in modo che questo non sia lasciato a sé stesso, e di indirizzare perciò una quota del valore totale prodotto dall’intero sistema.
Le forme specifiche di questo intervento permeano talmente la società moderna che gli individui ne sono assuefatti, percepiscono il fenomeno come naturale, come se fosse sempre esistita una distribuzione di valore. In realtà l’unico fenomeno paragonabile ha tutt’altra natura, ed è quello della distribuzione di cibo e spettacoli alla plebe nell’antica Roma. Fenomeno costoso e a volte rovinoso per l’imperatore e per lo Stato, mentre il welfare è per il capitalismo salvifico e promotore di nuova accumulazione.
Il welfare è figlio del liberismo, e lo ha ucciso per sempre. Oggi chi si atteggia a liberista dimentica che combatte contro le misure di protezione escogitate di fronte ai disastri provocati dal capitalismo “spontaneo”. Crede di “liberalizzare” il mercato imponendogli la legge, quindi delle regole, senza accorgersi che proprio in questo modo impedisce d’autorità il decorso naturale del capitalismo verso forme chiuse, accentrate e monopolistiche. Lo fa naturalmente per mezzo dello Stato, del suo apparato legislativo, esecutivo e di controllo poliziesco. E si dimostra così più statalista di coloro che critica, introducendo forme di salvataggio nei confronti di capitalisti altrimenti destinati liberamente a soccombere.
Se, parlando di welfare, vengono in mente nell’immediato la previdenza, l’assistenza sociale, quella sanitaria, l’edilizia popolare o il programma di lavori pubblici, non hanno minore importanza gli interventi sul controllo generale dell’economia, come l’abbassamento del tasso di sconto, che regala ai capitalisti vantaggi nell’accesso al credito, o le leggi di sostegno alla produzione, che drogano il mercato interno a favore dei capitalisti nazionali e delle loro esportazioni.
In questo sistema, contrariamente a quanto affermano le volgarizzazioni del capitalismo da parte degli stessi capitalisti, non è affatto rilevante che vi sia uno “Stato imprenditore” o una serie di imprenditori privati. Se le leggi che regolano gli investimenti, il mercato interno e lo stimolo verso quello estero sono uguali per lo Stato e per l’imprenditore singolo, non fa nessuna differenza che quest’ultimo venga eliminato o meno. Tanto più che la “privatizzazione” è generalmente basata sulla vendita pubblica di azioni, titoli di possesso legale che vengono distribuiti nella società a migliaia di “capitalisti” che non contano nulla e che sono guidati dalle leggi dello Stato più che da minuscoli gruppi di maggioranza in balìa essi stessi della concorrenza. Il capitalismo funziona in quanto tale anche senza capitalisti (ex URSS) così come i capitalisti possono essere tali anche senza possedere le grandi quantità di denaro che maneggiano (azionariato diffuso, concessioni, appalti, intermediazione finanziaria, ecc.).
Lo stesso Keynes afferma che occorre “eliminare la figura del possessore di capitali” quando il suo “oppressivo potere addizionale” si affianca al funzionamento di un capitalismo che sfrutta il valore conferito al capitale in tempi di ridotta disponibilità; per giungere a questo è necessario ampliare le funzioni dello Stato affinché sia possibile “una discretamente vasta socializzazione dell’investimento”. Ed ecco il punto cruciale, che milioni di stalinisti non erano riusciti a digerire: “La cosa importante – scrive Keynes – non è che lo Stato si faccia carico della proprietà dei mezzi di produzione; se è in grado di minare il volume totale delle risorse da dedicare all’aumento di questi mezzi o di variare il tasso base per gli stanziamenti a loro favore avrà già fatto tutto il necessario […] L’ampliamento delle funzioni dello Stato ci sembra necessario per evitare una completa distruzione delle istituzioni economiche attuali e anche la condizione per un fruttuoso esercizio dell’iniziativa individuale”.
Del resto anche l’esperienza empirica dimostra, se pur ce ne fosse ancora bisogno dopo le dimostrazioni teoriche di Marx, che il capitalismo funziona meglio con pochi capitalisti e con molti salariati, con una raccolta centralizzata di capitali altrimenti inutilizzabili, con una massa crescente di profitto nelle mani di pochi centri di accumulazione per poter contrastare la tendenza al ribasso del saggio. Perciò al Capitale in generale conviene, indipendentemente dalla volontà dei capitalisti, che si devono adeguare alle sue leggi, un vasto rastrellamento di capitali nella società, ma un ristretto numero di gruppi di controllo, integrati con la politica dello Stato. Insomma, la vittoria della moderna centralizzazione dei capitali sulla vecchia concentrazione. Siccome lo Stato è al servizio del Capitale e non viceversa, ecco che diventa conveniente e necessario un controllo stretto dei pochi capitalisti o gruppi borghesi, accompagnato dalla massima libertà (di vendersi) per i proletari.
L’insopportabile piagnisteo populista sulle malefatte delle multinazionali e dei governi costituiti da borghesi corrotti e da lobby di potere rovescia i termini della questione: esistono certamente i fenomeni denunciati, ma nel lungo periodo si impone sempre l’interesse dell’accumulazione, non quello dei singoli. Durante l’interessante fenomeno detto “mani pulite” si calcolò, sulla base di ciò che era emerso dalle indagini e dai processi, che in quarant’anni l’intero ammontare del valore dirottato dalle varie lobby stataliste più o meno mafiose e dai politici corrotti fosse qualcosa come 125 miliardi di euro attuali. Un cifra impressionante se sparata ad effetto per campagne politiche atte a convincere i fessi, ma una sciocchezza dal punto di vista pratico: 25 centesimi a testa all’anno per ogni italiano. Lo Stato liberista, aumentando di un millesimo di euro la tassa sulla benzina o concedendo a un “privato” linee elettriche o telefoniche per “favorire la concorrenza e quindi i consumatori” e prelevando poi da capitalisti e restante “popolo” la sua tangente, spenna tutti infinitamente di più.
Ciò che in realtà il sistema ormai non sopporta è il fatto che, quando diminuisce l’incremento del plusvalore totale prodotto, si fa difficile la sua distribuzione presso strati sociali nullafacenti, parassitari o semplicemente addetti ad attività improduttive. Questa vera e propria assistenza pubblica di quel magma piccolo-borghese che serve da supporto alla politica della borghesia è il l’effettivo “costo” che il capitale deve affrontare. La mazzetta al disonesto, la corruzione individuale, pur eretta a sistema, è una goccia nel mare rispetto a quel che costa l’ammortizzazione sociale, la corruzione di classe, il mantenimento della palude.
In breve, dopo “stato del benessere” e “stato sociale”, l’ulteriore termine escogitato dagli economisti, “stato assistenziale”, è ben azzeccato, e in realtà non si riferisce affatto ai poveri veri, ai paralitici falsi o ai milioni di pensionati elettorali. Per gli economisti, sottolineare in modo spregiativo una pretesa degenerazione dello statalismo, colpevole di lesa libertà di mercato, è un modo come un altro per non essere fuori dal coro piagnone dei capitalisti in crisi. Ma capitalisti ed economisti non sono il capitalismo. La parabola del welfare, cui l’economia politica aveva dato corso per il salvataggio dell’asfittico sistema, si chiude con un attacco al welfare stesso per salvare il capitalismo… e tornare alle condizioni di partenza. Forse i capitalisti possono pensarlo, ma il capitalismo non si ferma certo per questo, e macina inesorabilmente un’altra dura realtà. Addirittura opposta a quella fatta bere anche ad ingenui sinistri.
Malthusianesimo di ritorno
Fin dalla sua nascita il capitalismo, osannato per la sua capacità di produrre ricchezza, si presenta con tremende contraddizioni. Quella più immediatamente riscontrabile riguarda la condizione di vita degli uomini, ai quali – come abbiamo appena ricordato – non è affatto distribuita la ricchezza che producono, mentre dilaga la miseria relativa e assoluta. Quando il Capitale s’impossessa della terra, l’espropriazione dei contadini porta in breve alla distruzione della solidarietà di famiglia e di villaggio. I vecchi vincoli sociali non sono sostituiti da nuovi. L’uomo non diventa solo povero, rimane anche solo. Nasce l’uomo libero da proprietà e da antichi vincoli famigliari allargati, vagabondo o proletario, quindi passibile di forca o di sfruttamento, cioè libero di scegliere se morire ancor giovane, di colpo, sulla forca, o poco per volta, di sfruttamento. Non prima però di aver figliato altra forza-lavoro a beneficio del Capitale. Ma non troppa, per non insidiare col numero la ricchezza da distribuire.
Qui entra in gioco Malthus, passato alla storia per aver detto che non ci può essere ricchezza per tutti se la popolazione cresce a ritmo esponenziale mentre la produzione cresce solo in progressione aritmetica (Saggio sul principio della popolazione, 1798). Da allora si parla di “malthusianesimo” per indicare un controllo della popolazione rispetto alla bassa capacità produttiva mirato ad innalzare la quantità pro capite di merci; oppure, paradossalmente, un controllo dell’alta capacità produttiva per adattare la quantità di merci al mercato e impedire la rovinosa caduta dei prezzi. C’è così un malthusianesimo “terapeutico”, come quando si distrugge frutta in eccesso, e uno “profilattico”, come quando si pagano i contadini per estirpare i frutteti o si tassano certi prodotti industriali.
Malthus aveva notato che i capitalisti potevano produrre in quantità illimitata e perciò vendevano alle classi ricche prodotti industriali a prezzo sempre più basso, mentre gli operai consumavano prevalentemente prodotti agricoli che invece rincaravano; e la crescita demografica sproporzionata degli operai in rapporto a quella della produzione agricola rendeva eccedente il loro numero. Per quanto le sue teorie da prete riformato, santificanti il capitalismo e lo sfruttamento, fossero aberranti dal punto di vista della teoria economica e della specie umana, Malthus non era così fesso da limitare la sua concezione unicamente a un fattore di popolazione, se non altro perché aveva scopiazzato da autori più bravi di lui. In realtà il suo schema completo, quello del Trattato di economia politica applicata (1820), è basato sul prodotto netto, cioè quella parte della produzione che può essere consumata senza intaccare la capacità produttiva esistente. Al pari di quello di Quesnay, dal quale deriva, è una funzione della produzione.
Marx criticò Malthus non tanto per il suo modello quanto per la sua difesa pretesca dell’accumulazione capitalistica primitiva sotto l’ordine feudale. Con l’esaltazione del consumo improduttivo e la mortificazione di quello vitale, Malthus difendeva condizioni sociali retrograde, in polemica con Ricardo, che almeno era per lo sviluppo della forza produttiva sociale in sé stessa senza preoccuparsi di ciò che sarebbe successo agli uomini in quanto agenti della produzione. Malthus esaltava la produzione borghese in quanto reazionaria, conservatrice di vecchi rapporti; Ricardo in quanto rivoluzionaria, demolitrice. Marx è sprezzante nei confronti di un modello di capitalismo che, disegnato da un prete, contempla una distribuzione del plusvalore non soltanto fra le classi capitalisticamente produttive ma tra “parassiti, fannulloni gaudenti, parte padroni e parte servi, che si appropriano gratuitamente dalla classe capitalista, a titolo di rendita o a titolo politico, una massa considerevole di ricchezza, pagando però le merci al di sopra del valore col denaro sottratto agli stessi capitalisti”. Nel capitalismo il modello distributivo, qualunque esso sia, pensato alla Malthus o secondo criteri di moderno “benessere”, deve necessariamente portare ad una ripartizione di classe del plusvalore. Mentre il modello ricardiano fa esplodere il sistema per troppa produzione, troppa energia, troppa velocità, il modello malthusiano lo fa esplodere come una fogna intasata. Ancora Marx: “Mentre la classe capitalistica è sferzata a produrre dall’impulso all’accumulazione, gli elementi economicamente improduttivi sono spinti solo dall’impulso al consumo e rappresentano la dissipazione. Ed è questo, invero, l’unico mezzo per sfuggire alla sovrapproduzione, che coesiste con una sovrappopolazione in rapporto alla produzione. Il miglior rimedio per entrambe è il sovraconsumo delle classi che stanno al di fuori della produzione. Lo squilibrio fra la popolazione operaia e la produzione è così soppresso dal fatto che una parte del prodotto viene divorato da non produttori, da fannulloni. Lo squilibrio della sovrapproduzione dei capitalisti [è soppresso] dal sovraconsumo della ricchezza sgavazzante“.
Il welfare state è in fondo figlio di Malthus, dato che nasce dalla stessa preoccupazione distributiva che aveva il suo genitore, compresa la convinzione che le leggi per l’assistenza ai poveri siano inutili, anzi, dannose. I benesseristi sono molto preoccupati dell’esistenza e soprattutto della tendenza dei “poveri” ad aumentare con ritmo geometrico. In genere, alle leggi per una mera assistenza sociale contrappongono un sistema assicurativo, pubblico o privato ma del tutto capitalistico, abbinato ad una politica economica redistributiva del reddito che fa leva soprattutto sulla tassazione progressiva e su una legislazione economica appropriata.
Keynes è un economista che in genere non viene affiancato a quelli che hanno fatto la storia del welfare state (Marshall, Pigou, ecc.), ma ha molto a che fare con la sua realizzazione. Anch’egli disegna un modello a-classista in cui ciò che importa è il rapporto fra grandezze, per esempio risparmio, investimento, consumo, occupazione. O meglio: in cui il risultato del sistema è funzione del valore delle varie grandezze. Siccome queste grandezze non influiscono in modo proporzionale sul sistema, ecco che lo Stato avrebbe notevoli possibilità di influenzarne il comportamento agendo su di esse. Per esempio, il consumo non aumenta in proporzione al reddito, ma tende ad appiattirsi man mano che questo cresce; di conseguenza, aumentando il reddito di milioni di “poveri”, c’è la sicurezza che tutto l’aumento finisca in consumo, mentre ciò non succede se aumenta della stessa percentuale il reddito di poche migliaia di “ricchi”. Puntando sulla maggiore “propensione marginale al consumo” propria dei poveri e sulle altre leve politico-economiche in mano allo Stato, Keynes si prefiggeva di pilotare la distribuzione del valore prodotto nella società, alimentare la produzione ed eliminare crisi e lotta di classe.
Invece di convincere malthusianamente i proletari a non proliferare, sarebbe stato più proficuo adibirli a un lavoro qualsiasi in modo che ricevessero, con il crisma della legge e della moderna morale classista, la quota di valore derivante dall’imposta progressiva (togliere ai ricchi per dare ai poveri, una moderna versione di Robin Hood cara anche ai falsi comunisti, specie i più sinistrorsi). Gli uomini in esubero, insomma, invece di non nascere avrebbero dovuto non vivere, essere più che mai mero tramite di valore, “scavare buche al solo scopo di riempirle”, affinché il ciclo dell’accumulazione non s’inceppasse sul crollo di produzione e consumi. La peggiore alienazione umana, gabbata per “benessere”. Keynes ammise che lo schema fisiocratico del prodotto netto, e quindi la legge della domanda effettiva di Malthus, avevano influenzato la sua teoria economica.
Certo, la nascita del proletariato, fenomeno complementare a quello dell’espropriazione del contadino e dell’esplosione urbana occidentale, comporta anche teorie sul proletariato, da parte della conservazione (l’economia politica), ma anche e soprattutto della rivoluzione (Marx e la teoria del comunismo). Proprio per paura della rivoluzione la borghesia moderna ritorna sul problema. La feroce trasformazione sociale mette in pericolo l’assetto borghese, e la borghesia risponde con il cannone e con le riforme, in un alternarsi naturale, a seconda delle esigenze. Le nuove forme di pauperismo sono pericolose per due aspetti: il primo è la degenerazione sociale, la violenza, l’illegalità, terreni poco fertili per il senso civico del buon cittadino, più consoni al rifiuto dell’ordine produttivo della fabbrica e dell’ambiente di cui essa ha bisogno; il secondo, opposto e sicuramente il più importante per noi, è la tendenza spontanea all’organizzazione proletaria, non quella episodica, ma quella mutuata dallo stesso ambiente produttivo che obbliga alla razionalità, entra nei comportamenti collettivi e si manifesta con regolarità sempre maggiore attraverso inaspettate forme di lotta.
In Inghilterra le poor law, le leggi per i poveri, produssero più impiccati e deportati che operai produttivi e furono abbandonate nel 1834, dopo oltre due secoli d’inefficacia. La Germania di Bismarck, paese a capitalismo giovane e quindi sviluppatosi velocemente con le contraddizioni più moderne, fu la prima a istituire, tra il 1883 e il 1892, un sistema di misure sociali moderne a favore degli strati più poveri della popolazione. Ancora in Germania, dai ranghi stessi della borghesia nasceva, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, la non troppo strana utopia borghese di un “socialismo del capitale”, il cui massimo esponente fu il capitalista Walther Rathenau: “L’ordinamento cui noi perverremo sarà un ordinamento di economia privata, ma non di un’economia senza freni […] Noi rideremmo di qualcuno che volesse comprarsi un cannone per rendersi indipendente[…] nessuno si sogna di pretendere per sé un tratto di ferrovia o di rete telegrafica, di fondare un proprio sistema particolare di giurisdizione privata, ma ciò per l’economia viene accettato senza discussione […] L’economia dovrebbe invece essere suscettibile di un ordinamento razionale, di un’organizzazione cosciente, di una penetrazione scientifica e di una responsabilità solidale, in modo che possa rendere molte volte di più di quanto oggi si ottiene con la lotta di tutti contro tutti”. Rathenau proponeva qualcosa di più di uno “stato sociale”, vagheggiava uno stato integrato in tutte le sue componenti, una popolazione senza classi tutt’uno col Capitale. Il suo allarme e il suo programma furono riecheggiati nell’impressionante film Metropolis di Fritz Lang (1926), il cui finale di riconciliazione sociale piacque ai nazisti. Fu ammazzato nel ’22 da un destro che non aveva capito nulla di come evolve il movimento reale.
Gli Stati Uniti, altro capitalismo giovane, furono costretti dalla Grande depressione, mezzo secolo più tardi, a varare il Social Security Act (1935), il primo corpo completo e articolato di leggi sulla moderna politica di protezione sociale da parte dello Stato. Nel frattempo l’Italia e la Germania avevano adottato misure simili, portando alle estreme conseguenze non solo il problema della protezione sociale, ma quello del controllo globale del fatto economico, almeno all’interno dei confini nazionali (all’esterno questa esigenza si manifestava ancora con necessità di controllo territoriale diretto). Naturalmente un tale controllo presupponeva come elemento fondamentale l’eliminazione – prima violenta e in seguito istituzionale – dei conflitti sociali e la collaborazione di classe.
Il capitalismo imperialista più vecchio, quello d’Inghilterra che aveva dato il via alle politiche sociali fin dal ‘600, arriva buon ultimo sulla scena del welfare moderno, nel 1942, scrivendone però il manifesto compiuto ad opera dell’economista Beveridge. A dire il vero questo lord di vecchio stampo, tra il riformista e l’utopista, studiando i disastri del capitalismo a cavallo del secolo, aveva prodotto un documento già nel 1909, ma era rimasto inascoltato. Nel 1944 ripubblicava una versione privata del suo rapporto, che conteneva un programma di keynesismo puro. L’autore di questo programma fu individualmente sconfitto in politica, e si ritirò a studiare le utopistiche new town, presto degenerate in squallide periferie metropolitane chiamate eufemisticamente “città giardino”; ma in generale la politica del welfare divenne ordinaria amministrazione in tutti i maggiori paesi capitalistici, raggiungendo l’apice negli anni ’60 del secolo scorso nei paesi del Nord Europa, specie in quelli scandinavi.
L’Italia, che non aveva per nulla smantellato l’economia controllata dello stato fascista, fu caposcuola anche per tutto il dopoguerra, soprattutto con una politica mirata alla spesa pubblica, alle sovvenzioni industriali e ad una pesante redistribuzione del reddito. Per quanto il sistema, specie nel Sud, apparisse disastrato e a basso rendimento a causa di una borghesia parolaia pasticciona, nel suo complesso fu in realtà abbastanza efficiente, tanto da portare l’economia nazionale quasi alla pari con quelle di Francia, Inghilterra e Germania (valore prodotto pro-capite in unità di potere d’acquisto).
Il significato delle liberalizzazioni fasulle
Fu negli anni ’70 che si raggiunge il massimo livello di applicazione delle politiche espansive dirette, vale a dire dell’intervento dello Stato per sostenere la produzione e i consumi attraverso tre canali principali: incentivi all’industria, distribuzione del reddito al fine di elevare la capacità totale di consumo delle fasce sociali senza reddito, investimenti pubblici (case popolari, infrastrutture, industria di stato, ecc.). Ma la generale caduta del saggio di profitto, ben evidenziata dalla caduta relativa della produzione industriale che ne è l’indice principale, provocò una conseguente difficoltà ad attingere alle fonti di valore per il sostegno di tali politiche. La conseguenza fu un generalizzato disavanzo nei conti pubblici, un ricorso al debito statale e quindi un aumento dello stesso debito consolidato e della pressione fiscale per la sua gestione nel tempo.
Negli anni ’80 Inghilterra e Stati Uniti (tramite i “battilocchi” del momento Tatcher e Reagan, che diedero luogo ai rispettivi “ismi” nei loro paesi) furono costretti per primi ad abbandonare le vecchie politiche di controllo dell’economia per adottarne di nuove, poste genericamente sotto l’ombrello del termine deregulation. Non si trattava affatto, si noti bene, di eliminare il controllo, ma di istituirne un altro di tipo diverso e più efficace, quindi più stretto. Al controllo diretto dello Stato sugli elementi della produzione e del reddito, subentrò quindi un controllo indiretto, basato principalmente sulla manovra dei flussi finanziari.
Ora, è ovvio che i due unici paesi in grado di controllare mondialmente tali flussi (mediante i due storici strumenti da cui passa la quasi totalità della finanza mondiale che conta, Wall Street a New York e la City finanziaria a Londra), ne traessero vantaggio. Questo non poteva succedere agli altri paesi, e infatti il resto del mondo, pur costretto a seguire le politiche di deregulation, di cui avrebbero volentieri fatto a meno, non riuscì a mettersi al passo nemmeno in vent’anni.
Il capitale finanziario che muove da e verso i maggiori centri mondiali di smistamento è meno “speculativo” di quanto appaia a prima vista nelle quotidiane transazioni. In generale e nel volgere di qualche anno, questa circolazione smista e fissa effettivo valore, nel senso che si trasforma in proprietà industriale, e finisce per controllare all’origine, almeno in parte, il plusvalore che fluisce nelle mani dei maggiori possessori di capitali. Attraverso le borse mondiali e le banche di peso internazionale vengono acquistate aziende, effettuate fusioni, influenzati programmi di sviluppo, viene insomma modificato l’assetto della proprietà e della concorrenza a favore ovviamente dei gruppi capitalistici e delle nazioni più forti.
Un tale tipo di razzia sul plusvalore internazionale è possibile da parte di pochi paesi solo se molti altri paesi allentano il controllo interno sui flussi di valore. Questa è la ragione per cui gli Stati Uniti, l’Inghilterra, i maggiori gruppi finanziari e gli speculatori internazionali hanno iniziato a battere la grancassa sulla liberalizzazione del mercato, cioè sulla facoltà di dirigere meglio i flussi di capitali nel mondo intero. Questa è la ragione per cui i paesi che non hanno il potere di governare i flussi esteri non possono smantellare il vecchio sistema di protezione sociale interno, malgrado le roboanti prese di posizione dei gruppi borghesi più legati agli interessi del capitale internazionale o semplicemente più stupidi o servili. Questa è anche la ragione per cui paesi che hanno rigidità interne intrinseche, come Germania e Giappone, si trovano oggi in grande difficoltà: non potendo contare sulla possibilità di sfruttare internazionalmente i proletari del resto del mondo, sono costretti a trarre il massimo profitto dai propri, senza tuttavia ridurli ad una condizione da Terzo Mondo (non per bontà d’animo, ma per il sostegno dei consumi interni).
Così facendo, cioè mantenendo lo stato sociale e una politica di relativamente alti salari, perdono sempre più di competitività sul mercato mondiale. Essendo esportatori netti, questa loro condizione si è tramutata in disastro non appena la stagnazione mondiale si è fatta sentire. Il Giappone è in ginocchio da dieci anni e la Germania è sul punto di seguire la stessa parabola discendente. E così gli altri paesi con caratteristiche analoghe. La Corea, la cui produzione è sensibilissima al mercato mondiale, è precipitata nella rivolta sociale non appena ha provato ad adeguarsi alla concorrenza liberalizzando il mercato interno della forza-lavoro. L’Italia, che era in condizioni anche peggiori, sfruttando paradossalmente il corporativismo classista ereditato dal fascismo è invece riuscita, dal 1992-93 (quando si sfiorò una grave crisi sociale e la rivolta proletaria), a coinvolgere partiti e sindacati in una deregulation selvaggia che di fatto ha smantellato completamente il sistema di garanzie precedente (le attuali manovre come quella sull’articolo 18 non sono che scaramucce politiche all’interno degli schieramenti borghesi, come vediamo in altro articolo).
Stati Uniti e Inghilterra hanno semplicemente fatto da battistrada per tutto il resto del mondo capitalistico, costringendolo, nel volgere di vent’anni, a sintonizzarsi sulle esigenze del capitale mondiale, cioè a liberare il proletariato dei vari paesi da ogni tutela nazionale.
Siamo quindi di fronte ad un paradosso: Stati Uniti e Inghilterra furono i paesi che diedero corpo teorico, adottarono e portarono alle estreme conseguenze le sperimentazioni fascista, nazista e staliniana in campo sociale, tanto che le politiche del welfare furono sinonimo di economia anglo-americana e non altro; ma proprio Inghilterra e Stati Uniti furono i primi paesi a soffrire di questa politica. Che, per ammissione dello stesso Keynes, era già un tentativo di rimedio, una toppa. E’ difficile andare oltre rattoppando la toppa, ritornare alle condizioni di partenza; anzi, un assurdo, dato che non si può far girare all’indietro né la storia né tantomeno lo sviluppo della forza produttiva sociale.
Evoluzione del sistema
Nelle intenzioni, la politica del Welfare State avrebbe dovuto prima di tutto rappresentare un rimedio alle tensioni sociali attraverso l’attenuazione delle contraddizioni del capitalismo, che sono dovute, ricordiamolo, agli effetti dello sviluppo continuo della forza produttiva sociale. Keynes lo disse apertamente: se il capitalismo fosse lasciato a sé stesso, avremmo una inevitabile rivoluzione. E’ la stessa osservazione che fece Marx quando notò le capacità di auto-limitazione del sistema di cui stava rilevando le leggi: “Uno sviluppo delle forze produttive che avesse come risultato di diminuire il numero assoluto degli operai, che permettesse in sostanza a tutta la nazione di compiere la produzione complessiva in un periodo minore di tempo, provocherebbe una rivoluzione perché ridurrebbe alla miseria la maggior parte della popolazione”. Il passo continua con un’altra osservazione su questo limite contro cui urta il modo di produzione capitalistico, forma per nulla assoluta di sviluppo come pretendono i borghesi, anzi, forma che entra necessariamente in conflitto insanabile con lo sviluppo stesso.
Per Marx, è noto, l’andamento del sistema è una funzione della produzione, mentre le scuole borghesi introducono parametri diversi, come i prezzi, la soddisfazione marginale o le propensioni psicologiche. Se Keynes non fu uno specifico cantore dell’economia del benessere e della protezione sociale, fu però il primo fra gli economisti a elaborare, per il capitalismo, una teoria sulla necessità di correttivi economico-sociali di utilizzo pratico, e lo fece lavorando su un modello dinamico atto a modificare il disequilibrio dei flussi di valore nel sistema. Voleva in ultima analisi ottenere una modifica dei fattori della produzione-distribuzione. C’è da sospettare che Keynes, senza mostrarlo, abbia attinto non solo da Quesnay e da Malthus, ma anche da Marx: la sua impostazione è un modello dinamico di flussi di valore a partire dalla sua origine, cioè dall’industria. Anche se molto più complicata di quella marxiana, noi la possiamo riferire con facilità allo scambio di valore fra le classi. Se Malthus aveva copiato malamente da Quesnay, Keynes lo ha fatto da Marx, con l’aggravante di nasconderlo.
Ciò non è per nulla strano: per dimostrare da un punto di vista materialistico la caducità del capitalismo sottoposto al lavorìo della rivoluzione che avanza (comunismo), Marx dovette sviluppare uno schema dinamico già preparato da un feudalesimo che, sopraffatto, registrava la vittoria dell’avversario mentre sulla carta lo descriveva sterile; Keynes dovette ricorrere alla dinamica nel tentativo ideologico di rattoppare il capitalismo e renderlo eterno, nascondendo a sé stesso il fatto che la sua classe era ormai sterile nella realtà. E in effetti sterile è una società che ha bisogno di drogare il proprio sistema non più in grado di funzionare da solo. Quest’operazione dell’economista inglese, più filosofica che scientifica, potrebbe spiegare sia la madornale incoerenza fra gli scritti dei diversi periodi della sua vita, sia la teorizzazione col senno di poi, quando fascismo e nazismo avevano già imboccato la strada “keynesiana”. Incoerenza e rattoppismo riflessi in seguito su tutta la sua scuola e rinfacciatigli senza pietà dai liberoscambisti.
Ad ogni modo l’intervento massiccio e totalitario dello Stato in economia fu necessario per superare la catastrofica crisi mondiale degli anni ’30. Più tardi, fino a pochi anni fa, in condizioni di accumulazione non troppo perturbata come in quest’ultimo lungo dopoguerra, le politiche keynesiane furono parimenti necessarie al sistema sia per controllare e indirizzare la crescita economica, sia per frenare i fenomeni depressivi e bloccare, soprattutto, la tendenza a quegli effetti cumulativi che avevano dato luogo alla reazione a catena sfociata nella Grande Depressione. In Vulcano della produzione o palude del mercato?, un testo della nostra corrente, vengono sottoposti a critica i risultati di un’altra scuola neo-malthusiana (attraverso un modello di J. J. Spengler), e si dimostra che tutti questi tentativi portano alla fine i borghesi ad inchinarsi di fronte alla marxiana funzione di produzione se vogliono capire i meccanismi economici e trarre conclusioni per le politiche nei confronti della loro stessa società.
La politica sociale dei vecchi paesi capitalistici avrebbe dovuto garantire un’attenuazione delle contraddizioni sommando l’assicurazione previdenziale a base contributiva e l’efficienza produttiva dovuta alla “programmazione” economica. Si doveva investire, per mezzo di politiche adatte ad un utilizzo razionale, l’enorme accantonamento di capitali in attesa del loro consumo differito. Di qui un benessere diffuso in una società più equilibrata e sicura, caratterizzata naturalmente dalla pace sociale benedetta da sindacati, partiti e preti progressisti. In quegli anni questo processo influenzò anche il soglio pontificio: l’enciclica Mater et Magistra, del 1961, rigettava il principio liberista secondo cui la socializzazione era una minaccia per la società. Accettava dunque la socializzazione e la dichiarava elemento irreversibile della crescita umana, nell’ambito della quale i credenti avrebbero dovuto dare il loro contributo. Naturalmente vi fu gran tripudio degli stalinisti fino a Mosca, dove non si era affatto capito la lungimiranza della Chiesa rispetto al processo storico che avrebbe portato alla loro distruzione.
La quantità di valore rastrellata nella società dalle politiche sociali fu enorme. In Italia giunse a rappresentare fino alla metà del cosiddetto costo del lavoro, circa il 10% dell’intero valore prodotto ex novo in un anno. Naturalmente nacquero anche sottoprodotti ideologici, come una specie di alternativa fra capitalismo e socialismo, vie di mezzo esplicitamente teorizzate o sottoposte a critica. Ma al di là delle intenzioni, cioè della programmazione o del liberismo sfrenato degli addetti ai lavori nello Stato, tutta la società ebbe a beneficiare dell’aumentata possibilità di consumo, compresi, seppure in misura ovviamente minore, i proletari, che ebbero accesso ad alcuni beni durevoli prima negati. Classicamente, alla corruzione delle classi sfruttatrici o parassitarie corrispose anche una corruzione del proletariato, tramite il veicolo delle sue organizzazioni degenerate. E’ un fatto materiale, non certo da valutare in termini moralistici. Di qui la crescita di atteggiamenti consociativi che portarono il mondo politico, sindacale e del grande capitale apparentemente a “cooperare in nome del Bene Comune del Paese”, in realtà ad accaparrarsi quote di plusvalore la cui distribuzione era permessa dal sistema keynesiano di controllo dei flussi.
Si assistette, lentamente ma inesorabilmente, all’espansione degli strati sociali “sgavazzanti” che vivevano sul plusvalore altrui, descrivibili esattamente con le parole che Marx utilizza contro Malthus e citate più sopra. Specialmente in Italia, gli ex partiti operai e i sindacati parteciparono al festino, radicandosi, direttamente o con organismi paralleli, nel campo delle cooperative, dei supermercati, delle assicurazioni e della vendita di servizi agli utenti tramite lo Stato (per esempio tramite i Centri di Assistenza Fiscale). Per molti anni il sistema funzionò senza troppi impedimenti, precisamente finché ci fu plusvalore da distribuire in abbondanza.
Il numero e la dimensione delle “istituzioni”, cioè degli apparati sorti esclusivamente sull’onda della possibile “distribuzione del reddito” crebbe a dismisura, e con essi la burocrazia e la pratica clientelare, con gran danno per l’efficienza e l’adeguatezza dell’intero sistema. Mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti il fenomeno coinvolgeva un vecchio e inefficiente apparato produttivo, che si sarebbe poi riconvertito prevalentemente ai servizi abbandonando allo sfacelo intere città ex industriali con gli impianti invasi dalle erbacce (la Rust belt, fascia della ruggine), in Italia si assisteva al conflitto mortale fra un apparato produttivo che stava diventando uno dei più moderni ed efficienti del mondo (con livelli di automazione e competitività studiati anche all’estero), e il bassissimo rendimento del sistema complessivo. Passati ormai guerra e piano Marshall da troppo tempo, i trasferimenti di plusvalore fra le classi e mezze classi si slegarono da qualunque programma di ricostruzione industriale e sociale, seguendo semplicemente gli interessi dei beneficiari.
Travolsero persino il sistema della sicurezza sociale propriamente detta, dilagando nella società intera, fin nelle sue pieghe nascoste, per esempio con la distribuzione, specie al Sud, di benefici esigui ma elargiti su larga scala. Mentre negli anni ’50 la spesa pubblica rappresentava il 30% del valore complessivo prodotto, nel 1970 saliva al 36,3%, nel 1980 al 48,8% e nel 1985 quasi al 60%. Questa situazione, la cui genesi è implicita nella gran quantità di plusvalore disponibile nella società, nei problemi posti dalla sua distribuzione specie verso le mezze classi, e quindi nella teoria comunista della miseria relativa crescente del proletariato, non poteva evidentemente durare. Il sistema incominciò a perdere colpi negli anni ’80, dopo che la crisi petrolifera e la concorrenza internazionale avevano eroso quote di plusvalore sia facendo aumentare il prezzo delle materie prime, sia rendendo evidente il divario di efficienza fra i diversi sistemi produttivi nazionali.
Senza una crisi generalizzata e una altrettanto generalizzata guerra che distruggano lavoro morto, cioè capitale accumulato, non si potrà dar luogo a un rinnovato ciclo di applicazione di lavoro vivo nella ricostruzione. Non si potrà neppure avere plusvalore a sufficienza per garantire il livello di vita attuale di tutte le classi. I meccanismi produttivi e distributivi, sotto la spinta della legge marxiana dei rendimenti decrescenti, stanno già provocando da tempo un accumulo enorme di valore in pochissime mani e una distribuzione di miseria enorme a scala planetaria. Gli strati intermedi della popolazione stanno già subendo un drastico salasso, i cui effetti si manifestano per ora in un indeterminismo politico dei governi, in una loro incapacità ad agire rispetto ai problemi e in una confusione di ruoli fra le classi, tutti fenomeni generalizzati ai maggiori paesi capitalistici.
Non c’è dubbio che, con le persistenti difficoltà d’accumulazione, nei prossimi anni il problema si farà gravissimo, come del resto evidenziano tutti i modelli macroeconomici, anche solo con la proiezione dei fenomeni dovuti al calo demografico e all’aumento dell’età media degli individui. Ma ci sono altri dati che aggravano la situazione, primo fra tutti l’integrazione mondiale, che provoca effetti catastrofici sul vecchio assetto del mondo diviso in nazioni sovrane. L’immensa circolazione dei capitali attraverso le frontiere, il non meno importante spostamento di uomini e attività produttive con il conseguente confronto diretto fra i salari in tutto il mondo, l’impotenza dei governi nazionali a far fronte alle nuove esigenze con legislazioni idonee a mantenere, se non il “benessere”, almeno la pace sociale, sono tutti elementi che tendono a eliminare di fatto, nel tempo, le politiche nazionali del Welfare State per sostituirle con programmi mondiali di sopravvivenza del capitalismo e di esorcismo nei confronti della rivoluzione.
Brancolamenti economici e tentativi di progetto sociale
L’economia capitalistica moderna ci offre molti spunti per comprendere il passaggio necessario alla non-economia della società futura, dove sarà molto più semplice il controllo generale dei flussi di beni e di lavoro sulla base di una contabilità per oggetti e non per valore. Dove non vi saranno “ammortizzatori sociali” ma armonizzazione fra le varie componenti della società, che siano produttive o non ancora produttive, o non più. Per comprendere il passaggio alla società futura non c’è niente di meglio che comprendere ciò che già sta realizzando questa società, così com’è, con il suo controllo autoritario dei flussi di valore. Vi sono alcune difficoltà da superare, dovute soprattutto all’abitudine: per poter vedere la necessaria rottura dobbiamo avere in mente la società di domani, con tutte le sue caratteristiche di negazione della presente. Il procedimento contrario, cioè l’immaginare un’evoluzione graduale di questa società in una “migliore” non ci mostra nulla: invece di una trasformazione (passaggio ad altra forma attraverso la rottura della vecchia forma sociale) avremmo una ri-forma.
La forma sociale presente, basata sul valore, ha un “rendimento” bassissimo. Il fenomeno è stato analizzato a fondo in Scienza economica marxista e rimandiamo il lettore al testo. Ricordiamo soltanto che la nostra teoria dello sciupìo capitalistico non è un rigurgito di moralismo contro i capitalisti che s’ingozzano di plusvalore “rubato” ai proletari, ma una teoria della fisica dissipazione dovuta ad un sistema che cresce a ritmi e a rendimenti sempre più bassi. Una volta eliminata la dissipazione dovuta al capitalismo, la forza produttiva sociale esploderà verso utilizzi più razionali rispetto ai bisogni umani; eliminata la proprietà, non ci sarà ormai bisogno di Stato per indirizzare le energie (non più “valore”) in ogni direzione a salvaguardare nel miglior modo la riproduzione della specie nel suo ambiente. La società di transizione sarà abbastanza matura da adoperare lo Stato solo per eliminare in fretta le ragioni materiali della sua stessa esistenza, cioè per far estinguere le classi. Non per divinizzarlo insieme con la Patria Socialista, come successe in ambito di rivoluzione arretrata.
Non ci saranno più crisi da superare o da evitare. Ogni provvedimento per l’indirizzo delle energie sarà attività di specie e non stratagemma per continuare il ritmo dello sfruttamento e dell’accumulazione. Si estinguerà allora anche il partito di classe, sostituito da un organo specifico del corpo sociale. In questo contesto una diminuzione dell’utilizzo-dissipazione di energia non sarà considerata una catastrofe, come quando diminuiva il PIL, bensì sarà perseguita, progettata, in armonia con l’attenzione prestata a tutta la biosfera, di cui l’umanità è solo una parte.
Quando borghesi come i citati Keynes, Spengler e neo-malthusiani vari, affrontano il problema della dissipazione di valore sotto la spinta di una crisi gravissima quale la Grande Depressione degli anni ’30, lo fanno nell’ottica di chi vuole riprendere un ciclo aumentato di dissipazione senza che ad essa seguano effetti catastrofici. E per farlo cercano la cura per il capitalismo malato, lo drogano con ogni genere di doping. Keynes è il massimo esponente delle teorie dissipative dell’economia politica, il teorizzatore del lavoro inutile e del consumo sfrenato che rivitalizzano il Capitale. Egli non scherza affatto quando dice che scavare buche al solo scopo di riempirle, fare la guerra e costruire piramidi sono mezzi per sfruttare energia sociale a scopo di profitto. Anche quando traccia schemi asettici è come se impegnasse l’umanità ad un contratto faustiano con il Capitale: gli vende l’anima per avere punti di crescita, ma l’inferno è assicurato.
Di fronte alla catastrofe già avvenuta una volta, l’economista spaventato ha una sola preoccupazione: “Potrebbe ripetersi?”. La domanda è anche il titolo della celebre ricerca di Hyman Minsky, il quale afferma senza mezzi termini: “Due generazioni di cittadini e di uomini politici hanno vissuto nel terrore che lo spettro di quel grande crollo ritornasse. Uno degli obiettivi principali dei riformatori era quello di organizzare le istituzioni economiche e finanziarie in modo che il grande crollo non potesse ripetersi”.
Bene, finora ci sono riusciti, e c’interessa moltissimo sapere come hanno fatto, perché se il capitalismo è obbligato ad autolimitarsi, significa che ha incominciato a non essere più capitalismo. Siccome questo particolare modo di produzione è intrinsecamente instabile – ammette l’autore citato – il maggior avvenimento di questo dopoguerra è in realtà qualcosa che non è avvenuto: cioè, non c’è stata un’altra crisi catastrofica. I meriti di questo fatto straordinario, dato che c’erano invece tutte le premesse perché si ripetesse, sono attribuiti interamente all’intervento dello Stato. Se dunque lo Stato ha il potere di modificare l’indirizzo dei profitti e dei consumi (salari e investimenti), dovrebbe anche avere quello di esorcizzare le crisi catastrofiche per sempre. Esse infatti sono catastrofiche, storicamente inevitabili e cicliche solo quando non si sappia governare il processo di formazione del valore e la sua distribuzione. Keynes aveva una fiducia enorme nella possibilità di governare il capitalismo, perciò di eliminare le crisi e far vivere l’umanità nel benessere consumistico. Questo inno all’eternità del Capitale è significativo non tanto perché lo si può rinfacciare efficacemente nella polemica storica sulla realtà della miseria crescente, quanto perché ha un elemento tecnico di estrema importanza per noi comunisti: il valore prodotto può essere utilizzato al di fuori della volontà di coloro che ne hanno proprietà giuridica; vale a dire che i capitalisti, quando non siano eliminati dalla concorrenza, sono, almeno in parte, espropriati dal Capitale.
Sia Keynes che Minsky (quest’ultimo era consulente del governo americano quando scrisse il suo saggio), capitolano clamorosamente di fronte al marxismo: mentre nella teoria neoclassica dell’equilibrio – dice Minsky – il profitto è dato dalla produttività marginale degli investimenti moltiplicata per la massa del capitale investito (per noi: saggio di profitto per capitale anticipato), in una teoria dinamica che permetta di prevenire le crisi occorre sapere prima che cosa succede al profitto, cioè indirizzarlo; non basta un dato rilevato da serie passate. Affermazione davvero interessante perché, oltre a rappresentare in qualche modo un tentativo di rovesciamento della prassi, una politica secondo progetto, fa comparire nuovamente la nostra funzione di produzione. Infatti è il profitto-plusvalore che determina la produzione futura. La quale, a sua volta dovrà essere venduta, e lo sarà solo se posta di fronte ad una domanda solvibile. Alla fine questa dev’essere trovata per forza, a costo di stimolare il mercato, cioè suscitarlo, inventarlo. Da che il capitalismo è maturo, non è più il salario, cioè la parte di domanda solvibile rappresentata dai lavoratori, che stabilisce il livello della produzione di beni di consumo, ma viceversa. Il fenomeno è qualcosa di molto differente rispetto alla legge di Say (ogni volume di produzione trova da sé il suo mercato), che rifiutiamo. Nel nostro modernissimo caso interviene una doppia regolazione dovuta proprio alla maturità del capitalismo: 1) se il salario è, come lo definiamo sempre, la quantità di beni che serve a riprodurre la forza-lavoro, il valore di quest’ultima, cioè il suo prezzo medio di mercato, è stabilito dalla quantità di beni compatibile con date condizioni medie di vita (quelle cui si rivolge l’attacco pubblicitario prima di dar luogo alla produzione); 2) anche senza ipotizzare una produzione totalmente just in time, cosa impossibile, è comunque normale per l’industria adeguare con margini ristretti d’errore la produzione all’assorbimento del mercato. Lo stesso vale per i consumi industriali, cioè gli investimenti: essi sono richiesti non tanto dall’aumento della produzione e dall’obsolescenza materiale degli impianti quanto dalla concorrenza, che impone un ciclo di rinnovo sempre più frenetico, e sono programmati in base a dati abbastanza attendibili.
Come da antica polemica dei comunisti contro l’economia politica, la teoria del valore è in grado di informare in anticipo su che cosa succede nella società che produce e si riproduce, mentre la forma fenomenica prezzo è una realtà aleatoria che si forma in ritardo rispetto alla produzione e al comportamento del mercato. La nostra è una teoria e insieme un metodo di previsione, l’economia politica è una constatazione e un tentativo di rattoppo. Avendo rigettato la teoria del valore per ragioni di classe, i singoli capitalisti tentano di ricavare previsioni basandosi sull’andamento statistico della produzione e del consumo e ne proiettano la tendenza nel futuro. Ma lo Stato, capitalista collettivo, non può limitarsi a questo, deve avere un programma e intervenire sulla realtà cercando di prevenire disastri come quello del ’29 che ebbe uno sbocco solo con la più terribile guerra.
Ora, la Grande Depressione ha avuto l’effetto di illuminare parzialmente alcuni borghesi, far loro abbandonare le teorie meccaniche dell’equilibrio e spingerli alla ricerca di modelli dinamici. Avrebbero potuto raggiungere più in fretta i loro risultati copiando direttamente Marx. Avendo a disposizione gli strumenti matematici successivi, le teorie delle relazioni, quelle dei sistemi complessi e i modelli computerizzati, sarebbero stati in grado di capire meglio il loro stesso sistema. Ma non potevano ammettere il meccanismo principale di questo sistema, lo sfruttamento. Nel citato Vulcano della produzione è scritto a chiare lettere che il capitalismo descritto da Marx è meno disastrato e più efficiente di quello che scoprono i capitolatori quando smettono di farne l’apologia pura e semplice. Se non fosse così sarebbe già morto e sepolto. Quando i moderni economisti si spaventano per i disastri sociali che il capitalismo provoca, diventano apocalittici e indagano sui “limiti dello sviluppo” predicando la necessità di prendere misure drastiche altrimenti sarà la fine. Con tutti i loro computer non ne azzeccano una e i loro scenari si dimostrano persino più catastrofici dei nostri. Ciò avviene perché tengono conto soltanto del livello dei prezzi, della disponibilità di risorse fisiche (in fondo, della teoria della rendita) e della degenerazione dell’ambiente. Nella loro visione soggettivistica vedono i capitalisti correre verso il fallimento, ed è vero, ma non realizzano il fatto che il capitalismo si avvantaggia con la distruzione continua di capitalisti e capitali (lavoro passato, morto) e che ciò comporta un effetto sulla durata storica dello sfruttamento (dominio sul lavoro attuale, vivo). Il capitalismo non è eterno comunque, Marx in ciò era “crollista”, ma la sua esistenza può essere abbreviata soltanto dalla possibilità di un rovesciamento politico.
Se lo Stato, mediante una politica economica e sociale (Welfare State) si prende l’incarico di controllare il rovesciamento già avvenuto nella società, di controllare quindi il gioco della concorrenza, degli investimenti innovativi e produttivi, l’accesso ai mercati e il livello dei consumi, è chiaro che determina o perlomeno salvaguarda il livello dei profitti e dei salari (questi ultimi, proprio allo scopo di evitare la lotta di classe, sono intesi in senso lato, cioè sociale, come reddito destinato ai lavoratori produttivi, alle fasce improduttive, ai disoccupati, all’intervento di assistenza propriamente detta). La leva è quella ormai classica dell’imposta progressiva, del credito, dei tassi e dei sistemi assicurativi e previdenziali; agendo su di essa lo Stato controlla il mondo finanziario. Anzi, coalizioni di Stati tentano ormai di farlo anche a livello internazionale.
Che ciò avvenga operando direttamente o indirettamente non ha importanza, ma succede a livelli tali che parlare di capitalismo alla vecchia maniera per definire questo stato di cose è ormai un non-senso. In un testo della nostra corrente, Proprietà e Capitale, c’è un capitolo dedicato alla materiale formazione di una “economia comunista” già nella società attuale. Perciò la necessità di superare la vecchia forma sociale non si presenta nel programma comunista solo come “rivendicazione ideale”, ma come evidenza concreta dell’inutilità di strutture sopravviventi all’erompere della forza produtiva sociale, anche molto prima della rottura politica rivoluzionaria.
La forma schiavistica era già morta al tempo del tardo latifondo romano; la forma feudale era già permeata di traffici e manifatture capitalistiche; la forma capitalistica matura ha già sviluppato completamente tutte le strutture materiali utili alla società futura. Il sistema di massiccia ripartizione sociale del plusvalore, abbinato al controllo drogato dell’economia è addirittura un qualcosa che va oltre il “normale” capitalismo. Esso ci permette di anticipare possibilità pianificatrici ben più potenti, ricordandoci che l’umanità ha già conosciuto antiche società urbane, ancora comunistiche, in grado di indirizzare immense energie verso la costruzione di opere che lasciano stupiti ancor oggi. Chi si accinga a studiarle dal punto di vista dell’utilizzo dell’energia sociale si rende conto facilmente come, dal capitalismo alla società comunistica sviluppata, verranno liberate potenzialità ben più grandi per mezzo della scienza e della tecnologia moderne.
DOMANI
Premesse per la società futura
Ma allora, seguendo la nostra teoria che fa del capitalismo la base reale del comunismo, dobbiamo vedere anche in queste realizzazioni lo zampino della vecchia talpa che scava sotto lo scranno della borghesia. Dobbiamo provare soddisfazione di fronte all’insensato balletto dei neo-classici neo-liberisti, i quali predicano ad ogni piè sospinto privatizzazione e demolizione dello stato sociale. Di fronte a processi di socializzazione irreversibile, vorrebbero tornare all’epoca precedente la Grande Depressione, quando misure come quelle attuali non erano neppure immaginabili. Insensati, perché saranno costretti a fare il contrario: a rafforzare lo Stato, non a indebolirlo; ad investire di più per il controllo sociale, non di meno; ad essere proiettati verso il mondo, non verso la patria.
La crisi catastrofica incombe come una spada di Damocle sulla testa della borghesia, che non può più accontentarsi di descrivere i processi, ma deve prevederli e prevenire le conseguenze di andamenti rilevati da una continua e ossessiva osservazione. Per questo è costretta a scendere sul nostro terreno e a mostrare, più chiaramente che mai, con quanta ansia tenti di difendere il suo sistema barcollante.
Benché l’approccio keynesiano non sia inserito nella storia del Welfare State, o perlomeno sia tenuto separato, è evidente per noi che il maturare parallelo di entrambe le esigenze terapeutiche per il sistema capitalistico malato si inserisce in un capitolo unico della controrivoluzione. Per gli economisti classici e neo-classici l’approccio alla realtà della produzione e del mercato era quello di dare – con espedienti analitici – spiegazione dei fenomeni in un modello di equilibrio fra produzione, occupazione, consumo e altre variabili strettamente connesse. Per gli economisti keynesiani – e in questo consiste, nonostante le incongruenze teoriche, l’interesse del loro approccio – produzione, occupazione, consumo, ecc., vanno spiegati nel loro processo di variazione.
Per molti economisti borghesi Marx è da annoverare fra i classici, in quanto egli avrebbe utilizzato le categorie adattandole vuoi alla filosofia che da lui prende il nome, vuoi alle esigenze della lotta di classe. Tali enormi sciocchezze sono spazzate via da una sola considerazione: lo schema di riproduzione allargata è un modello a retroazione positiva altamente dinamico, tanto da portare ad una crescita esponenziale; invece i fattori politici e sociali che stanno intorno alla produzione rappresentano un modello a retroazione negativa, in grado di frenare e addirittura far saltare il sistema. Keynesismo e Welfare State rappresentano il tentativo di conciliare l’intervento politico sullo schema di riproduzione, cioè di trasformare la retroazione negativa in positiva. La crescita eterna.
Ovviamente è una stupidaggine. Dal punto di vista fisico e biologico niente può crescere eternamente. Perciò se il sistema cresce, salta in virtù del sopravvento della prima retroazione; se non cresce, salta lo stesso in virtù del sopravvento della seconda, che lo annichilisce. In ogni caso la forza produttiva sociale è frenata dal modo di produzione capitalistico. Il comunismo, come movimento reale fortemente distruttivo nei confronti del presente, è un processo dinamico perfettamente descritto da Marx. Il quale svolge nello stesso tempo la critica contemporanea ai classici e quella preventiva ai neoclassici, keynesiani e neo-liberisti (ai quali ultimi lo Stato piace un sacco quando privatizza i profitti e socializza le perdite).
Se ad un certo punto il capitalismo, nella sua corsa a permeare il mondo, invece di espandere internazionalmente il sistema del controllo sociale, che si chiami Welfare State o altro non importa, dovesse restringerne la portata e basare la propria sopravvivenza, rispetto all’inevitabile attacco della classe proletaria, soltanto sulla forza delle armi, sarebbe spacciato. Non è impossibile che si giunga a quel punto, ma sarebbe veramente una non-soluzione, disperata, finale. Per adesso assistiamo ad una espansione rozza e primitiva che si traduce in fondi d’aiuto e d’investimento a favore di zone disastrate, in proliferazione di organizzazioni internazionali di aiuto, in migliaia di campi profughi e rifugiati di tutti i tipi, in interventi per assorbire eccedenze agricole e industriali invendibili. Sta di fatto che oggi, come negli schemi di supporto alla produzione o in quelli di protezione sociale, c’è una crescente ripartizione di plusvalore non solo all’interno dei singoli paesi ma del mondo. L’ONU si occupa quasi esclusivamente di un dibattito politico sull’argomento, mentre la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Mondiale per il Commercio, autentici organi dell’esecutivo del Capitale, se ne occupano dal punto di vista pratico.
Non essendoci nello schema keynesiano le classi, il modello diventa farraginoso e poco chiaro. Non si capisce per esempio da dove piovano le difficoltà del sistema che si vuole “salvare”. Sembrerebbero alla fin fine dovute a semplici scompensi di distribuzione, perciò recuperabili con espedienti fiscali e di bilancio pubblico, mentre per noi sono dovute allo scontro fra produzione sociale e appropriazione privata del valore. Nonostante tutto, una cosa è chiara: lo schema keynesiano ci dice che il consumo è una funzione del reddito globale, anche se in maniera non proporzionale: cioè cresce l’investimento, cresce la produzione, cresce il reddito ma il consumo non cresce nella stessa misura. Come mai? Ecco la confessione: le fasce di reddito basso, quelle che potrebbero consumare di più, le più numerose, non possono; quelle di reddito alto sono poco numerose e hanno già tutto; gli investimenti si bloccano perché è bloccato il consumo e quindi si blocca la produzione. E’ una teoria del sottoconsumo? No, perché, esattamente come dice Marx, non esiste crisi da mancanza di consumatori solvibili (è una tautologia, ogni consumatore è sempre solvibile per quel che consuma). C’è crisi perché s’inceppa il sistema intero della produzione. Nella farragine keynesiana sono riflesse le leggi reali della crisi capitalistica.
Dunque il consumo totale non cresce della stessa quantità del reddito, dunque il capitale prodotto non è reimmesso nella circolazione. Paradossalmente, in questo schema assolutamente borghese, i proletari consumano per definizione tutto ciò che ricevono, mentre i colpevoli di poca “propensione marginale” sono proprio i “ricchi”. Se parte della popolazione possiede valore e non lo può consumare, la ripartizione forzata dei redditi esiste in potenza prima che a qualcuno venga in mente di escogitare teorie sociali per imporla. Nel sistema in quanto tale, la forza produttiva sociale mostra già la sua dirompente esuberanza, ma la sovrastruttura politica di classe non sa e non può far altro che utilizzare il valore in eccesso per rattoppare falle. Invece di sfruttare un gran numero di proletari, è costretta a mantenerli. A noi tutto ciò fa pensare immediatamente alle potenzialità della società futura, mentre a Keynes venne in mente una “teoria del rilancio della domanda effettiva” per eliminare definitivamente la povertà e salvare il capitalismo per sempre. In fondo era un ottimista.
Ma, ci chiediamo, se il capitalismo è giunto a questo punto, certamente irreversibile a meno di non immaginare uno scontro generalizzato e violentissimo fra le classi, e se la ripartizione del reddito all’interno della società ha raggiunto proporzioni così vaste da rappresentare un vero e proprio processo di espropriazione parziale delle proprietà, che cosa resta del libero mercato e soprattutto dell’essenza stessa del capitalismo?
Cancellazione immediata del Welfare State
Supponiamo di essere in una società che abbia messo una pietra sopra al dominio della borghesia. Nell’immediato essa si troverebbe ancora in una fase di transizione in cui vigono tutte le categorie precedenti, nessuna esclusa, perché è pura utopia pensare che dall’oggi al domani esse si possano eliminare con una serie di decreti. Che esistano capitalisti singoli inquadrati nel nuovo sistema politico o che vi sia capitalismo di stato non ha importanza, il problema è, appunto, politico, non economico, giacché anche l’economia sarà destinata ad estinguersi (lasciamo a fantasiosi utopisti frustrati l’immagine di una dittatura del proletariato giacobina, dove per “eliminazione” della borghesia si immagina qualcosa di molto letterale e tutto sommato meschino). In questo sistema la produzione avviene ancora per un mercato, le merci si scambiano secondo il loro prezzo oscillante intorno al valore, esiste l’equivalente generale denaro, e perciò esistono ancora gli asili, le scuole, gli ospedali, le pensioni e le assistenze a pagamento, non importa se nella forma differita dell’assicurazione sociale pagata con una ripartizione del valore tra le classi (che ci sono ancora, altrimenti a che servirebbe la dittatura del proletariato?).
Tale società futura ha già il potere effettivo di rompere i vincoli di valore anche se produce ancora valori, se cioè sfrutta ancora il lavoro umano per trarne plusvalore. Incomincia da subito a distruggere i rapporti di valore perché la produzione sociale viene spinta alle massime conseguenze; l’azienda viene gradualmente integrata in un sistema d’industria fino ad estinguersi; il complesso produttivo viene considerato sempre più un unico elemento della società, così come l’operaio globale già descritto da Marx produrrà una unica merce globale. Questa merce particolare verrà distribuita fra la popolazione, non da un’autorità al vertice di una piramide, ma da un sistema che l’umanità avrà progettato in modo che esso funzioni da solo, così come funzionano da sole le cellule di un organismo in base al loro DNA. L’autorità non sarà un uomo o un comitato, ma un programma sul quale saranno basati i movimenti degli uomini (che ne saranno i realizzatori) e dei prodotti.
In questa società il denaro circola come mezzo di conteggio e di scambio, ma non si accumula né nelle mani dei privati né viene raccolto da qualche ente statale per essere investito. Poco per volta il surplus si armonizza con le esigenze di riproduzione sociale e perciò si adegua a quanto è necessario per ristabilire le scorte e i processi di logorìo dell’apparato produttivo o, se così fosse utile, per aumentare le potenzialità generali e dare soddisfazione a nuovi bisogni. Nel tempo, certamente in tutto il mondo e non in un periodo molto lungo, la soddisfazione di questi bisogni perderà sempre più i suoi caratteri quantitativi (produzione per la produzione) e assumerà caratteri esclusivamente qualitativi (produzione per i bisogni umani).
Il primo passaggio è dunque una specie di capitalismo a riproduzione semplice e non più allargata, dove tutto il plusvalore viene “consumato”. Infatti l’accumulazione avviene a favore di tutta l’umanità, nessuno si appropria del surplus, l’investimento diventa direttamente consumo sociale. Finché esistono ancora capitalisti tramandati dalla società precedente, essi possono soltanto fornire le loro esperienze tecniche e organizzative, se ancora ne hanno. In una situazione del genere l’umanità impara presto a produrre solo ciò che è umanamente utile e dimentica persino il concetto di profitto. Poco per volta il conteggio in denaro viene sostituito con il conteggio in quantità fisiche: nel sistema produttivo generale, contano i “pezzi” prodotti e le ore occorrenti ad ottenere il risultato. Non più fabbrica per fabbrica, posto di lavoro per posto di lavoro, ma nell’insieme, in modo da tenere sotto controllo soltanto il rendimento generale del sistema.
In tale sistema, che avrà certamente un rendimento sempre più alto grazie al superamento dello sciupìo capitalistico, le quantità prodotte saranno distribuite secondo criteri di circolazione naturale, vi sarà una sorta di osmosi sociale, per cui non vi sarà più ripartizione sociale di plusvalore ma solo una diffusione naturale del prodotto.
L’asilo, la scuola, l’assistenza medica, le pensioni ecc. saranno “gratuiti”, ma non perché da qualche parte nella società gli uomini “pagheranno” l’ammontare dell’assicurazione sociale o le imposte come adesso. La società intera sarà come un sistema vivente in cui ogni organo svolge la sua funzione in armonia col tutto, e sarà quindi consapevole che l’asilo, la scuola, l’ospedale sono parte di sé, come lo sono la fabbrica o le strutture che ne rappresentano il sistema nervoso, come la circolazione sanguigna, il ricambio, le relazioni che rappresentano il metabolismo complessivo.
Non vi sarà “ripartizione del reddito”, perché nonostante la sopravvivenza di categorie ancora capitalistiche non vi saranno più redditi. Non vi sarà neppure prelievo di valore “alla fonte” perché sarà la società stessa a programmare la distribuzione di risorse là dove sono necessarie all’armonia del tutto. Invece di separare merci, servizi, produzione e “prestazioni gratuite”, essa unificherà ogni sfera dell’attività umana spazzando via la divisione sociale del lavoro, la differenza di natura fra le attività umane.
I salari, se avranno ancora questo nome, saranno rapportati a tempo di lavoro generico semplice e tutta la popolazione avrà qualche compito da svolgere. Il controllo che la società eserciterà su sé stessa tramite l’inventario e il movimento di quantità fisiche e non di valore, eliminerà alla fine ogni forma di “retribuzione”, registrando l’attività lavorativa di ognuno su un supporto qualsiasi come per esempio una scheda elettronica. Su di essa, anche quando ci sarà ancora scritta una cifra che ricorda il vecchio denaro, sarà registrata in realtà una semplice quantità di lavoro. Vale a dire che a questo punto non avrà nessuna importanza se un numero significa “dollari” oppure “ore di lavoro”, perché nessuno potrà accumulare quei numeri, chiedere un interesse, anticiparli come capitale che frutta plusvalore. Poi cadrà anche la necessità di “valutare” secondo il tempo di lavoro anche se rimarrà il rilevamento statistico di esso.
In una società che non sia basata sulla produzione di valore ogni programma keynesiano di previsione e di orientamento della domanda totale di merci non ha senso. E le specifiche politiche del welfare, essendo basate sulla ripartizione guidata del valore, si estingueranno rapidamente. Nell’immediato, anche quando il rovesciamento sociale avrà ancora a che fare con tutte le vecchie categorie del capitalismo, il Welfare State potrà essere abolito con una semplice decisione, stabilendone i tempi e i modi. E non saranno necessari molti anni.
Come dicevamo, non ci riferiamo a una “dittatura del proletariato” dura e pura che emana decreti tramite l’onnisciente partito da un centro pianificatore unico mondiale, visione caricaturale della rivoluzione che lasciamo ad altri. Nessun sistema complesso si lascia trattare come un teatro di burattini “cartesiano” e forse occorre precisare per l’ennesima volta, prima di concludere con la trasformazione reale della società, che cosa significhi per un comunista “rovesciamento della prassi”.
Lo faremo non con le parole dello schema classico della nostra corrente, ma con termini equivalenti mutuati dalla stessa conoscenza cui essa attinse. Cartesio partiva dal presupposto che gli elementi complessi, poco conoscibili, fossero più accessibili all’indagine qualora fossero scomposti nei loro elementi semplici. Il mondo cartesiano, rivoluzionario per la sua epoca, era un mondo riducibile alla somma delle sue parti, ognuna delle quali analizzabile separatamente, anche nello spazio e nel tempo. Cartesio immaginava di poter trattare a questo modo anche i corpi viventi, organi con funzioni specifiche, macchine fatte di “pezzi”, impalcature, collegamenti, leve. Prospettando una riduzione del complesso a semplice, del tutto alle sue parti costitutive, per poterle trattare e conoscere, aveva separato il corpo dall’anima, operazione al suo tempo temeraria. E una volta che le parti fossero state analizzate in quanto tali, esse potevano essere riunificate nel complesso da cui erano state divise, per cui il tutto risultava evidente all’indagine ancora e solo come somma aritmetica delle parti stesse. Oggi sappiamo che il pensiero “meccanicistico” è inadeguato rispetto alla conoscenza profonda dei fenomeni, ma già questa era una rivoluzione (più o meno contemporanea, tra l’altro, alla condanna di Galileo; fatto che spaventò Cartesio inducendolo a sospendere la pubblicazione dei suoi studi).
Questo approccio a una nuova teoria della conoscenza era rivoluzionario all’epoca perché frutto dello sviluppo delle forze produttive, che caratterizzava il capitalismo nascente. C’era la necessità di occuparsi delle applicazioni pratiche, di costruire macchine, di fare calcoli, di dare sistemazione alla tecnologia. La vecchia conoscenza speculativa era del tutto inadeguata a dare risposte. Occorreva quindi fondare una nuova conoscenza, renderla condivisa, toglierla dalle mani dell’artigiano, che la trasmetteva individualmente al figlio o al garzone, e metterla in quelle di una scuola che l’avrebbe trasmessa socialmente. Soprattutto occorreva toglierla dalle mani del vecchio Dio, che non la teneva in minima considerazione, quando invece sarebbe stata alla base della nuova società fondendosi con la nuova scienza.
L’inglese Francis Bacon, studiato e ammirato da Marx come progenitore del materialismo, poneva le questioni che qui c’interessano allo stesso modo razionalistico, e il filone si può seguire nei suoi sviluppi fino all’illuminismo e al positivismo scientifico. Tutto il capitalismo e specialmente l’economia moderna poggiano su una concezione cartesiana del mondo. Ma il mondo funziona in un altro modo, e la borghesia stessa l’ha ultimamente scoperto, utilizzando questa sua nuova consapevolezza con ottimi risultati.
In breve, la dinamica dei sistemi complessi dimostra che l’approccio alla conoscenza, e soprattutto il modo di intervenire per cambiare la realtà (applicazione della “volontà”, rovesciamento della prassi), non possono essere basati sui “pezzi” di un problema visti separatamente, e che anche il tutto va affrontato come un qualcosa in movimento, che non è mai uguale a sé stesso e che soprattutto è formato da parti interagenti, per cui la loro aggregazione dà risultati assai diversi che se fossero semplicemente sommate l’una all’altra. E per “dinamica” non si deve semplicemente intendere il passaggio fra un punto definito nel tempo e nello spazio ad un altro punto dopo che sia trascorso altro tempo; in questo caso non saremmo per nulla usciti dal “meccanicismo”, avremmo semplicemente fatto un confronto tra due fotografie scattate in istanti diversi.
Ciò significa che la conoscenza della dinamica insita nel modernissimo capitalismo – un sistema complesso che marcia verso la sua trasformazione – permetterà la progettazione del cambiamento ulteriore. Con questa conoscenza sarà cioè possibile varare un’apposita politica per trasformare gli iniziali flussi di valore in flussi di “valori d’uso”. I quali non hanno bisogno di rapporto sociale (tra classi) ma di rapporto umano (di specie). Per dare un’idea in flussi di valore di scambio basta riferirsi a poche cifre: in un paese moderno risulta mediamente occupato in attività qualsiasi, produttive e improduttive circa il 40% della popolazione; il reddito dei soli lavoratori produttivi è il 20% del monte totale dei redditi, cioè del valore totale da essi prodotto in un anno; il valore redistribuito dallo Stato in welfare è superiore all’ammontare dei salari dei lavoratori produttivi (di circa un 25%); ciò significa che l’energia sociale complessiva devoluta al welfare per mantenere la pace sociale costa alla borghesia più di quanto le costi l’intera produzione di merci e servizi vendibili (il capitale costante è anch’esso lavoro e come al solito lo rapportiamo a zero).
Inoltre non si tratta di un prelievo alla fonte per investimento da utilizzare in consumo differito nel tempo da parte del diretto interessato (pensione, malattie, incidenti, istruzione, ecc.), ma di un prelievo dal reddito attuale per pagare i beneficiari del welfare attuale, senza legami con coloro ai quali il prelievo viene fatto. In poche parole, è ormai superato il concetto di assicurazione, mentre vige una pura e semplice diversione immediata di valore a fini sociali. Già questo ci permette di immaginare quali risultati potrebbe raggiungere una società in cui raddoppiasse la popolazione dedita alla produzione vera e propria e in cui tutti i suoi componenti, dai bambini agli anziani, partecipassero in quanto cellule differenziate alla vita complessiva dell’organismo sociale.
Oggi invece la cosiddetta protezione sociale esiste perché ci sono i poveri cronici, coloro che sono sbattuti fuori dal ciclo produttivo, coloro che devono studiare per entrarvi, i malati e gli incidentati, i neonati che devono crescere e gli anziani da rottamare. Tutte categorie sociali che, non essendo direttamente produttive, servono solo a fabbricare plusvalore attraverso l’industrializzazione della crescita, della vita e della morte. Che soffrano o meno al Capitale non importa niente. Come si vede, già facendo un elenco discretizziamo il problema, dividiamo cartesianamente i “pezzi” della società, classificando grossolanamente fra produttori di valore e non, cioè, dal punto di vista capitalistico, tra utili e non. In una società organica questa divisione non esiste e l’individuo entra ed esce dal ciclo vitale (nasce e muore) senza aver smesso per un attimo di essere parte attiva della società.
Il capitalismo, come vanno strepitando gli economisti e i governanti, ha effettivamente un problema grave, gravissimo, mortale. Oggi un individuo è “ragazzo” fino a trent’anni e rimane nel ciclo produttivo per ben poco tempo rispetto alla durata della vita; la maggior parte della popolazione attiva si dedica ad attività che sempre più riciclano valore altrui anziché produrne; gli anziani non possono essere trattenuti al lavoro lasciandone fuori i giovani. Perciò fra non molto l’uomo, in grado di raggiungere facilmente 90 anni di media e mandato magari in pensione a 70, dovrà essere mantenuto per una cinquantina d’anni in confronto ai quaranta di lavoro (cfr. figura). Ma da chi? Nessuna società capitalistica, per quanto opulenta, riuscirà a risolvere questo assurdo. Invece la società futura lo risolverà immediatamente, semplicemente eliminando la differenza fra tempo di lavoro e tempo di vita, e mettendo così da parte la suddivisione cartesiana in categorie distinte dedite a produrre valore, distribuirlo, fagocitarlo da parassiti. Semplicemente considerando la specie intera come un insieme complesso e dinamico che vive ed evolve, non che consuma (cioè, secondo i sinonimi: sciupa, logora, distrugge, guasta, esaurisce, erode, dilapida, sperpera, dissipa, ecc. ecc. Com’è potente la lingua, strumento più antico della società del valore, e quindi più sincero).
Una formazione economico-sociale già pronta
Il capitalismo moderno ha già lavorato per noi, le potenzialità per una formazione sociale più avanzata ci sono già. Basterà la liberazione delle potenzialità attuali non solo ad aprire la strada ad una forma di economia superiore, ma a condurre al superamento dell’economia stessa. Ritorniamo all’immagine dell’avvenuta conquista del potere in un paese capitalisticamente avanzato e dei problemi che si presentano all’amministrazione della società nuova. Sappiamo che la somma dei prezzi è il valore totale e che questa grandezza di valore, di fronte ad una situazione generalizzata che non permette più l’appropriazione privata del plusvalore, è assimilabile a mera energia sociale, rappresentabile con ore di lavoro o unità di misura qualsiasi. La vecchia suddivisione, che vedeva il 20% della produzione totale andare ai produttori e l’80% a qualcun altro che ne beneficiava senza produrre, è caduta ed ora si possono fare altri calcoli. Per esempio, se ci basiamo sulla situazione giapponese mostrata dalla figura, vediamo che coinvolgendo nella produzione i giovani e gli anziani si può tranquillamente recuperare già immediatamente un buon 30% di energia produttiva e giungere al 50 invece del 20%.
Un altro recupero di rendimento si può agevolmente ottenere dalla natura della produzione, che ora potrà essere mirata al contenimento dello spreco: l’Istituto Battelle di Ginevra aveva calcolato qualche anno fa che la produzione di un’automobile che durasse vent’anni invece di dieci richiedeva un dispendio di energia (in tep, tonnellate di petrolio equivalenti) superiore del 16%, ma per via della durata permetteva un saldo finale, del 42% netto di risparmio. Ora, è certo che avere a disposizione i dati sull’automobile non è la cosa migliore, poiché la razionalizzazione sociale in questo campo sarà ancora più drastica con la limitazione del folle proliferare del trasporto privato; ma essi sono molto indicativi e vanno per esempio considerati insieme con quelli sul rendimento in altri settori, come l’agricoltura (cfr. l’articolo sul numero scorso). Oppure con gli effetti che avrebbe l’eliminazione di settori che non producono nulla e dissipano soltanto, come tutti i servizi legati al denaro, banche ecc.
Ciò che importa è che, da qualunque punto di vista si effettui il confronto, si riesce a salire agevolmente e grandiosamente sulla scala del rendimento sociale e quindi a distribuire meglio sia l’attività degli individui che gli individui stessi in confronto alle attività necessarie. Se invece del lavoro coatto e mercificato abbiamo semplice e libera attività umana, non c’è nulla di strano nel farvi partecipare anche i bambini e gli anziani, come succedeva nel comunismo primitivo. I primi assorbiranno esperienza e dilateranno le loro possibilità conoscitive e sociali imparando e producendo utilmente in compagini altamente organizzate come l’industria (la scuola come viene intesa oggi sarà un ricordo del passato e il bambino utilizzerà gli strumenti del linguaggio, mano, parola, scrittura, capacità di relazione, gesto produttivo, in un processo unitario); i secondi metteranno a disposizione capacità affinate dall’esperienza e conoscenze che oggi, in mancanza di una staffetta fra generazioni sui luoghi di lavoro, devono essere ricostituite ogni volta con una “formazione” specifica e anch’essa sottoposta alle leggi del valore, essendo la conoscenza trattata come “investimento” sull’uomo, esattamente come si fa con le macchine, gli impianti e le infrastrutture.
La società attuale produce pseudo-programmi prospettando di far lavorare gli anziani solo perché non può mantenerli in pensione (né sterminarli), e di far studiare – e quindi mantenere – i giovani fino a trent’anni solo perché non ha lavoro per essi; prospettando nello stesso tempo investimenti produttivi e perciò il licenziamento di lavoratori che vanno ad ingrossare ancor più l’esercito della sovrappopolazione inutile; prospettando l’eliminazione del pensionamento pubblico a favore di quello privato senza chiedersi dove saranno investite “produttivamente” le immense, ulteriori raccolte di capitali. Quest’ultimo ritornello della moderna economia politica è addirittura il più assurdo: i paesi che si basano sulla raccolta previdenziale privata devono gestire fondi pensione per una massa finanziaria che va dal 60% del PIL canadese al 140% di quello svizzero, passando dall’80% di quello degli Stati Uniti. Innalzare ulteriormente l’età pensionabile, come si continua a predicare, quando i posti di lavoro non aumentano e quindi l’unica via d’uscita diventa quella di ritardare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è un non-senso che fa ingigantire il problema dei fondi raccolti. La tabella ci ha mostrato chiaramente che nelle fasce d’età precedente e successiva a quella lavorativa ci saranno molto presto più anziani che giovani, perciò per ogni anno di non-pensionamento degli anziani occorrerebbe già da adesso ritardare più di un anno l’assunzione dei giovani. L’età media effettiva di ingresso al lavoro nell’Unione Europea è 28 anni, quella effettiva di pensionamento è 60 anni (62,5 negli USA): portare quest’ultima a 65 significa innalzare l’ingresso dei giovani a più di 33, con tutto ciò che ne consegue rispetto all’economia e all’impaludamento sociale.
I pochi numeri che abbiamo presentato, rapportati non a denaro ma a ore di lavoro e sfrondati dallo sciupìo capitalistico, ci permettono di percepire con chiarezza che la società futura non avrà i problemi attuali, per la semplice ragione che anche solo dal punto di vista quantitativo della distribuzione del lavoro (che comunque non è certo un obiettivo sufficiente) tutto è già risolto. La nuova società non ha bisogno che del passo politico, nulla deve maturare ancora. Naturalmente neppure il processo politico s’inventa, ma è chiaro che l’umanità si trova di fronte a molti fenomeni che si potrebbero già trattare come non-problemi se “soltanto” si potesse dar corso alle nuove potenzialità. Già da oggi saremmo perfettamente in grado di integrare l’attività di tutti, dai neonati ai vecchietti non nel lavoro salariato che produce plusvalore, che poi occorre obbligatoriamente investire, ma nell’attività di produzione e riproduzione globale, senza partita doppia e surplus monetario finale.
La proprietà privata non solo degli oggetti e dei capitali, ma di tutto il globo terrestre apparirà assurda e l’homo faber, artefice della sua vita e dell’ambiente che lo circonda, cancellerà in fretta la sua storia “proprietaria”, brevissima parentesi tra i due milioni d’anni di comunismo primitivo del passato e gli ancor più numerosi di comunismo sviluppato che verranno. Quando Marx affronta il problema della proprietà basilare, quella della terra, lo imposta nella dinamica storica che vede un passaggio continuo di generazioni, per cui “un’intera società, una nazione, e anche tutte le società di una stessa epoca prese complessivamente, non sono proprietarie della terra. Sono soltanto i suoi possessori, i suoi usufruttuari e hanno il dovere di tramandarla migliorata, come boni patres familias, alle generazioni successive”. La borghesia, per parte sua, ha capitolato clamorosamente anche di fronte al suo ultimo baluardo, quello della proprietà, perché tutto il discorso sul welfare e sul keynesismo verte sul fatto che nel mondo sviluppato attuale una buona metà del capitale esistente è espropriato e indirizzato artificialmente nella società. Il capitalista, invece di essere il soggetto della proprietà privata, cioè chi priva qualcun altro del capitale, diventa l’oggetto della privazione, è espropriato. Certo, lo è a favore della proprietà e per la salvaguardia dei suoi stessi interessi (finché sopravvive), ma la proprietà non è più l’elemento essenziale, quel che conta è la sopravvivenza della classe che la rappresenta, ormai classe virtuale, memoria di sé stessa.
Ma la capitolazione più significativa sul piano della percezione da parte della classe dominante è proprio l’indirizzarsi di alcuni borghesi verso forme ibride di teoria economica. Un esempio è la scuola di J. W. Forrester, legata alla dinamica dei sistemi, che si basa su modelli computerizzati in grado di elaborare migliaia di relazioni in successione, modelli che vengono “caricati” con i dati dell’economia reale, verificati su serie di variabili del passato, quindi conosciute; i loro risultati sono, è vero, influenzati dall’operatore che gestisce il programma, ma offrono una buona visione dell’andamento critico e “al limite” del capitalismo, mostrano cioè curve di sviluppo dall’andamento asintotico, verso lo sviluppo zero o addirittura verso catastrofi irreparabili (com’è noto i comunisti sono “catastrofisti”). Un altro esempio è la scuola di Georgescu-Roegen, che tratta l’economia come scambio di energia in un sistema termodinamico chiuso, quindi entropico (dissipativo), e che viene anch’essa sul nostro terreno degli schemi di riproduzione allargata a rendimenti decrescenti. A livelli ancor più vicini a un approccio globale, sono stati sviluppati, presso istituti come il MIT, modelli dinamici di simulazione che vanno oltre il semplice schema economico e incominciano a tener conto di fattori diversi dalle risorse, dai capitali e dalle politiche economiche, e a integrare il mondo intero, la biosfera e anche l’energia che giunge dal Sole (pioniere di questa tendenza fu Carl Madden, scomparso prima di poter dare sistemazione alle sue teorie). Infine, serbatoio di inaspettate quanto fertilissime capitolazioni di fronte al marxismo, la scuola interdisciplinare, o meglio, olistica (una sola disciplina onnicomprensiva e non un collegamento fra discipline separate) di Santa Fe, che esplora il movimento delle molecole umane in relazione all’ambiente che le ha prodotte e a quello che esse stesse producono, tendendo a considerare il mondo come un unico sistema complesso, prodotto particolare di un universo dal quale dobbiamo smettere di sentirci estranei.
Insomma, la società nuova preme con forza su quella presente e ne scombussola persino le premesse ideologiche e scientifiche. Questo fenomeno ci dà la misura di come sia diversa dall’utopismo la dottrina che impropriamente deriva il suo nome da Marx. La nostra previsione sulla scomparsa del Capitale e della proprietà va ben oltre ogni immaginario sistema “pensato” od ogni “realistico” trasferimento di valore e proprietà dal soggetto individuale a quello sociale (si estinguerà pure questo soggetto, lo Stato). La nostra previsione si legge nella dinamica di questa società, nel suo necessario divenire, cioè nella liberazione quantitativa dovuta allo sviluppo capitalistico della forza produttiva sociale, dinamica che ormai si esprime, per chi in essa sa leggere, anche come liberazione qualitativa. E’ oltremodo interessante notare che sta contemporaneamente morendo la visione volgare del partito, organismo che gli opportunisti e i sinistri poco preparati considerano ancora in termini quantitativi, mentre nel cervello sociale stanno esplodendo ovunque gli interessi verso i fenomeni qualitativi, anche dal punto di vista dell’organizzazione sociale.
Il passaggio dal welfare e dalle alchimie sulla ripartizione del plusvalore ad un organico metabolismo sociale con il suo ricambio molecolare, biologico, tra uomini e tra questi e l’ambiente, è uscito dai lavori di Marx e ha conquistato la scienza del nemico, tanto che lo si può leggere agevolmente nella sua produzione di punta. Per quanto occorra saper sfrondare i vari documenti dai fronzoli ideologici della borghesia, l’utopia è uccisa per sempre dalla realtà in movimento.
Mentre la natura utopica dei modelli ideali predispone i loro fautori ad attendersi la realizzazione di una società migliore da un’opera di persuasione e di reclutamento alle idee giuste ecc., la natura materiale del movimento che cambia la società ci mette sotto gli occhi un potenziale che nessuno dovrà creare; esso esiste, trasforma, distrugge ostacoli verso il futuro, dimostra le leggi del comunismo in divenire e resiste a qualsiasi critica. Chi rinuncia alla possibilità di mostrare con ogni mezzo la società futura sulla base delle evidenze attuali o addirittura lo rifiuta come metodo comunista e si culla nel metodo opposto, nell’utopia dei costruttori di società e di partiti non fa parte dell’attuale rivoluzione: “Nella sua sufficienza filistea – afferma la nostra scuola – questo metodo non è che il preparato alibi per le cricche politiche professionali, che non hanno mai sentita l’altezza della forma partito e l’hanno ridotta a palcoscenico per le contorsioni di pochi attivisti”. E aggiunge: se queste cricche dovevano ritornare a concezioni esoteriche, non visibili a tutti, o limitarsi a manovre politiche per conquistare adepti in quantità, tanto valeva che restassero nelle sacrestie ad attendere il rivelarsi del verbo divino o stazionassero in permanenza nelle anticamere del potere, dove per i servi ci sono sempre dei piatti da leccare.
Il Welfare State non è argomento da rivendicazione comunista e neppure sindacale. L’operaio deve rifiutare l’ingabbiamento della sua condizione in contratti che lo legano all’avversario; deve rifiutare gli automatismi stabiliti per legge che lo inchiodano alla società capitalistica. La sua garanzia è nella forte organizzazione, in grado di mobilitare i proletari in qualsiasi momento, senza preavviso e senza programmazioni, per gettare in campo la forza e non la legislazione. Ma questa prospettiva può essere capita solo da chi non ha nulla a che fare con la mentalità leguleia del riformista e del “sindacalista” di professione, azzeccagarbugli che invece vivono sulla definizione delle regole, sul loro mantenimento e sull’attività sbirresca per farle rispettare in quanto legge.
Noi vediamo nel sistema della protezione sociale a carattere mercantile un ostacolo da demolire e da sostituire con ben altro che gli articoli di un codice e i trasferimenti di plusvalore. Siamo per la negazione perché nella società futura non ci saranno politiche del welfare, e ribadiamo che la vera politica comunista consiste nel proiettare il futuro nell’oggi, mentre in genere non si fa che proiettare l’oggi nel futuro, come nei peggiori film di fantascienza (qualcuno riesce a definirsi comunista addirittura proiettando il passato nel futuro, come fa chi fonda la propria concezione del mondo sulle arretratezze borghesi dello stalinismo, del maoismo e di altri “ismi” analoghi).
Esplosione della società futura
Sviluppando i temi sfiorati da Carl Madden, un filone economico-sociale tra quelli prima elencati elabora le sue valutazioni sulla società e sul suo progresso a partire dalla trasformazione dinamica che avviene su uno stock globale che l’umanità in un certo momento della sua esistenza eredita dalla storia del pianeta e da quella delle società e generazioni precedenti (cfr. Giarini). L’accumulazione sarebbe un fenomeno complesso che riguarda non solo il Capitale, coinvolto in minima parte nel sistema-Terra (e Terra-Sole) ma soprattutto l’intero ambiente e l’intero percorso storico che ha portato all’esistenza della “società monetizzata”, la quale, a sua volta, evolve in modo contraddittorio: da una parte accumula nel suo ciclo; dall’altra disaccumula nel ciclo globale, cioè consuma ciò che la natura ha accumulato in milioni di anni. In questo curioso modello gli impianti, le costruzioni ecc., tutto ciò che normalmente viene considerato capitale fisso, è invece considerato capitale che fluisce con il perenne suo utilizzo nel ciclo di produzione: come in Marx viene rapportato a zero. Il capitale monetario, inoltre, è considerato a parte, come un valore d’uso necessario, nell’attuale periodo che l’umanità sta vivendo, per sviluppare la forza produttiva sociale e andare oltre.
Qualunque utilizzo venga fatto di un modello del genere (ed è chiaro che si tratta, nel caso degli autori, di salvaguardia di un capitalismo “dal volto umano”), a qualunque linguaggio si ricorra per descriverlo, le conseguenze estreme che se ne possono trarre è che non più di capitalismo si tratta ma di altro. La “gestione” dello stock è la chiave di volta del modello, ma anche in Marx la proprietà della terra, intesa quest’ultima in senso lato, è la chiave di volta di tutto il problema sociale. Proprio il trattamento della terra, che gli uomini ereditano e che hanno il compito di tramandare ai posteri intatta o migliorata, mai esausta e peggiorata, dev’essere indirizzato al miglior sviluppo futuro dell’umanità. Tutta la specie umana sarà dedita a questo compito. Non sarà suddivisa in lavoratori “produttivi”, non produttivi, capitalisti, sovrappopolazione relativa, madri, bambini, vecchi, malati e parassiti. Nel nuovo metabolismo sociale non ci saranno poveri da assistere, pensionati da pagare o “propensioni marginali al consumo” da stimolare. Il lavoro delle madri e dei cuccioli umani nel garantire la continuità biologica della specie avrà “valore” identico a quello degli anziani nel garantire la continuità della conoscenza e dell’esperienza, complemento biologico delle biblioteche cartacee ed elettroniche. E non si chiederà a nessuno se ha pagato la tessera sanitaria quando si ammalerà o si spaccherà la testa cadendo.
Sistemato l’individuo al suo posto come cellula dell’organismo sociale, neppure i miliardi di individui che popoleranno la Terra saranno l’umanità, la specie umana, ma rappresenteranno una parte di essa entro il limite temporale delle esistenze singole, delle generazioni, delle epoche. Per la prima volta nella sua storia, coscientemente, scientificamente, l’uomo che vivrà nell’arco di un certo periodo si subordinerà alla specie, cioè si organizzerà in funzione non dell’attimo fuggente della sua propria vita e dell’aumento di capitale altrui ma ai fini dell’umanità a venire. Solo così l’individuo realizzerà anche sé stesso come uomo.
L’ingenua visione dell’economista che immagina uno stock universale con tanto di denaro e accumulazione capitalistica è ibrida, ma è certamente il frutto di una forte pressione materiale da parte della realtà in movimento. Marx fonda la sua teoria del futuro sulla differenza tra proprietà e usufrutto. Nel linguaggio corrente la proprietà è permanente, l’usufrutto è temporaneo. Nel diritto borghese la proprietà comporta il diritto di usare e di abusare del suo oggetto, mentre nell’usufrutto il diritto prevede solo l’uso ed esclude l’abuso. L’economista vede il problema e rileva che gli obiettivi della produzione capitalistica cozzano contro il limite dello stock, della sua natura, la quale non può sopportare una pura e semplice dissipazione. Introduce quindi un concetto giuridico: l’obiettivo locale non può essere disgiunto da quello globale, ma quest’ultimo comprende la natura e le generazioni future, ergo non si può affrontare il problema della produzione e dell’accumulazione attuale, transitoria, senza porre limiti alla libertà. Occorre cioè che vi sia uso senza abuso, un’assunzione di responsabilità verso il genere umano. L’economista borghese, costretto dalla teoria della dinamica dei sistemi, recita a modo suo un requiem alla proprietà.
Siamo già andati oltre le argomentazioni del politico, del giurista e dell’ambientalista che disquisiscono sui limiti sociali dell’inquinamento ecc.; la loro preoccupazione è di rattoppare il sistema in modo che si possa respirare e continuare a produrre, ricavando magari ulteriore plusvalore anche con i rattoppi, sperando di evitare problemi fra le classi, disturbi della tranquillità di sfruttamento o addirittura ribellioni. Siamo quindi, di nuovo, andati oltre la società borghese già in ambito borghese. Questa concezione olistica borghese scaturita nel tentativo di risolvere problemi della borghesia, non somiglia più né agli schemi keynesiani né alle misure legislative di Lord Beveridge per la protezione sociale. Ci dimostra come una prova sperimentale che il passaggio è stramaturo.
Integrata ogni componente sociale nella produzione e riproduzione di specie, sarà anche bloccata la dissipazione della conoscenza operata dalla società attuale, che giunge ad elaborare scienza ma poi la sterilizza, la rinnega, se questa dimostra la caducità del capitalismo o se non produce immediatamente profitto. Perciò, ridotto anche al minimo il tempo di lavoro necessario, che sarà collegato al tempo di vita in cui lavoro e altre attività anche gioiose non sono distinte, l’umanità farà esplodere ogni possibilità di conoscenza per badare a sé stessa in un tutto organico, e non avrà bisogno di uno Stato con i suoi “interventi sociali”. Sparito il Capitale, lavoro morto che dominava il lavoro vivo, anche l’enorme accumulo di manufatti che ricopre il pianeta – altra ex manifestazione solida e palpabile del lavoro morto – rappresenterà un patrimonio da rigenerare a nuovi compiti e da passare alle future generazioni. Come la terra non può essere data in proprietà a nessuna classe in particolare senza consegnare l’intera società a quella classe, così l’industria e tutto ciò che rappresentava “capitale fisso” e “immobiliare” saranno trattati al pari della terra e presi in usufrutto dall’umanità vivente. Nessuno avrà “diritti”, nessuno dovrà essere salvaguardato dalle differenze di distribuzione di valore.
Letture consigliate
- Karl Marx, Il Capitale, Libro I, cap. XIII (sul pauperismo, su Malthus, sulla sovrappopolazione relativa come legge generale dello sviluppo capitalistico).
- Partito Comunista Internazionale, Vulcano della produzione o palude del mercato? (dal paragrafo 30: “L’economia del welfare”, al paragrafo 44: “Parassitismo e malessere”); Scienza economica marxista come programma rivoluzionario; Proprietà e Capitale. Tutti pubblicati nella nostra collana Quaderni Internazionalisti.
- Bruno Jossa, Economia Keynesiana, Etas Libri.
- Pierre Delfaud, Keynes e il keynesismo, Lucarini.
- Hyman P. Minsky, Potrebbe ripetersi?, Einaudi.
- Orio Giarini, Dialogo sulla ricchezza e il benessere, Mondadori Est.
- The Economist, “Pensions – Time to grow up”, 16 febbraio 2002.
- Federico Caffè, Economia del benessere; Ernesto Rossi, Sicurezza sociale, entrambi in Dizionario di economia politica, Edizioni Comunità.
- Attilio Esposto e Mario Tiberi (a cura di), Federico Caffè, realtà e critica del capitalismo storico, Donzelli Editore.
- Mariano d’Antonio (a cura di), La crisi post-keynesiana, Boringhieri.
- Istat, Rapporto sull’Italia 2001, Il Mulino.
“È chiaro che una critica basata sul richiamo ad una situazione futura che nessuno ha ancora osservata o rilevata incontrerà sempre la fiera derisione di quelli che sono soliti dileggiare il dogmatismo, o perfino la ricaduta nella utopia, di noi marxisti rivoluzionari. In tutte le nostre lunghe ricerche noi abbiamo citato mille e mille passi in cui si vede che Marx fa sempre in modo esplicito il paragone tra le caratteristiche del processo capitalistico e quelle della produzione futura e società futura, dato preciso per il quale egli tiene il comunismo in atto, pur designandolo sotto diversi nomi e perifrasi. Ciò in tutte le opere, nei tre Libri del Capitale, opera massima, e possiamo dire in ogni capitolo di essa, anche se per mostrarlo appieno il lavoro critico deve saper gettare ponti sicuri tra pagine anche lontanissime tra loro” (da Scienza economica marxista come programma rivoluzionario).
FONTE: https://www.quinterna.org/pubblicazioni/rivista/07/estinzione_welfare.htm
Gas: le società tedesche iniziano a tagliare i contratti ai clienti

La DEP Deutsche Energiepool GmbH della Bassa Sassonia ha annunciato venerdì che avrebbe “cessato completamente la fornitura nazionale di gas naturale“. Molti clienti hanno già avuto la risoluzione dei contratti di fornitura. L’azienda ora vuole “concentrarsi sui servizi nel settore energetico”.
Negli ultimi mesi i prezzi di approvvigionamento di gas naturale ed energia elettrica sul mercato a termine sono triplicati e i prezzi per gli approvvigionamenti a breve termine sono aumentati di circa cinque volte, la società ha giustificato il drastico passo: “Quasi nessuno nel mercato dell’energia si aspettava un simile sviluppo rapido e senza precedenti».
Ad agosto 2020 un megawattora di gas naturale costava 4,80 euro nel mercato spot. Nel frattempo sono stati raggiunti prezzi di 75,04 euro. La crescita potrebbe non finire subito.
L’andamento del mercato spot riflette i picchi di prezzo, ma di fatto la situazione sul mercato del gas europeo è peggiorata in tutta Europa negli ultimi mesi. Dopo un inverno freddo in cui gli impianti di stoccaggio del gas sono stati svuotati, la domanda di gas è rimasta insolitamente elevata. Da un lato, l’economia globale si è ripresa molto più velocemente del previsto dopo la pandemia di corona. Quindi la fame di gas dell’Asia, per vari motivi, ha mandato il prezzo alle stelle sul LNG.
I prezzi per questa fonte energetica fossile sono aumentati in modo insolitamente forte da gennaio. In media a lungo termine, un megawattora (MWh) di gas naturale costa normalmente tra i 15 e i 20 euro. Tuttavia, il prezzo è attualmente di 65 euro per MWh. La situazione in Gran Bretagna è particolarmente tesa. Sette compagnie energetiche sono già fallite quest’anno.
I clienti interessati di Deutsche Energiepool continueranno a rifornirsi di gas. La società energetica Eon ha annunciato che sarebbe intervenuto. Secondo le sue stesse dichiarazioni, l’azienda è il fornitore di base e sostitutivo responsabile in “gran parte della Germania” e deve garantire la consegna, di solito a prezzi più elevati rispetto ai fornitori a basso costo su Internet.
A differenza dei fornitori a basso costo, i fornitori tradizionali non acquistano a breve termine, ma acquisti scaglionati sul mercato dei futures. “Acquistiamo le quantità di energia necessarie a lungo termine e con lungimiranza per evitare i picchi di prezzo che stiamo vivendo attualmente nell’interesse dei nostri clienti”, ha sottolineato Christoph Müller, Energy Manager di Eon. Questo salvaguardia le forniture, ma solo parzialmente: i picchi devono essere acquistati sui mercati spot ed è complesso coprire solo con i future le forniture. Inoltre i contratti di consegna devono essere rispettati per dare vera tutela.
FONTE: https://scenarieconomici.it/gas-le-societa-tedesche-inziano-a-tagliare-i-contratti-ai-clienti/
Ma la retorica pauperista non aiuta i poveri
di Umberto Minopoli 14 Ottobre 2018
Basta con la retorica, a sinistra, su povertà e diseguaglianze. Si sta sbagliando tutto: analisi, diagnosi e, soprattutto terapia. E alla fine ci troveremo, statene certi, con i poveri aumentati e la società più appiattita e stagnante.
La retorica delle diseguaglianze
La retorica sulle diseguaglianze e povertà e sta diventando, a sinistra, una sorta di richiamo, di segno distintivo, di artificio semiologico per prendere le distanze dal riformismo, dal gradualismo, dall’ottimismo sulla crescita. La tesi è quella antica e classica della sinistra massimalista: la diseguaglianza si combatte con la redistribuzione. E con il dirigismo dello Stato (governo e politica); lo sviluppo dell’economia, la crescita del Pil e una visione liberale dell’economia tendono, naturalmente e spontaneamente, ad allargare le distanze e lasciare indietro gli esclusi; la povertà si combatte redistribuendo dai ricchi ai poveri.
Questa visione è falsamente attribuita al riformismo socialdemocratico classico e al liberalismo sociale keynesiano. Una impostura.
Le ricette socialiste e il liberalismo sociale degli anni 40/70, del “trentennio” del welfare occidentale, redistribuivano quello che la ricchezza creava col dinamismo e lo sviluppo. La priorità era la crescita per redistribuire. Non la redistribuzione per stagnare. E’ il populismo che sta imponendo questa idea stagnazionista, pauperista, distorsiva della lotta alla povertà attraverso la decrescita. E la sinistra, subalterna, idealmente impoverita, priva di identità, le va dietro. Meschina.
L’assistenzialismo non protegge i più poveri
Fare della povertà un obiettivo redistributivo sganciato e separato dalla crescita economica, priorità assoluta, è solo retorico. Ed è inefficace e controproducente: non accorcia i divari ma li allarga; non diminuisce la povertà ma l’accresce.
Gli Stati moderni governano ormai quote limitate del bilancio pubblico. Se le dirottano verso l’assistenza invece che verso la crescita, l’economia si inviluppa e la povertà si accresce. Dirottare risorse decrescenti verso impieghi assistenziali e improduttivi non protegge i più poveri. In cambio moltiplica gli effetti stagnanti in economia. Che aumentano divari, ineguaglianze e povertà.
Costringe lo Stato a finanziare i programmi redistributivi sottraendo risorse agli investimenti e agli altri settori moltiplicativi dello sviluppo ( scuola, ricerca, università, innovazione) e mantenendo un’alta tassazione sul lavoro e sulle imprese.
La lotta alla povertà si fa con lo sviluppo
La lotta alla povertà si fa all’opposto: facendo della redistribuzione, dell’assistenza, della protezione un “di cui” della crescita, degli investimenti, dell’innovazione. E delle “riforme” che allarghino il lavoro, la produttività, il dinamismo, riducano la burocratizzazione, gli impieghi improduttivi, i divari territoriali. La sinistra, ormai, non si divide più tra riformisti e rivoluzionari.
Ma tra due anime altrettante inconciliabili: quella populista, critica del riformismo e dell’ottimismo liberal-socialista abbacinata dalla predicazione pauperista e della decrescita e quella, invece, che ritiene, ancora, che il capitalismo non vada tosato con la redistribuzione di risorse scarse ma vada governato per accrescere le risorse. Con lo sviluppo. La vera e irriducibile distanza tra riformisti e populisti è tutta qui. Anche nella sinistra. Ed è bene che emerga. Anche nel Pd.
Presidente dell’Associazione Italiana Nucleare. Ha lavorato nel Gruppo Finmeccanica e in Ansaldo nucleare. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle Attività Produttive tra il 1996 e il 1999. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dei Trasporti dal 1999 al 2001. Consigliere del Ministro dello Sviluppo Economico per le politiche industriali tra il 2006 e il 2009.
FONTE: http://www.libertaeguale.it/ma-la-retorica-pauperista-non-aiuta-i-poveri/
LA LINGUA SALVATA
pauperismo
pauperismo s. m. [der. del lat. pauper –ĕris «povero», sull’esempio dell’ingl. pauperism, fr. paupérisme]. – 1. Fenomeno economico e sociale per cui in determinati periodi larghi strati della popolazione sono colpiti dalla miseria in conseguenza di un complesso di fattori di varia natura (penuria di risorse naturali e di capitali, scarso spirito di intraprendenza, cattiva distribuzione della ricchezza, ecc.) o anche di fatti eccezionali (guerra, carestia, crisi economica, inflazione acuta, ecc.), che possono suscitare gravi situazioni di depressione economica e di disoccupazione, o accentuare squilibrî già esistenti. 2. Con altro senso, il termine designa talora l’ideale di povertà professato da alcune comunità cristiane, come gli Ordini mendicanti (con riferimento soprattutto al basso medioevo), e l’effettivo stato di povertà in cui esse, per libera scelta, vivevano.
FONTE: https://www.treccani.it/vocabolario/pauperismo/
Pauperismo
Il concetto di pauperismo fu coniato in Inghilterra attorno al 1800 per indicare la povertà quale fenomeno di massa risp. i poveri come categoria sociale. Determinante per la formazione di questo concetto fu l’avvento di una nuova forma di Povertà: era considerato pauper chi non riusciva, neppure con il proprio lavoro, a procurarsi un reddito sufficiente. Il termine inglese, ripreso dal lat., fu adottato anche dal franc. e dal ted., dove sostituì progressivamente l’espressione povertà di massa e venne talvolta utilizzato come sinonimo di proletariato. Solo dopo la metà del XIX sec., in area germanofona il termine proletariato fu usato esclusivamente per designare gli operai attivi nell’industria e nell’artigianato. In un quadro più ampio, il pauperismo e il relativo dibattito devono essere visti in relazione alla Questione sociale.
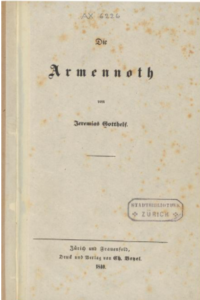
Per una più ampia discussione pubblica sul fenomeno del pauperismo in Svizzera – la povertà di massa esisteva invece già da tempo – furono decisivi sia i periodi di crisi verificatisi all’inizio del XIX sec. (ad esempio le guerre di coalizione del periodo napoleonico e la carestia del 1816-17), sia le conseguenze dell’intenso incremento demografico (dal secondo terzo del XVIII sec.) e della crescente industrializzazione. Occasioni di dibattito a livello nazionale venivano offerte dalle assemblee annuali della Società svizzera di utilità pubblica (SSUP) (fondata nel 1810), in cui si incontravano molti politici e intellettuali interessati alla soluzione della questione. Fino al 1860, in particolare dal 1835, il pauperismo fu un argomento ricorrente di discussione. A livello politico, la promulgazione di numerose nuove leggi sui poveri dimostra la volontà delle autorità cant. di risolvere il problema. Sul piano letterario, l’opera Die Armennoth (1840) di Jeremias Gotthelf costituì una testimonianza di grande incisività. Apparvero diversi contributi scientifici sul pauperismo, che possono essere ricondotti a due punti di vista principali. Vi era un approccio socioeconomico, parzialmente influenzato dalla teoria demografica di Thomas Robert Malthus (Maltusianesimo), secondo cui la povertà si perpetuava per via ereditaria. Tra i suoi sostenitori figuravano Johann Caspar Zellweger, Johann Konrad Zellweger e Heinrich Grunholzer. Altri esponenti di questa corrente – tra l’altro Paul Usteri, Jakob Christoph Bernoulli e Johann Rudolf Schneider – relativizzavano però l’aspetto demografico della povertà di massa. In un’angolazione etico-religiosa e soprattutto conservatrice il pauperismo veniva invece considerato sia un fenomeno di disgregazione dovuto allo stravolgimento dell’ordine divino a opera della Rivoluzione franc. e quindi una punizione per la distruzione della società per ceti tradizionale, sia una conseguenza del fallimento individuale (ad esempio l’Alcolismo). Questa opinione era difesa da Johann Ludwig Spyri, Jeremias Gotthelf, Karl Ludwig von Haller, Johann Rudolf Waser e Johann Peter Lange. Assai differenti erano pertanto anche le misure proposte per combattere il pauperismo: tra di esse figuravano la limitazione della crescita demografica, le innovazioni in campo agricolo al fine di aumentare la resa e migliorare così la situazione alimentare, una più equa distribuzione dei terreni agricoli, l’industrializzazione per creare possibilità di guadagno, l’emigrazione e la lotta all’alcolismo e alla mendicità.
Riferimenti bibliografici
Studi
Gruner, Arbeiter
Nuova storia della Svizzera e degli Svizzeri, 2, 1983, 209
M. Körner, «Die Schweiz 1650-1850», in Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 4, 1993, 589-618
Pfister, Bern, 341
Suggerimento di citazione
Jäggi, Stefan: “Pauperismo”, in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 24.11.2009(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016091/2009-11-24/, consultato il 28.09.2021.
FONTE: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016091/2009-11-24/
PANORAMA INTERNAZIONALE
Crisi energetica: aziende forzatamente in ferie in Cina
Settembre 24, 2021 posted by Leoniero Dertona
Almeno cinque province della Cina, Guangdong, Anhui, Jiangsu, Zhejiang e Shandong, stanno applicando misure per ridurre il consumo d’elettricità, giungendo ad ordinare di ridurre o sospendere completamente le produzioni industriali, il tutto fino al mese di ottobre.
Tra l’altro ci sono interruzioni programmate di elettricità settimanale nel Dongguan e Guangdon, e lo stesso, anche se in misura minore, accade anche nelle altre province. In questo caso le aziende cercano di far corrispondere i turni di lavoro con le chiusure o mettono i dipendenti in ferie.
Le aziende del settore del mobile a Houjie, Dongguan, hanno implementato pienamente le misure per limitare l’uso di elettricità a partire da questo mercoledì. Le interruzioni dell’energia sono molto pesanti: le industrie manifatturiere leggere subiscono possono subire l’interruzione dell’elettricità per cinque giorni, e l’erogazione solo per due, ma i settori altamente energivori dovranno chiudere tutta l prossima settimana, fino alle tradizionali ferie di ottobre, per risparmiare energia. L’energia viene tolta dai settori industriali e convogliata verso i servizi essenziali e domestici per non creare dei problemi insormontabili alle persone.
Perché avvengono questi lockdown così diffusi? China Business News riporta come gli imprenditori diano la responsabilità alle nuove normative di carattere ambientale che limitano l’uso del carbone nell’attività di generazione elettrica. In realtà il problema economico sembra essere più profondo: l’aumento del costo del carbone, legato alla carenza di produzione nazionale e al non utilizzo, per motivi politici, delle importazioni dall’Australia, ha portato il costo del kilowatt/ora a 0,60 centesimi di yuan, a fronte di un prezzo pagato dal pubblico di 0,40 centesimi. Una perdita per Kilowatt che non tollerabile, se non in modo episodico, anche perchè il carbone / petrolio e Gas Naturale devono essere comprati sul mercato internazionale a prezzi sempre più crescenti.
Le conseguenze per noi sono chiare: l’interruzione delle produzioni industriali in Cina avrà come conseguenza ulteriori rotture di stock nelle forniture internazionali, con un incremento dei già presenti shock sul lato dell’offerta e quindi altri episodi di carattere stagflazionistico.
China Business News ha riferito che il motivo della carenza di alimentazione nel Guangdong, secondo persone che hanno familiarità con la rete elettrica del Guangdong, è che la carenza di energia è la chiave. “Finora la centrale termica non ha funzionato a pieno regime. Una delle unità è fuori servizio e l’altra ha solo la metà della normale fornitura di energia”. “Il prezzo dell’elettricità per kilowattora di energia termica è superiore a 40 centesimi di RMB, ma il costo della produzione di energia ha raggiunto quasi 60 centesimi di RMB. Ciò significa che per ogni chilowattora di elettricità si perde più di un centesimo di RMB. .”
FONTE: https://scenarieconomici.it/crisi-energetica-aziende-forzatamente-in-ferie-in-cina/
Pezzentismo imperiale
1. Nel sistema capitalistico celebrato dai mass media e dai social media di proprietà dei Jeff Bezos e degli Elon Musk, si accusa la Russia di seguire le regole del mercato.
2. Nel sistema belluino delle “regole” occidentale, dove la NATO e i suoi regimi fantoccio fascisti dell’Europa orientale (gli Staterelli neonazisti baltici, Polonia, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Montenegro, Macedonia, Finlandia, Svezia, Ucraina, Georgia) minacciano militarmente e politicamente la Federazione Russa; a Mosca viene rimproverato il diritto di rispondere con tutti i mezzi alle minacce e provocazioni istigate da Bruxelles, Londra e Washington, che non sono solo rivolte contro Mosca, ma contro tutti i suoi alleati: dalla Bielorussia alla Siria, dall’Iran alla Corea democratica, dal Venezuela all’Algeria. Ecc. ecc. La Federazione Russa ha il diritto di rispondere alle minacce degli occidentali e dei loro scagnozzi su tutti i piani: geoeconomico, geopolitico, geostragico. Chi ne è contrariato, continui pure a guardarsi la merda hollywoodiana degli 007 e dei rambo, fantasmi spazzati via dalla realtà.
Tale realtà può essere occultata e imbellettata dai ridicoli e grotteschi media di regime e dagli ipocriti e miserabili social media amazoniani (aziendali), ma non è ignorata da chi, in ogni momento, affronta sul serio tali due bestie pachidermiche e legnate: UE e USA, come fa il Fronte multipolare globale o le insurrezioni popolari nel quarto mondo; non di certo i “comunistielli gretini” occidentali che vegetano entro il ventre mediatico della bestia.
POLITICA
Economia ecologica: signoraggio, debito pubblico, tasse…
Riconoscersi in ciò che è
… ma non conviene vendersi per un piatto di lenticchie (in prestito). Stavolta mi tocca toccare un tema scabroso. No, non si tratta della nuova professione riservata alle donne in Cina, quella di “pugnettista”, che comunque è un simbolo di come l’asservimento della specie umana sia giunto a livelli bassissimi.
Economia ecologica: signoraggio, debito pubblico, tasse… ma non conviene vendersi per un piatto di lenticchie (in prestito)
Qui in questo blog riservato a temi “ecologici” e “spirituali” debbo oggi occuparmi di denaro, economia e finanza. Il fatto è che se non viene risolto il problema economico in modo ecologico ed “etico” la società non potrà progredire e resterà preda di tormenti consumistici e schiavitù lavorative.
Il denaro che è nato come mezzo di facilitazione per lo scambio di beni necessari, ed in se stesso all’inizio aveva un valore universalmente riconosciuto (la prima moneta furono gli spiedi che avevano un uso reale), è diventato pian piano un mezzo speculativo di asservimento e di sperequazione sociale. Sia ben chiaro non è colpa del denaro in quanto tale se ciò è avvenuto ma la “colpa” sta nel modo in cui è stato utilizzato (e qui intendo proprio nel senso “utilitaristico” speculativo). Non voglio però fare una cronistoria del percorso. Fermiamoci al momento presente e cerchiamo di capire chi oggi detiene il potere di emettere denaro ed a quale prezzo per la comunità umana.
Un piccolo incipit – Scriveva Stefano Trentin: “Vi siete mai chiesti dove finiscano i miliardi di miliardi di imposte e balzelli che continuiamo a versare allo Stato criminale e predatore? Lo stato Italiano per avere denaro deve cedere alle banche private titoli di stato e pagare gli interessi del 4%. Le banche private ricevono dalla BC€, istituto privato di emissione, il denaro al tasso dello O,5%. Bankesters-usurai legalizzati ! Ecco la causa e l’effetto dei famosi 2100 miliardi del debito pubblico, in vertiginosa crescita!”.
Negli anni passati ed anche ai giorni nostri alcuni “mattacchioni” consapevoli della realtà delle cose relative allo strozzinaggio della moneta debito (dicasi signoraggio bancario) hanno denunciato alla magistratura questi fatti ma nessuno ha mai indagato un banchiere, al contrario fu incriminato Giacinto Auriti che aveva denunciato i governatori di BankItalia e di BCE.
Gandhi disse che “il modo migliore per sovvertire un potere vessatorio e dittatoriale è quello di non pagare le tasse”, sembrerebbe facile, ma finché la maggioranza della gente è consapevolmente o inconsapevolmente connivente con il sistema vessatorio, la rivolta fiscale non è pensabile (pena persecuzioni, multe, pignoramenti, galera, etc.).
Ma lasciamo per ora da parte il come liberarsi economicamente dal cappio usuraio e vediamo come funziona, nei particolari, il meccanismo della emissione monetaria e dell’indebitamento pubblico. E non dimentichiamo l’origine del problema.. ovvero la rinuncia da parte dello Stato al suo diritto sovrano di emettere cartamoneta…
Sì avete capito bene, non è lo Stato Italiano e nemmeno la Comunità Europea a creare il denaro che circola, lo creano dal nulla la Banca d’Italia (prima) e la BCE (oggi). Queste banche sono enti privati (e non pubblici come erroneamente si crede). La cartamoneta viene fatta stampare, senza alcun controvalore (ex nihilo) da codeste banche centrali e viene concessa in “prestito” e lo Stato ripaga il denaro così ottenuto con “obbligazioni” e “titoli” che poi vengono venduti dalle banche stesse che ne ricavano ulteriori interessi. La moneta circolante è in tal modo un “debito” che lo Stato – e di conseguenza tutti i cittadini – debbono pagare. Infatti l’emissione del denaro da parte della Banca Centrale, avviene solo in contropartita a Obbligazioni emesse dallo Stato al corrispettivo valore. E questa è la vera fonte del debito pubblico (a causa dei tassi di interesse, spread, etc.).
Ovviamente il problema non è solo europeo, anzi, diciamo che ha salde radici in USA. Infatti anche la Federal Reserve che sommerge di dollari il mondo è una banca privata ed è per questa ragione che, anche gli USA, sono sommersi dal debito pubblico. Tre anni dopo aver approvato il Federal Reserve Act del 23 dicembre del 1913, il presidente Woodrow Wilson affermò: «Sono l’uomo più infelice. Ho inconsapevolmente rovinato il mio Paese. Una grande nazione industriale è controllata dal suo sistema di credito. Ora il nostro sistema di credito è concentrato. Perciò, la crescita della nazione e tutte le nostre attività è nelle mani di pochi uomini. Stiamo per diventare un Paese mal governato, completamente controllato e dominato del mondo civilizzato. Non più un governo in cui c’è libertà di opinione, non più un governo guidato dalla convinzione e dal voto della maggioranza, ma un governo pilotato dall’opinione e dalla prigionia voluta da un piccolo gruppo dominante di uomini». Inoltre – truffa nella truffa – questi pezzi di carta colorata che le banche centrali private fanno stampare sono assolutamente privi di ogni copertura… non c’è alcun deposito aureo, beni, od altro di concreto che li sostenga.. l’unico valore è quello convenzionale per l’accettazione di chi usa la moneta.
In verità il denaro che abbiamo in tasca ha valore solo perché noi gli diamo quel valore, non essendo garantito da alcun controvalore in sé non vale nulla nemmeno il costo dei colori e della carta (praticamente inservibile per qualsiasi uso concreto). Eppure con questa colossale truffa effettuata dai banchieri il mondo sta passivamente diventando preda dei poteri economici “occulti” (nel senso che il popolo non conosce il meccanismo diabolico) che regolano ogni movimento finanziario e monetario.
Ohi, ohi, insomma le tasse che noi paghiamo sarebbero il pizzo che lo Stato deve versare come contropartita del signoraggio bancario e anatocismo consentito ai banchieri privati della BCE, per onorare i trattati. Ed i politici (tutti i politici) sono solo i sicari, conniventi o ricattati, dei banchieri finanzieri internazionali padroni di Banche, di Multinazionali e dei MEDIA, e manipolatori delle masse. Insomma bisogna andare sulla “CIMA della PIRAMIDE” con l’occhio del Big Brother, per trovare i veri artefici dei danni all’Umanità. E l’asservimento politico lo vediamo bene in Italia. Come dice Michele Meomartino: “La politica che un tempo poteva avere margini di indipendenza rispetto agli altri poteri, oggi è completamente funzionale e condizionata da questi poteri. Negli ultimi 20 anni, l’Italia ha avuto come presidente del Consiglio, prima Ciampi (eletto successivamente addirittura presidente della Repubblica) e poi Dini. Fino ad alcuni mesi fa, c’era Mario Monti che rappresenta gli interessi di alcuni agenzie finanziarie. Per tacere di Prodi…”.
Ma infine perché lo Stato non ripudia la “moneta-debito” ed emette il denaro in forma diretta, tramite il Ministero del Tesoro? Beh, c’è da dire che questo gioco sarebbe molto rischioso, a causa degli enormi interessi che stanno dietro alla mega-truffa bancaria… Infatti – ad esempio – si sospetta che Aldo Moro fu eliminato proprio perché stava avviando un processo di affrancamento dal signoraggio bancario (le famose cinquecento lire emesse direttamente dal ministero del tesoro) ed in America il presidente Kennedy fu verosimilmente eliminato per la stessa ragione, cioè aveva dato ordine al Tesoro di iniziare un processo di emissione monetaria in proprio, garantita dall’argento posseduto dallo Stato.
Perciò non bisogna credere a chi semplicemente propone l’uscita dalla UE o l’azzeramento del debito pubblico lasciando però invariato il meccanismo della “produzione” del denaro. Occorre che lo Stato o l’unione degli Stati (come nel caso dell’Europa) assuma la sua sovranità monetaria rispetto alle banche centrali.
Secondo l’economista Savino Frigiola: “La ricetta per schivare le manovre di strangolamento sono abbastanza semplici, facili da praticare, collaudate e sicure. Poiché la maggior parte del debito pubblico viene creato dall’emissione monetaria abilmente carpita dai banchieri privati, BCE o Federal Riserve che sia, è sufficiente che lo Stato invece di emettere propri titoli di debito per poi scontarli o venderli al sistema bancario, alle condizioni imposte volta per volta dal creditore, emetta direttamente i propri titoli monetari con i quali monetizzare il proprio mercato mediante il pagamento di opere o attività di pubblico interesse e così non si creano debiti”.
Semplice no?
Ma state “tranquilli” non vi saranno “forze” politiche coraggiose abbastanza da sfidare il golem finanziario e bancario mondiale ormai consolidato. Prova ne siano anche le norme che dal 2014 entrano in vigore con il Patto di Stabilità – come scrive Loretta Napoleoni – tra queste c’è l’impegno del nostro paese a ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil al 60 per cento attraverso una maxi manovra finanziaria all’anno per i prossimi 20 anni, la prima avverrà quest’anno. Dato che al momento questo rapporto supera il 132 per cento (equivalente a 2080 miliardi di euro circa) bisogna ridurlo di almeno 900 miliardi di euro, il che equivale a circa 45 miliardi l’anno per due decadi, in forma di diminuzione dei servizi, aumento di tasse e svendita di beni comuni. Tutto per soddisfare la cima della piramide del NWO.
Cosa possiamo fare dunque nel “piccolo”? Nel privato per sfuggire minimamente alla catena e magari lanciare un messaggio di cambiamento? La mia soluzione è semplice: diventare vegetariani, ridurre od eliminare i consumi di prodotti industriali, ritirare i fondi dalle banche e operare economicamente in modi ed ambiti ecosolidali. Forse dovremmo anche ripensare il nostro stato sociale, restringere la delega allo Stato e cominciare ad attuare forme di autorganizzazione modello banca del tempo. Perché semplificando i bisogni, cercando l’essenziale e scartando il superfluo, avremo sempre meno bisogno di soldi e di tempo per soddisfarli… insomma sopravvivere in silenzio. Come dice I Ching: in tempi bui il nobile si ritira nella sua virtù, non accetta cariche pubbliche né emolumenti in modo da non confondersi con il malgoverno.
FONTE: https://www.terranuova.it/Blog/Riconoscersi-in-cio-che-e/Economia-ecologica-signoraggio-debito-pubblico-tasse
SCIENZE TECNOLOGIE
Pauperismo o populismo digitale?
“Quello che è scritto in maniera approssimativa è mal pensato” scriveva Adorno cinquant’anni fa. Oggi appiccicare l’aggettivo “digitale” a un qualsiasi sostantivo astratto segue le logiche di una cultura di persuasione che trova la sua forma linguistica nella pubblicità e il suo luogo di comunicazione nei talk show. Il libro “Populismo digitale” di Alessandro Dal Lago (Raffaello Cortina Editore, Roma 2017, € 14,00) in questo senso non è un’eccezione.
Si parla di “soggetti digitali” (p. 63), di “carisma digitale” (p. 21), “pubblico digitale” (p. 18) e “opinione digitale” (p. 12) senza mai darne una definizione sufficiente, confidando nella pura forza di evocazione retorica. Ecco cosa possiamo aspettarci da un libro che stilisticamente assomiglia più a un blog e i suoi commenti che a un saggio o un libro con pretese scientifiche: “Ed ecco svelato l’arcano del populismo…” (p. 55), “Insomma, il M5S è un partito come gli altri – forse peggiore…” (p. 132), “Ecco un esempio clamoroso” (p. 132), “…trascinerebbe nella polvere l’immagine complessiva…” (p. 133) e “In altre parole, non c’è molto da ridere.” (p. 143).
Però andiamo con ordine. Il libro si articola in una breve introduzione, quattro capitoli e una brevissima conclusione. L’introduzione espone la tesi secondo la quale oggi esiste una “prevalenza della politica virtuale su quella reale” (p. 12), il concetto di un “double bind politico-comunicativo” (p. 19), fra l’altro mai veramente dimostrato, e l’ipotesi che “la incapacità delle sinistre tradizionali” spieghi “ampiamente la deriva di destra del populismo” con la conclusione “Quello di cui possiamo essere sicuri è che il mondo è entrato in una situazione di anarchia senza precedenti” (p. 24).
Il primo capitolo “Gli equivoci del populismo” comincia con l’affermazione “Oggi, il popolo in senso stretto non esiste”, per poi fare una carrellata di diverse teorie del populismo cominciando da alcuni approcci al termine “popolo”, ma senza mai sviluppare un concetto proprio di “populismo”. Seguendo parzialmente Ernesto Laclau il capitolo conclude con due affermazioni frettolose: “In poche parole, l’ambiente del populismo contemporaneo non è altro che la realtà e al tempo stesso evanescente di Internet”. (p. 53) e “Ecco svelato l’arcano del populismo. Il significato vuoto del reale della politica, l’impossibile verità del popolo di cui parla Laclau, non è altro che l’insieme delle identità virtuali della rete. Il popolo, che nella realtà materiale non esiste, se non nelle convenzioni o delle finzioni della democrazia rappresentativa, si è ora ricostituito (corsivo dall’autore su ricostruito, ndr) in rete” (p. 55).
Il secondo capitolo “La realtà come costruzione virale” è sostanzialmente un insieme di esempi di fake news, distorsioni di notizie e casi di commenti di utenti per dimostrare come “lo stile tangenziale, identitario e oppositivo delle discussioni online degeneri facilmente in scambio di insulti” (p. 82). Purtroppo Dal Lago non spiega cosa sia lo stile tangenziale ma conclude con il solito “insomma” che sostituisce una argomentazione coerente: “Insomma, la verità in rete è diventata una mera funzione di chi la pronuncia” (p. 65).
Nel terzo capitolo, il più breve del libro, con il titolo “Populismi digitali e para-fascismi”, Dal Lago cerca attraverso delle analogie tra peronismo, Trump, Le Pen, Orban e il Movimento 5 Stelle di distillare un concetto di para-fascismo senza mai spiegare cosa rende i politici e i movimenti di cui sopra simili al fascismo storico, soprattutto per quel che riguarda la violenza e la glorificazione della guerra. Forse Dal Lago teme che questo sia il prossimo passo: “Visti gli slogan delle loro campagne elettorali, c’è da aspettarsi di tutto” (p. 115).
Il quarto capitolo “Il fascismo travestito da democrazia diretta” è sostanzialmente un attacco al Movimento 5 Stelle e un tentativo di dimostrare che questo sta diventando un movimento di “estrema destra” (p.134). Il capitolo contiene lunghe citazioni di Beppe Grillo ed altri esponenti, qualche “rivelazione” sui meccanismi interni del movimento e finisce – riferita al M5S – con una perequazione di populismo e para-fascismo.
Complessivamente lo scopo del libro rimane oscuro. Non contiene nessun accenno a ricerche empiriche e il quadro concettuale rimane costantemente fluido, tralasciando le teorie sociologiche attuali più importanti, come la teoria dei sistemi, network theory et al.
Alla fine colpisce l’approssimazione linguistica, la similitudine tra lo stile dell’autore del libro e quel populismo digitale che cerca di descrivere. Dalle fake news alla fake theory?
Tra apnea empirica ed asfissia concettuale forse appare il vero motivo del libro: “La questione seria è che l’ascesa di Grillo ha coinciso con la sparizione di qualsiasi opzione di sinistra dalla scena politica italiana” (p. 158). Quindi anche il target sono solo loro? “Parlo soprattutto di ciò che resta in Italia di quella realtà nebulosa e gassosa che va sotto il nome di sinistra” (p. 156). Forse la terza parola di questa frase doveva essere non un “di” ma un “a”.
FONTE: https://www.techeconomy2030.it/2018/04/05/pauperismo-populismo-digitale/
STORIA
Pauperismo attraverso i secoli
pauperismo
Termine coniato dalla storiografia contemporanea per indicare un fenomeno caratteristico della società europea tra basso Medioevo (XII-XIII secolo) e rivoluzione industriale (XVIII-XIX secolo), quando parte della popolazione urbana e rurale viveva in condizioni più o meno gravi di indigenza. Nei secoli VII-XI lo scarso sviluppo demografico e il basso tenore di vita generalmente diffuso non diede luogo alla formazione di uno stato di vera indigenza: al pauper (povero) in questo periodo non si contrapponeva il dives (ricco), ma il potens (potente), per cui la subordinazione di alcune classi rispetto ad altre non era basata sul reddito bensì sul potere politico. In seguito, tra XII e XVIII secolo, il termine fu utilizzato per indicare quell’ampia fascia della popolazione che per vivere era costretta a lavorare. Si possono qui riconoscere tre tipologie diverse: i poveri che vivevano di elemosine; i poveri che lavoravano saltuariamente, o che facevano parte di una famiglia dove solo alcuni avevano un lavoro, e che quindi arrotondavano le entrate con l’accattonaggio; i poveri che avendo rendite molto basse precipitavano nell’indigenza con l’avvicendarsi di ogni congiuntura sfavorevole. Data l’estensione cronologica del fenomeno il significato del termine povero subì un lento ma costante mutamento. Nel basso Medioevo troviamo una concezione quasi sacrale della povertà, intesa sia in senso negativo come flagello (immagine della condizione dell’uomo dopo il peccato originale) sia in senso positivo come motivo e stimolo all’espiazione poiché mediante l’elemosina verso il povero il ricco si assicurava la salvezza eterna. Nel XV secolo a questa concezione se ne sovrappose una laica, per cui il povero veniva a essere considerato con maggiore sospetto come ozioso, scroccone e vagabondo. Tale posizione si radicalizzò con il calvinismo, che trasformò la divisione ricchi/poveri in eletti/dannati. In età moderna i sovrani tentarono di operare distinzioni tra i veri poveri, quelli “di Cristo”, e i falsi poveri: i primi dovevano essere assistiti, i secondi trattati come criminali. Per tutto il Medioevo ogni forma assistenziale fu lasciata nelle mani dei religiosi, che crearono ospedali e ospizi e affrontarono i problemi contingenti senza però mai intervenire sulle cause; solo nel Settecento, con la concentrazionedi queste iniziative nelle mani dello stato, iniziò un lento processo di ricerca di individuazione delle cause sociali ed economiche del pauperismo.
P. Benigni
PAUPERISMO MEDIEVALE
Dottrina secondo la quale il vero cristiano non deve possedere niente. Ebbe un ruolo determinante nel definire diversi movimenti religiosi, ereticali e non, del XII-XIII secolo. Dopo aver avuto una qualche parte nelle lotte (pataria) contro la Chiesa simoniaca, il pauperismo fu al centro del movimento dei Poveri di Lione e divenne poi una crescente forza di protesta nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche. L’autorizzazione papale dell’ordine dei frati minori di san Francesco (1223) e il suo successivo grande successo incanalarono le istanze pauperistiche in una istituzione più facilmente controllabile ed evitarono che esse si trasformassero in una potente forza di contestazione ereticale. Ma le polemiche sulla povertà ricomparvero presto all’interno dello stesso ordine francescano, che si divise in due gruppi pronti ad accusarsi reciprocamente di eresia. Sette di frati irregolari che praticavano e predicavano il pauperismo accentuandone i toni rivoluzionari e millenaristici cominciarono a comparire in molte città italiane verso la fine del XIII secolo, venendo condannate come eretiche e duramente combattute dalle autorità ecclesiastiche, come accadde agli apostoli di Parma e ai seguaci di fra Dolcino (1306-1307). Benché il papa Niccolò III avesse dichiarato nel 1279 che i francescani erano autorizzati a usare in modo povero beni che andavano considerati proprietà della Chiesa, gli spirituali accrebbero la loro polemica, producendo con i fraticelli un’ala ancor più estremista. Il concilio di Vienne (1311-1312) cercò di mediare il contrasto, ma nel 1317 il papa Giovanni XXI condannò come eretica la stessa tesi centrale del pauperismo, cioè che Gesù e gli apostoli non avevano mai posseduto niente. Le fiamme dei roghi posero fine al movimento dei fraticelli e al più moderato pauperismo delle beghine e dei begardi.
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/p/p028.htm
Umiliati
Sorti in Lombardia nel solco del vasto movimento religioso originato dalla Pataria alla fine del XII sec., assimilati agli eretici (1184), gli umiliati ottennero nel 1201 l’approvazione di Innocenzo III. L’ordine aveva trina membra, includendo chierici e monache consacrate (primo ordine, regola di tipo agostiniano), laici e laiche con status di religiosi (secondo ordine, regola di tipo benedettino) e laici che permanevano nello stato coniugale (terzo ordine). La loro diffusione si concentrò spec. nell’Italia settentrionale, con piccole case spesso doppie (maschili e femminili) dedite alla predicazione, alla penitenza e al lavoro (coltivazione della terra, lavorazione e commercio della lana); i frati ebbero anche compiti relativi alla gestione delle finanze dei com. e alla conduzione di ospedali. Già nel XIII sec. riforme papali portarono gli umiliati a evolvere verso la forma degli ordini tradizionali, attraverso l’unificazione delle regole del primo e secondo ordine (clericalizzazione), l’introduzione del maestro generale, l’accentuazione della vita conventuale e la cessazione della predicazione e della lavorazione della lana. Il declino dell’ordine, dovuto a ragioni politiche, spirituali ed ecclesiastiche, iniziò nel XV sec. Dopo vani tentativi di riforma, l’ultimo di S. Carlo Borromeo (1560, protettore), il ramo maschile viene soppresso nel 1571; quello femminile venne orientato alla regola benedettina.
Gli umiliati, la più praticata forma di vita consacrata dell’epoca medievale nel Ticino, si diffusero capillarmente dal XIII sec. in diverse località dell’attuale cant. Finora è stato possibile attribuire loro con certezza le case di S. Pancrazio, sull’Isola Grande di Brissago (1214-XIV sec., fusa con Gordola), di S. Caterina a Gordola (fine XIII sec.-prima del 1550, fusa con Locarno), di S. Caterina a Locarno (prima del 1291-1570/71, soppressa) per il Locarnese; a Lugano, di S. Maria (ospedale, XIII-XV sec., passato alla gestione com.), di S. Caterina (prima del 1250-1848, soppressa), di S. Antonio (prima del 1295-1570/71, soppressa); ad Astano, di S. Antonio (menz. per la prima volta nel 1272, fusa con S. Caterina di Lugano nel XIV sec., estinta); nel Mendrisiotto, di Riva San Vitale e Castel San Pietro (XIII sec., estinte); a Mendrisio, di S. Giovanni (ospedale, prima del 1287-XV sec., cessione ai serviti) e di S. Orsola (prima del 1268-1555, forse fusa con S. Orsola di Como). È nota l’esistenza di altre comunità, ma lo stato attuale della ricerca non permette di affiliarle all’ordine degli umiliati, così come quelle degli ospizi delle valli ambrosiane.
Bibliografia
–HS, IX/1
-M. P. Alberzoni et al. (a cura di), Sulle tracce degli Umiliati , 1997
-A. Ambrosioni, «Umilati», in Diz. degli Istituti di perfezione, 1997
-A. Gerhards, Dictionnaire historique des ordres religieux, 1998, 314 sg.
Autrice/Autore: Antonietta Moretti
FONTE: https://anamcara.freeforumzone.com/mobile/d/8717845/Pauperismo-attraverso-i-secoli/discussione.aspx
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 11 Giugno 2013
11 Giugno 2013



