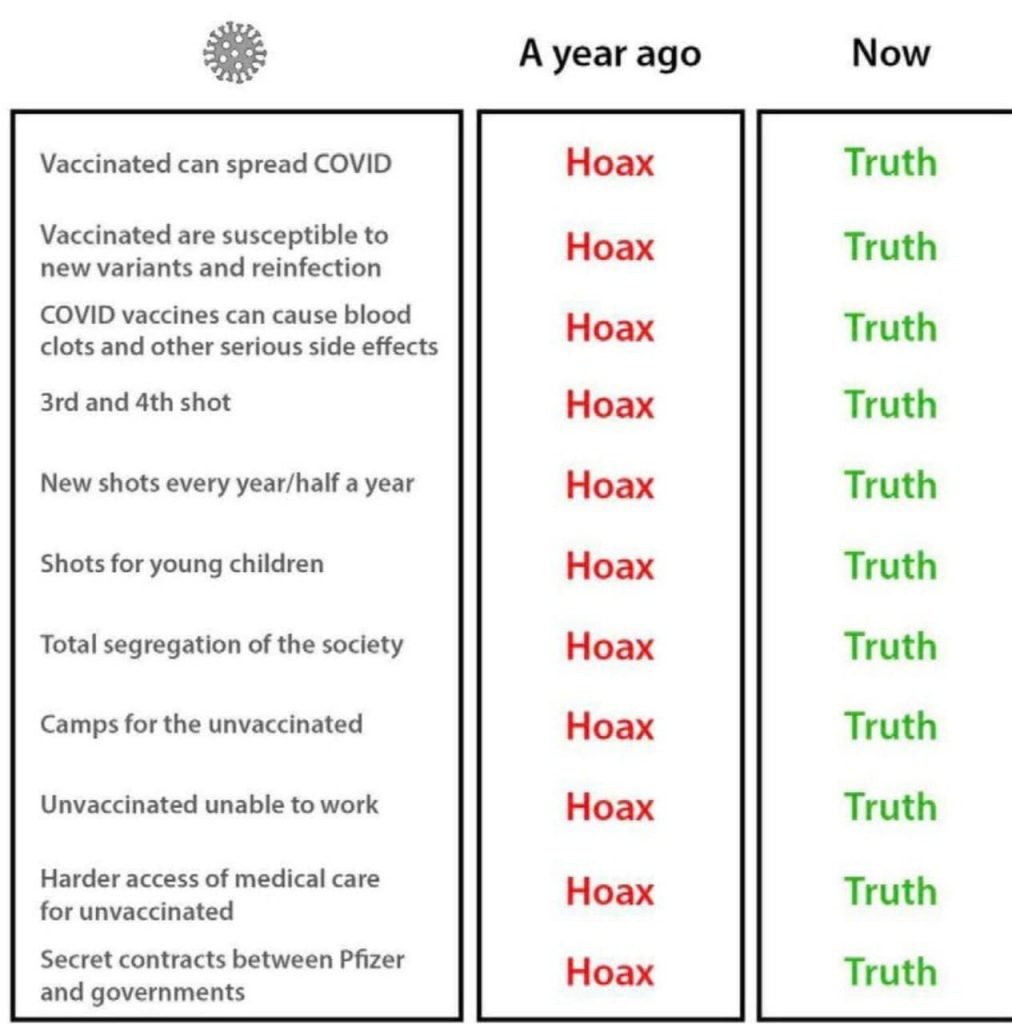RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI
12 GENNAIO 2022
A cura di Manlio Lo Presti
Esergo
Una vita strettamente individuale è necessariamente un fallimento.
ANDREA EMO, Aforismi per vivere, Mimesis, 2007, pag. 82
https://www.facebook.com/dettiescritti
https://www.instagram.com/dettiescritti/
Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.
I numeri degli anni precedenti della Rassegna sono disponibili sul sito www.dettiescritti.com
Precisazioni legali
www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com
Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.
Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com
La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SOMMARIO
MATTEOTTI, REGENI, ATTANASIO … IL PRESIDENTE UE?
Venti anni di Guantanamo: l’abisso creato dagli Stati Uniti
Green pass nucleare: esce a maggio la Bomba per l’Italia
POLLI, GALLI E PENNIVENDOLI ASSORTITI
Guarda in alto, non solo la cometa
Vergognoso silenzio della sinistra sui molestatori stranieri di Capodanno
Draghi: le nostre scelte sono basate sui DATI
La Corte dei Conti blocca il “regalo” dello Stato ai Benetton: cosa è successo
CASO “RACKETE”, TRA CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE CHE NON ESISTONO E LEGGI E CHE ESISTONO E NON SONO APPLICATE
Perché la Somalia rischia di diventare l’Afghanistan d’Africa
In Kazakistan Washington porta avanti il piano della RAND, poi toccherà alla Transnistria
La task force Takuba tra forze speciali italiane e i russi della Wagner
Negatività, totalità e nuove forme della critica
Ancora un cavo sottomarino tagliato al largo della Norvegia
SORVEGLIANZA GENERALE!
I cento euro di multa? Non sottovalutateli. Sono una porta spalancata sull’abisso
“Le banche prestano soldi solo a chi non ne ha bisogno”. Vero, ma non per i motivi che pensate
VENTESIMO ANNIVERSARIO DEGLI ATTENTATI DELL’11 SETTEMBRE
Uno Stato democratico? intervista a Michel Warshawski
Gli Stati Uniti e la ribellione delle élite
LA DEMAGOGICA ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO DIRETTO AI PARTITI
DA ISTITUTO LIBERALE
PROMEMORIA per la sinistra italiana ed europea complice del terrorismo genocida islamico.
Chi finanzia l’Oms? Cos’è e come funziona l’agenzia dell’Onu
QUI L’AFFARE S’INGROSSA, ARRIVA FRANCO FRATTINI
EDITORIALE
MATTEOTTI, REGENI, ATTANASIO … IL PRESIDENTE UE?
Il continuo azzoppamento della ex-italia

Secret Intelligence Service building – Vauxhall Cross – Vauxhall – London – 24042004
Al di fuori delle manifestazioni di circostanza e di imminente beatificazione non troppo postuma, c’è da interrogarsi, sospettosamente, se la connotazione troppo improvvisa della morte, dopo una brevissima (troppo) convalescenza, dell’ex giornalista rientra nel piano di progressiva esclusione del nostro Paese dai piani alti dell’unione, da tutte le aree africane ed internazionali? Rilevo una imbarazzante sincronicità del decesso del giornalista-presidente con la vicinissima scadenza del suo mandato comunitario. L’uscita repentina di scena del buon presidente Ue non poteva avere tempismo migliore, oltre al fatto che rende impossibile una sua eventuale rielezione dando la certezza assiomatica di far posto ad “altri”. Forse, a breve sarà il turno dell’altro italiano con due cognomi, attualmente commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione Von der Leyen, detto dai suoi detrattori “Er moviola”? …Sarebbe un altro posto reso vacante… sempre per i soliti “altri”? Non si butta niente!
Mentre i vari Paesi d’Europa stanno dismettendo il casermaggio tecno-farmaceutico, la penisola inasprisce i controlli e le vessazioni, con la sua economia che va verso il collasso e la paralisi. Perché? Perché gli stati europei possano comprarsi il resto delle aziende che Monti non aveva fatto in tempo a dismettere a prezzi stracciati??? Ecco quindi chiarito il compito dell’attuale presidente del consiglio! A cosa servirebbe uno Stato economicamente, socialmente, finanziariamente, produttivamente raso al suolo dove, ricordiamo, è stata firmata a Roma la Carta fondativa della Comunità europea il 18 aprile del 1950? Forse, dopo la reductio ad desertum dell’Italia l’utilizzo del suo territorio è quello preconizzato dalla parlamentare Emma Bonino stabilendo per tale piano cifre iperboliche, da evento biblico?
Ricordo il caso Attanasio in Africa di cui ancora non sappiamo nulla che fa il paio con il caso Regeni il quale, con forte probabilità, non è stato ucciso dagli egiziani ma dai pretoriani di Cambridge Analytica allo scopo di demolire i rapporti commerciali e petroliferi italo-egiziani in cui sono subentrati gli stessi inglesi e i francesi. Per non far vedere che i soliti inglesi hanno agito sotto il loro naso, gli egiziani si sono accollati il caso. La sceneggiata non sembra un seguito cinematografico dell’assassinio di Matteotti, fatto fuori dagli inglesi perché l’indomani non rivelasse in parlamento il retroscena di immense tangenti intascate dai Savoia per interessi petroliferi?
Riflettiamo. È l’azzoppamento eterno dell’Italia, bellezza!
FONTE: https://www.opinione.it/politica/2022/01/12/manlio-lo-presti_commissione-von-der-leyen-ue-italia-egitto-francia-inghilterra-regeni-attanasio-africa/
IN EVIDENZA
Venti anni di Guantanamo: l’abisso creato dagli Stati Uniti
Torture, abusi, tute arancioni, filo spinato una guerra al terrorismo realizzata senza alcun rispetto del diritto dei detenuti. Per il mondo, Guantanamo è semplicemente questo: un campo di prigionia tra i peggiori al mondo. Un luogo di detenzione che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e prima di lui Barack Obama, avevano promesso di chiudere. E che invece è rimasto. Quasi un monito: un continuum nel tempo. Guantanamo resiste, e con essa la contraddizioni e le storture del sistema americano che per anni ha trattato quei detenuti speciali come prigionieri di guerra, la “guerra al terrorismo” per l’appunto, senza alcun rispetto dei diritti.
Una macchia per una potenza che fa della sua essenza democratica e del rispetto dei diritti universalmente riconosciuti come emblema della sua leadership mondiale. Ed è anche in questa incoerenza di fondo che si cela un simbolo, pur drammatico, come appunto è stato e continua a essere il campo di Guantanamo. Un incrocio in cui si intersecano tutte le contraddizioni dell’America e che rendono quella baia, e la base al suo interno, uno dei grandi nodi di Washington agli occhi dell’opinione pubblica mondiale.
Guantanamo: simbolo di una storia
Per molti storici è proprio lì, nell’attuale base navale sull’isola di Cuba, che inizia quello che è chiamato l’imperialismo americano, cioè quella fase di interventismo e di espansione territoriale e di influenza che ha caratterizzato gli Stati Uniti dalla fine del XIXI a tutto il Ventesimo secolo. Per molti la sua importanza è soprattutto legata al periodo più recente e alle perplessità di come sia possibile che una potenza che si proclama baluardo dei diritti umani possa ammettere un luogo in cui il diritto non esiste. Dove tutto è lasciato a un senso di impunità, di ingiustizia e di senso di oppressione.
Ma forse è proprio questo a rendere Guantanamo qualcosa di più di un base o di un campo di prigionia. E la sua storia, come la sua triste fama, accompagna in un percorso parallelo e oscuro anche le scelte politiche della potenza democratica per eccellenza: gli Stati Uniti.
Guantanamo, infatti, per certi versi nasce insieme allo scoperta degli Usa come potenza continentale. Una base concessa dal governo di Cuba a Washington dopo quella guerra ispano-americana che condannò la Spagna al declino definitivo dei suoi possedimenti coloniali e che fece sorgere una nuova potenza – indiscussa e indiscutibile – all’interno del mondo americano. Talmente indiscutibile che l’America, un tempo intesa come continente, divenne sinonimo di un solo Paese, gli Stati Uniti appunto.
A Cuba e nel mondo è accaduto di tutto da quel lontano 1903, anno in cui il presidente cubano Tomás Estrada Palma ringraziò gli Stati Uniti concedendo in affitto perpetuo quel lembo di terra della sua patria. L’Avana, da capitale di una sorta di protettorato Usa, si è trasformata nella centrale del socialismo sudamericano in lotta contro l’”imperialismo” americano. C’è stata la crisi dei missili, è caduto il Muro di Berlino, l’Unione Sovietica si è dissolta e anche Cuba ha perduto Fidel Castro e quell’ortodossia che per decenni l’ha contraddistinta. Eppure la base è rimasta: anche a costo “zero” per Washington. Nessuno ha osato davvero toccarla, per evitare una guerra, certo, ma anche con la sensazione che Guantanamo per certi versi era e resta un avamposto di un mondo che non è solo una base navale, ma la fotografia di un sistema politico e di rapporti di forza.
Il campo di prigionia della “guerra al terrore”
La fama di Guantanamo si deve oggi soprattutto alla scelta dell’amministrazione di George W. Bush di utilizzare la base come un campo di prigionia per le persone arrestate dopo l’11 Settembre 2001. Era l’inizio della guerra al terrore. Il Terrore, quello con la T maiuscola, che aveva colpito al cuore gli Stati Uniti e per cui per la prima volta si scatenò un conflitto che non aveva solo l’idea della vendetta, ma anche dell’inizio di una campagna universale contro un nemico invisibile. L’avversario anonimo, quello della porta accanto, quello di cui nessuno più poteva fidarsi. Un nemico nuovo e senza uno Stato che si potesse combattere. Il suo centro era una organizzazione votata al terrorismo di matrice islamista. E per contrastare questo avversario, il governo aveva bisogno di un luogo in cui il prigioniero andava condotto per confessare e espiare la sua pena: con un metodo e in luogo che non doveva essere solo un monito per gli altri adepto ad Al Qaeda e alle organizzazioni del terrore, ma anche come come garanzia verso l’opinione pubblica dell’azione delle forze Usa.
Dal 2002, esattamente venti anni fa, inizia così la nuova terribile vita di Guantanamo. Non più solo una base navale statunitense a Cuba, ma una prigione per i detenuti più pericolosi – o presunti tale – di questa guerra contro il terrorismo islamico. All’inizio tutto ruotava intorno a “Camp X-Ray”, chiuso dopo appena tre mesi”, e oggi tutto inserito all’interno del sistema di “Camp Delta” e di altri campi di prigionia.
Nel tempo si sono poi aggiunti altri luoghi resi pubblici solo dalle dichiarazioni di ex detenuti e di ex agenti che lavoravano all’interno del campo: tra tutti “Camp No”, uno dei luoghi più oscuri, collegato a episodi di detenuti poi dichiarati morti; e Penny Lane, il luogo dove Associated Press raccontò che venivano condotti i “combattenti” che potevano essere arruolati come spie.
Torture e privazioni: il “buco nero” degli Stati Uniti
Il governo americano fece subito capire che quello non era un centro di detenzione come gli altri. I primi detenuti, una ventina, arrivarono lì a bordo di un aereo militare e non avevano alcun tipo di diritto paragonabile a quello anche delle peggiori carceri in territorio americano. Da un punto di vista legale iniziarono immediatamente a circolare prima voi poi provvedimenti in cui di fatto Guantanamo era esclusa dalla giurisdizione Usa e che quei detenuti erano prigionieri di guerra che non avevano però possibilità di essere ricondotti sotto la convenzione di Ginevra. Un “buco nero” legale che nel tempo si è arricchito di prigionieri non solo spesso illegalmente catturati (erano gli anni delle “extraordinary renditions” ideate da Donald Rumsfield) ma anche innocenti e riconosciuti come tali solo dopo anni di abusi. In larga parte non vi sono stati nemmeno capi di imputazione o rinvii a giudizio. Violazioni delle più elementari regole processuali furono segnalate già all’inizio della vita di questo campo di prigionia direttamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma sono stati soprattutto i testimoni che hanno potuto lasciare la prigione a descrivere quello che accadeva a Guantanamo.
Impossibile elencare in modo esaustivo i metodi descritti dagli ex prigionieri che hanno passato anni nella base senza alcuna accusa. Per anni non avevano neanche diritto a un processo regolare, con l’eliminazione di uno dei diritti più sacri della Costituzione americana come quello dello habeas corpus. Molti detenuti, la maggior parte, per diverso tempo non hanno avuto nemmeno diritto a un rappresentante legale: erano uomini completamente in balia delle guardie carcerarie e dell’intelligence. Oltre a questa totale assenza di diritti processuali, si aggiungeva poi la pessima condizione di vita e i metodi utilizzati per estorcere informazioni ai prigionieri. L’annichilimento delle persone catturate e detenute nel campo era totale.
Chi ha potuto raccontarlo, ha parlato di “waterborading”, la tortura dell’acqua che prevede l’annegamento un attimo prima di rimanere completamente senza respiro, torture psicologiche e fisiche, violenze sessuali, pratiche degradanti, minacce, pestaggi, cambi repentini di temperature, dal caldo bollente al gelo, musica assordante, metodi di persecuzione religiosa. Chi non parlava, i più duri come chi non aveva semplicemente nulla da dire, veniva costretto in celle grandi quanto la propria persona e rimanere lì per giorni. C’è chi veniva costretto a digiuni prolungati, chi ha detto di essere stato drogato, chi torturato con sveglie nel cuore della notte e interrogatori senza fine per giorni. Tanti sono stati privati del sonno. In un rapporto della task force medica che si è occupata della condizione dei prigionieri di Guantanamo si è giunti alla conclusione che la Cia aveva costretto il personale sanitario a fare di tutto per controllare quelle torture, capire in che modo far sopravvivere le persone abusate e torturate, fino ad arrivare all’alimentazione forzata.
Le denunce e il vero male del campo
Per anni queste torture sono state denunciate da giornali, politica, associazioni legali, associazioni per il rispetto dei diritti umani, e organizzazioni internazionali. Molti esponenti di spicco del Pentagono e delle amministrazione statunitensi che si sono succedute nel tempo hanno promesso cambiamenti sensibili nel trattamento dei detenuti. Eppure quel mostro non è mai stato abbandonato e non ha mai interrotto il suo terrificante lavoro. Un campo che era partito con l’idea di essere il luogo in cui gli Stati Uniti avrebbero punito gli autori e i complici degli attentati dell’11 Settembre, e che invece si è trasformata nel simbolo di un Paese che non è riuscito a sfuggire alla logica della vendetta. Non un faro di civiltà in cerca di giustizia, ma un sistema assetato a sua volta di terrore.
Come ha scritto Domenico Quirico su La Stampa, “il peccato originale di Guantanamo e della guerra al terrorismo, è nel fatto che una democrazia non ha saputo trovare una forma di giustizia per punirli senza a sua volta commettere ingiustizie. Senza diventare come loro”. Purtroppo la storia sembra non avere avuto alcun tipo da lezione. L’Afghanistan è stato abbandonato dopo venti anni di guerra. Guantanamo, che doveva essere una sorta di laboratorio di giustizia interna, si è trasformata oggi nell’ultime eredità di una crociata, come era definita dai sostenitori del conflitto più duro, che non ha visto vincitori né vinti.
FONTE: https://it.insideover.com/terrorismo/guantanamo-venti-anni-stati-uniti.html
Green pass nucleare: esce a maggio la Bomba per l’Italia

Fra quattro mesi, in maggio, inizia negli Usa la produzione su larga scala della nuova bomba nucleare B61-12: lo annuncia la U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (L’Amministrazione per la sicurezza nucleare nazionale, NNSA, facente parte del Dipartimento Usa dell’Energia). Man mano che usciranno di fabbrica, le nuove bombe nucleari saranno consegnate alla US Air Force, che le installerà nelle basi in Italia e altri paesi europei al posto delle B61.
La B61-12 è una nuova arma nucleare polivalente che sostituisce tre delle varianti dell’attuale B61 (3, 4 e 7). Ha una testata nucleare con quattro opzioni di potenza, selezionabili a seconda dell’obiettivo da distruggere. Non viene sganciata in verticale come la B61, ma a distanza dall’obiettivo su cui si dirige guidata da un sistema satellitare. Può penetrare nel sottosuolo, esplodendo in profondità per distruggere i bunker dei centri di comando così da «decapitare» il paese nemico in un first strike nucleare. Per tale attacco la US Air Force dispone anche della quarta variante della B61, la B61-11 penetrante, ammodernata nel 2001. La B61-12, conferma la NNSA, può essere lanciata sia dal bombardiere stealth B-2A e dal futuro B-21, sia da caccia a duplice capacità convenzionale e nucleare.
Tra questi vi sono gli F-16C/D statunitensi schierati ad Aviano e i Tornado italiani PA-200 schierati a Ghedi. Ancora più idonei all’attacco nucleare con le B61-12 sono gli F-35A, già operativi anche nell’Aeronautica italiana. La NNSA comunica che «tutta la produzione necessaria di B61-12» sarà completata nell’anno fiscale 2026. Il programma prevede la costruzione di 500 bombe, con un costo di circa 10 miliardi di dollari (per cui ciascuna viene a costare il doppio di quanto costerebbe se fosse costruita interamente in oro). Il loro numero effettivo resta però segreto, come resta in gran parte segreta la loro dislocazione geografica.
Essa costituisce il fattore determinante della capacità offensiva delle bombe nucleari B61-12. Se fossero dislocate tutte in territorio statunitense, pronte ad essere trasportate con i bombardieri strategici, ciò non costituirebbe una sostanziale modifica degli attuali assetti strategici. Le B61-12 saranno invece dislocate in altri paesi a ridosso soprattutto della Russia, pronte ad essere trasportate e lanciate con gli F-35 e altri caccia.
Le basi di Aviano e Ghedi sono state ristrutturate per accogliere i caccia F-35A armati delle nuove bombe nucleari. A Ghedi possono essere schierati 30 caccia italiani F-35A, pronti all’attacco sotto comando Usa con 60 bombe nucleari B61-12. Non è escluso che esse vengano dislocate anche in altre basi sul territorio italiano. Non è escluso che, oltre ad essere dislocate in Germania, Belgio e Olanda, siano schierate anche in Polonia, le cui forze aeree partecipano da anni alle esercitazioni Nato di guerra nucleare, e in altri paesi dell’Est. I caccia Nato dislocati nelle repubbliche baltiche, a ridosso della Russia, possono essere anch’essi armati delle B61-12. Non escluso che le nuove bombe nucleari possano essere schierate anche in Asia e Medioriente contro Cina e Iran.
Nonostante siano classificate come «armi nucleari non-strategiche», le B61-12, avvicinate agli obiettivi, hanno capacità offensive analoghe a quelle delle armi strategiche (come le testate nucleari dei missili balistici intercontinentali). Sono quindi armi destabilizzanti, che provocheranno una reazione a catena accelerando la corsa agli armamenti nucleari.
Le 5 potenze nucleari membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito – affermano, in una dichiarazione congiunta (3 gennaio), che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta» e che «rimaniamo impegnati a portare avanti negoziati in buona fede su misure efficaci relative alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare». Si impegnino allora gli Usa a non schierare in altri paesi, ancora meglio a non produrre, le nuove bombe nucleari B61-12.
FONTE: https://www.voltairenet.org/article215281.html
POLLI, GALLI E PENNIVENDOLI ASSORTITI
Bruno Sacchini – 9 01 2022
Prendete ad esempio lo svirologo Massimo Galli che, fatte tre dosi, si becca il Covid e va in televisione a confessare che, per guarirsi, ha dovuto fare la monoclonale.
Id est cura alternativa, domiciliare o meno che sia, che altroché incularina e vigile attesa.
Ora, mi scusi lui e tutti i livorosi che i novax li metterebbero sui vagoni piombati: ma questa monoclonale, Galli, non poteva farla senza vaccinarsi prima e rompere i pistoni per due anni e oltre sulle virtù taumaturgiche di Pfizer?
Non si rende conto d’aver fatto così la figura dell’imbonitore, oltretutto da strapazzo?
Visto fra l’altro che con lo stesso rimedio (quando neanche c’era il vaccino) Zingaretti, Johnson, Berlusconi, Trump ecc. dal Covid son venuti fuori senza problemi.
Perché loro sì e noi no?
Ma a parte questo smagliante esempio di sanità di serie A, B e C, perché tanto accanimento su obbligo vaccinale e green caxx visto che l’esplosione di omicron ha dimostrato, statisticamente e scientificamente, che doppia e tripla dose non bastano?
Contraddicendo fra l’altro la nostra costituzionale libertà terapeutica indipendentemente dal Ministro della Disperazione bergamasca Roberto Speranza.
A tutto questo c’è un’unica spiegazione: che Mario Draghi, in quanto socio della Goldman Sachs a sua volta legata alla Big Pharma di Bill Gates, ha dovuto obbedire agli ordini di quest’ultimo che i suoi vaccini deve spacciarli costi quel che costi.
Tanto paghiamo noi, non lui.
C’è un altro dato a riprova di quel che dico: nessuno dei polli, galli o pennivendoli dei salotti RAI e Mediaset ha il coraggio di chiedersi dov’è finito Novovax.
Cioè quel vaccino a struttura consolidata, molto più sicuro di Pfizer, Moderna, Johnson eccetera, già sdoganato in Europa e in Italia, che il governo Draghi non solo non ha acquistato, ma neanche ordinato.
Sparito nel nulla, al contrario della pillola Pfizer che il feldmaresciallo Figliuolo ha già distribuito in tutti i suoi punti vendita: perché Alpino vuol dire fiducia!
Non è per caso (siccome a pensar male in genere ci si prende, salvo andare poi all’inferno) che, siccome Novovax è prodotto da una concorrente della Pfizer, allora nisba assieme a quei no vax che aspettavano solo lui, Novovax, per vaccinarsi?
Infine il postscriptum definitivo, giusto per garantirci il nostro scranno all’Inferno.
In questi ultimi tempi la Pfizer, cioè godless Bill Gates, ha acquistato, per la ridicola cifra di 10 miliardi di dollari, Thrilium Therapeutics e Arena Pharmaceuticals, due aziende farmaceutiche specializzate nella ricerca e cura di malattie cardiovascolari.
Che c’entra?, direte voi.
Invece c’entra, perché si tratta proprio di quelle malattie che Big Pharma sapeva sarebbero nate da un siero sperimentale quale appunto Pfizer e compagni.
Così il nostro genio del male ha pensato di portarsi avanti comprando aziende produttrici di quelle affezioni che, esplodendo negli anni, avrebbero ulteriormente moltiplicato i suoi di lui, Bill Gates, profitti.
Perché altrimenti Marione Draghi avrebbe ancor di più stretto il cappio attorno al collo dei no vax vietandogli perfino di andare a lavarsi i capelli dal barbiere?
Visto che tutto torna?
Arrivederci dunque in Inferno, girone complottisti e paranoici assortiti.
Bruno Sacchini 9 01 2022
FONTE: https://www.facebook.com/100007822153136/posts/3046510595619649/
ARTE MUSICA TEATRO CINEMA
Guarda in alto, non solo la cometa
di Massimo De Angelis
 Don’t look up è un film interessante per diversi motivi. Il principale, secondo Massimo De Angelis, ha a che fare con il possibile destino dei nostri sforzi di cambiare il mondo e di comunicare l’urgenza di questo cambiamento, ma anche di fare di questa comunicazione uno strumento di azione comune e collettiva. Non basta cominciare a guardare in alto per vedere la cometa in picchiata sulla Terra (il cambiamento climatico più della pandemia), c’è da riconoscere e sovvertire in basso l’ordine gerarchico della società nella quale il profitto viene prima di tutto.
Don’t look up è un film interessante per diversi motivi. Il principale, secondo Massimo De Angelis, ha a che fare con il possibile destino dei nostri sforzi di cambiare il mondo e di comunicare l’urgenza di questo cambiamento, ma anche di fare di questa comunicazione uno strumento di azione comune e collettiva. Non basta cominciare a guardare in alto per vedere la cometa in picchiata sulla Terra (il cambiamento climatico più della pandemia), c’è da riconoscere e sovvertire in basso l’ordine gerarchico della società nella quale il profitto viene prima di tutto.
****
Il film Don’t look up è come uno specchio che riflette la coscienza del mondo, uno specchio che ci mostra attraverso quali meccanismi perversi sia possibile che la potenza collettiva accumulata in trecento anni di sviluppo economico si trasformi in impotenza collettiva nella salvaguardia della riproduzione sociale a fronte di una grave minaccia. E questo non per mancanza di conoscenza o tecnologia, ma semplicemente per il modo in cui il nostro mondo è organizzato.
Nel film, la questione della riproduzione sociale è posta dalla minaccia di una cometa gigantesca destinata a colpire la terra, con conseguenze catastrofiche per tutta la vita sul pianeta. Non credo siano concepibili emergenze più gravi della minaccia imminente dell’estinzione di massa (lontana poco più di sei mesi), e sebbene nelle intenzioni del regista il film voglia evocare altre reali minacce alla riproduzione sociale, a cominciare dal cambio climatico, quest’ultima non si presenta ai nostri occhi con lo stesso grado e intensità di catastrofismo di una gigantesca cometa che colpisce il nostro pianeta.
Nel peggiore dei casi del cambio climatico, un aumento di 4 o 6 gradi gradi della temperatura entro la fine del secolo seminerà tanta morte e distruzione di comunità umane e animali con intensità mai viste prima, ma non porterà all’estinzione di massa di tutta la vita del pianeta. Allo stesso modo, la pandemia al limite può fare milioni, decine di milioni e chissà magari anche centinaia di milioni di morti umane, ma non può distruggere tutta l’umanità e tutti gli ecosistemi nei quali essa vive (a questo ci ha pensato il capitalismo che ha creato le condizioni per la trasmissione zoonotica del virus). Questo per dire che la scelta dell’evento limite attorno al quale costruire la narrazione del film è stata una scelta accurata per dare una risposta alla domanda: come si comporta un sistema sociale costruito a piramide attorno al comando capitalistico nei confronti dell’emergenza più catastrofica immaginabile per la riproduzione sociale? E se per tale catastrofe è concepibile e plausibile che la società non sia in grado di mobilitarsi efficacemente, immaginiamoci con catastrofi “minori” rispetto a questa quali il cambio climatico o una pandemia che sono sciocchezze a confronto.
Una chiave di lettura del film la si ottiene attraverso il concetto di “differenza che fa la differenza” di Gregory Bateson. La differenza che fa la differenza è l’informazione che deve essere comunicata attraverso diversi nodi di un circuito affinché un’operazione possa essere portata a compimento realizzando così la sua finalità. Per Bateson questa idea dimostra come la soggettività – quella che lui chiama mente – non è concentrata nel cervello, ma diffusa appunto tra diversi elementi di un circuito produttivo.
Bateson fa un esempio molto semplice. Si prenda un boscaiolo, con tanto di scure, intento a tagliare un albero. Questo processo produttivo si attua attraverso un circuito, gli elementi dei quali sono costituiti dal manico della scure, la sua lama, il taglio nel tronco fatto dalla scure e l’albero. Mentre la scure si muove sotto il controllo del boscaiolo, progressivamente cambia la forma del taglio nel tronco dell’albero. In ogni momento, la dimensione e la forma del taglio avrà un effetto sulla decisione del boscaiolo su come oscillare la scure la prossima volta che si abbatte sull’albero. Ma questo significa che la “notizia” della differenza che fa la differenza viaggia attraverso il circuito produttivo del sistema “boscaiolo-albero” prendendo via via la forma di differenze particolari e specifiche. Il cambiamento nella forma del taglio è ricevuto come informazione della differenza dalla retina del boscaiolo, e cambiamenti nella retina portano l’informazione della differenza che fa la differenza al sistema nervoso centrale, che a sua volta passa l’informazione ai muscoli, questi ultimi al manico della scure che viene inclinato in un certo angolo che a suo modo “informa” la lama che viene mossa in un angolo specifico, la quale lama infine, abbattendosi sul tronco, cambia forma e dimensione del taglio a seconda della grana e dalla densità strutturale dell’albero. Per Bateson, ogni elemento coinvolto nella diffusione dell’informazione attraverso una particolare differenza è parte di quello che costituisce la mente che distingue la differenza. Ora, nel semplice sistema boscaiolo-albero, abbiamo in linea di principio due finalità messe in un chiaro ordine gerarchico, la finalità del boscaiolo (l’abbattimento dell’albero) e quella dell’albero (la cui finalità sarebbe quella di preservarsi). I rapporti di potere tra boscaiolo e albero fanno in modo che la finalità del primo sia quella dominante (e ci dispiace per l’albero).
Nel film la differenza che fa la differenza è la notizia dell’arrivo della cometa e della sua minaccia per la vita entro sei mesi. La circolazione di questa notizia dovrebbe servire alla mobilitazione della cooperazione sociale orientandola verso uno scopo, una finalità: salvare il mondo, quantomeno trovando il modo di ridurre i danni potenziali della cometa. Invece del sistema boscaiolo-albero dell’esempio di Bateson volto alla finalità dell’abbattimento dell’albero, si dovrebbe instaurare un sistema società umana – cometa volto alla finalità della deviazione del corso della cometa. Una scala e un grado di complessità certamente più grande del sistemino di Bateson, ma non impossibile da concepire. Basterebbe che la notizia dell’arrivo della cometa si materializzi in un ampio circuito di cooperazione sociale, un circuito in grado di mobilitare rapidamente risorse sociali di entità tali (testate nucleari, satelliti, space shuttle etc.) da poter deviare il corso della cometa e salvare la terra. Lo stato, e lo stato statunitense in particolare, è l’unica istituzione sociale che può mobilitare risorse di tale entità e in tempi molto brevi. Il film però racconta come non sia possibile salvare il mondo, e non per ragioni “tecniche”, o di conoscenza, e neanche per via della “natura umana” come spesso si sente proferire da varie forme di cinismo essenzialista, ma per ragioni prettamente sociali, di potere sull’orientamento e le finalità della cooperazione sociale in vari ambiti. Un chiaro esempio è quando la notizia entra nel mondo dei media. La modalità del sistema mediatico, di come la trasmissione e riproduzione di questa notizia sia subordinata all’ordine gerarchico delle finalità all’interno di questo sistema è chiaro. La notizia dell’imminente distruzione planetaria è posizionata orizzontalmente con lo spettacolo del gossip. Inoltre, la forma comunicativa deve rendere le cose più leggere e divertenti, come “rendere più dolce la medicina”, rendendo quindi la comunicazione con la finalità della mobilitazione meno efficace, poiché questo modo comunicativo tende a sottovalutare e minimizzare, e quindi a tranquillizzare. Tranquillizzare la moltitudine significa indurla a tornare ad occuparsi della quotidiana normalità della sopravvivenza, nonostante si abbia la conoscenza di un’imminente apocalisse. Ci identifichiamo quindi facilmente con la frustrazione espressa in modo diverso dai corpi di Kate Dibiasky e Randall Mindy, i due astronomi interpretati magistralmente da Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence.
L’esempio più illuminante è quando i due astronomi si rapportano con il sistema stato, ai suoi più alti livelli della presidenza, uno Stato che presto nel film si mostrerà nella sua caratteristica più generale, quella di Capitale-Stato. Al contrario del boscaiolo nell’esempio di Bateson, la finalità dello Stato non è chiara e univoca. Quando i due astronomi entrano alla Casa Bianca per comunicare la grave notizia nella speranza di un’azione immediata e urgente, si trovano nel mezzo di una serie diversa di ordini gerarchici che subordinano la finalità dell’azione urgente per la salvaguardia del pianeta ad altre finalità. In senso generale, questo ordine gerarchico delle finalità subordina i bisogni della riproduzione sociale e della vita ad altre finalità. Proprio per questo esso è nel film la concausa della distruzione planetaria, poiché è un ordine gerarchico che immobilizza l’azione, o la rende vacua.
Vediamo alcune finalità dello Stato che via via vengono nel film a dominare o ad articolarsi alla finalità di salvare il mondo. In primo luogo, lo Stato si mostra asservito alla finalità della propria clientela quando i protagonisti sono fatti aspettare per delle ore perché ovviamente una festa di compleanno nell’entourage del presidente è più importante della notizia di una possibile catastrofe planetaria. Va beh, uno qui può anche dire che un altro presidente con un’altra sensibilità avrebbe fatto migliori public relations. In un successivo momento però, salvare il mondo viene subordinato alla riproduzione politica del presidente. Ci sono infatti le elezioni del midterm e Madam the president è invischiata in uno scandalo che richiede tutta la sua attenzione, quindi per l’amministrazione è meglio sedersi sulla notizia e valutare. Successivamente, quando anche le league universities confermano la gravità della situazione e i media hanno incominciato a pubblicizzare la notizia della cometa, l’ufficio della presidente percepisce l’occasione di allineare le due finalità, quella di salvare il pianeta e quello di rivitalizzare il proprio indice di gradimento, con la pianificazione di un’azione magistrale (missili e compagnia bella diretti alla cometa) guidata simbolicamente da un eroe (quando tecnicamente non c’era bisogno di nessun eroe) che serva a riprodurre i vecchi valori dell’individualismo e del razzismo. Un uomo di altri tempi appunto. Ma anche questo accoppiamento strutturale tra due finalità (quello della riproduzione sociale e della riproduzione politica della presidente) viene frantumato quando si instaura il vero comando del capitale con il suo ordine gerarchico: il profitto prima di tutto. E la cometa rappresenta appunto una grande opportunità di profitto, grazie all’intervento (ahimè) del visionario imprenditore che non può resistere alla tentazione di legare le sorti del pianeta al mito di una tecnologia mai prima sperimentata e immaginata (vi fischiano le orecchie? Il nucleare di quarta generazione? Geo-ingegneria contro il cambio climatico?) e allo stesso tempo salvifica e arricchente (quella che nella nostra vera vita ci tocca in sorte come green technology che a detta dei potenti ci salverà dal cambiamento climatico e promuove allo stesso tempo la crescita economica). E così, la cometa da minaccia si trasforma magicamente in opportunità, venendo narrata come miniera vagante dalla quale estrarre minerali di gran valore monetario e per mezzo della quale si fantastica la soluzione di tutti i problemi sociali del mondo – quante volte lo abbiamo sentito nel corso della storia del capitalismo – e addirittura si immagina un destino intergalattico dell’umanità (e quanta accumulazione di capitale e ingiustizie ambientali e sociali ci dovremo sorbire prima di arrivare a quel punto?). È questa una fantasia proveniente direttamente dalla razionalità del capitale, una fantasia che mobilita un potere reale, perché perseguita da soggetti come Peter Isherwell, nel film il miliardario titolare di una multinazionale tecnologica che ha nel suo libro paga anche la Presidente. Una fantasia che si impone nell’ordine gerarchico delle finalità e che subordina fino al punto di annientarla la riproduzione sociale (e della vita). Alla fine, il sogno intergalattico del capitalista si avvera, ma non proprio come anticipato nella sua fantasia, ma come piano B di fuga dell’1 per cento dalla terra in rovina.
Don’t look up ha tante sfaccettature che meritano di essere evidenziate. A me ha interessato mettere in rilievo l’immagine che ci riflette del possibile destino dei nostri sforzi di cambiare il mondo e di comunicare l’urgenza e la necessità di questo cambiamento, e di fare di questa comunicazione strumento di mobilitazione comune e collettiva. Un destino gramo che si produce proprio nel momento della circolazione della differenza che fa la differenza, del suo passaggio da soggetti che abitano un mondo dove non ci sono “ma” alla priorità della riproduzione della vita nel suo complesso, a un mondo dove non ci sono “ma” alla riproduzione del capitale e del potere. Finché non troviamo un modo per rompere questo impasse tra le due riproduzioni, e a sovvertire l’ordine gerarchico delle finalità, il nostro gramo destino è, asintoticamente parlando, quello illustrato dal film. E se questo dovrà essere, speriamo solo di vivere gli ultimi momenti in dignità comune, mano nella mano, consapevoli almeno di averci provato a cambiare il mondo, come in una scena finale tra i protagonisti del film.
FONTE: https://www.sinistrainrete.info/cultura/21969-massimo-de-angelis-guarda-in-alto-non-solo-la-cometa.html
ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME
Vergognoso silenzio della sinistra sui molestatori stranieri di Capodanno

FONTE: https://www.facebook.com/watch/?v=279482564164279
Draghi: le nostre scelte sono basate sui DATI
Sentendo una tale affermazione, mi viene voglia di ripetere le stesse domande fatte tempo fa a Zaia e rimaste senza risposta:
- dove sta la prova scientifica dell’esistenza del Sars-Cov2?
- dove sta la prova scientifica della sua letalità?
- dove sta la prova scientifica del contagio?
- dove sta la prova scientifica che un sano possa contagiare?
- perchè si usa il test pcr se il CDC stesso ammette che non distingue fra covid e una banale influenza?
- perchè alterate le statistiche, includendo i vaccinati da meno di 14 giorni fra i NON vaccinati?
- perchè rendete impossibile la segnalazione delle reazioni avverse?
- come potete trascurare l‘aumento di mortalità coincidente con l’introduzione dei vaccini?
- ecc. ecc.
Ma loro continuano dire che si basano sulla scienza e sui dati. E i babbei continuano a crederci.
Si sa, la menzogna è il loro pane quotidiano:
Consoliamoci con l’ottimo Silver Nervuti, che cir icorda la definizione che di Draghi aveva fatto il presidente della repubblica Cossiga: “Un vile affarsta”:

VIDEO QUI: https://www.youtube.com/watch?v=StsYZwVTRr0
FONTE: https://www.ingannati.it/2022/01/07/draghi-le-nostre-scelte-sono-basate-sui-dati/
BELPAESE DA SALVARE
La Corte dei Conti blocca il “regalo” dello Stato ai Benetton: cosa è successo
11 Gennaio 2022
Nel marasma pandemico rischia di finire nel dimenticatoio – come per altro sperano i diretti interessati – anche la vicenda Autostrade e Benetton. Dopo la tragedia del Ponte Morandi e tanti proclami, si rischia che gli italiani – e soprattutto i parenti delle vittime – subiscano oltre il danno anche la beffa. Cioè va a finire che i Benetton ci guadagneranno pure. Come ricostruisce Carlo Di Foggia su Il Fatto Quotidiano, “a tre anni e mezzo dal disastro del ponte Morandi di Genova, l’epilogo dello scontro tra il governo e la Atlantia dei Benetton, che controlla Autostrade per l’Italia, sembra scritto. Sono tutti concordi: governo e organismi tecnici, maggioranza parlamentare e pure l’Autorità dei Trasporti. Nessuna revoca della concessione, Aspi passerà dalla holding dei Benetton a un consorzio guidato dalla pubblica Cassa Depositi e Prestiti (coi fondi Blackstone e Macquarie) per 8 miliardi”.
I nuovi azionisti verranno garantiti da tariffe perfino più generose di quelle che hanno reso ricchissima la famiglia veneta. L’unico ostacolo – e quindi speranza – a questo epilogo è oggi la Corte dei Conti. “Il 20 luglio scorso, la Procura del Lazio ha aperto un fascicolo sull’accordo governo-Altantia. L’indagine parte dagli esposti di diversi parlamentari. Al momento è in fase istruttoria, il procuratore Pio Silvestri ha chiesto gli atti ai ministeri (Tesoro e Trasporti): l’obiettivo è verificare se l’accordo sia nell’interesse dello Stato o prefiguri un danno erariale. Per capire come finirà bisognerà però aspettare il parere definitivo della Sezione di controllo, che poco prima di Natale ha provvisoriamente bocciato l’intesa”.
Aspi mette sul piatto 3,4 miliardi di indennizzi in cambio della rinuncia del ministero alla revoca della concessione. “Serve il via libera della Corte dei Conti. Ma la sezione di controllo ha restituito gli atti per carenza documentale e sollevato diverse obiezioni”. La prima è che “l’Accordo transattivo potrebbe palesare criticità in ordine all’equilibrio economico e, quindi, alla sua sostenibilità”, visto che gli atti non dimostrano che nel “costo della transazione (3,4 miliardi) si sia tenuto conto della valorizzazione (in diminuzione) delle quote di Atlantia in Aspi”. Insomma, gli 8 miliardi scontano questa spesa?
Spiega Di Foggia: “Non è chiaro, visto che, scrivono i magistrati, dal testo non si può escludere che sarà ‘la controparte pubblica ad assumere, di fatto, l’onere della transazione’”. Inoltre, “la Corte dei Conti sottolinea che l’accordo non prevede una clausola a tutela di Cdp nel caso Autostrade venga condannata al processo di Genova perdendo il diritto alla concessione. Sarebbe una beffa clamorosa”. L’ultima obiezione della Corte è che “mancano manleve legali per evitare che in futuro Atlantia si rifaccia su Autostrade controllata da Cdp per cause avanzate da terzi”.
FONTE: https://www.ilparagone.it/attualita/autostrade-benetton-corte-dei-conti/
Il provvedimento con il quale il GIP del tribunale di Agrigento, il 20 dicembre 2021, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale ancora pendente a carico della “capitana” Carola Rackete per i reati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra era quanto di più prevedibile si potesse immaginare, alla luce del precedente costituito dalla sentenza della Cassazione n. 6626 del 16 gennaio 2020. Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione spiega perché si tratta di decisioni assai opinabili.
1. Con tale pronuncia, adottata su ricorso del pubblico ministero avverso la mancata convalida dell’arresto della stessa “capitana” per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra, consistiti nell’aver speronato, con la nave Sea Watch, di cui era al comando, una motovedetta della Guardia di Finanza – che, come da ordini ricevuti, aveva cercato di impedirle l’attracco al porto di Lampedusa -, era stato affermato che Rackete non dovesse rispondere di tali reati in forza della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 cod. pen., avendo essa agito “nell’adempimento di un dovere”
Il dovere era quello derivante dalle Convenzioni internazionali, tra cui in particolare la Convenzione di Amburgo del 1979, recepita in Italia con legge 3 aprile 1989 n. 147 (c.d. “legge del mare”), in base alla quale il comandante di qualsiasi nave ha l’obbligo di prestare soccorso a quanti si trovino in mare in condizioni di pericolo e di condurli nel più vicino “luogo sicuro” (“place of safety”). Quest’ultimo sarebbe stato, secondo la Cassazione, legittimamente individuato da Rackete nel porto di Lampedusa, dovendosi ritenere “non sicuri” tutti i porti della costa libica, dalla quale avevano preso il mare, con l’obiettivo di raggiungere, in un modo o nell’altro, l’Italia, numerosi “migranti” che erano stati poi soccorsi e presi a bordo dalla Sea Watch. Di qui, per conseguenza, la ritenuta operatività della stessa causa di giustificazione anche con riguardo ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di disobbedienza a nave da guerra, commessi nell’ambito della medesima vicenda, e per i quali Rackete era stata denunciata a piede libero.
Il provvedimento di archiviazione, come pure, a suo tempo, la citata sentenza della Cassazione, sono stati accolti, com’è noto, con entusiastico favore dalla vasta galassia dei partiti, organi di informazione, associazioni, movimenti, e così via, pregiudizialmente favorevoli all’immigrazione incontrollata. Per essi è fuori discussione l’equazione “dovere di soccorso = dovere di accoglienza”, su cui si basano, nell’essenziale, le pronunce giudiziarie in discorso, e in forza della quale si ha buon gioco nel sostenere che escludere il secondo dei detti doveri significa anche contravvenire al primo. A rischio di apparire presuntuosi, va detto chiaro e forte che quell’equazione non ha, in realtà, il minimo fondamento giuridico. Vediamo perché.
2. Il dovere di soccorso, la cui assolutezza e inderogabilità non conosce eccezioni, è stato stabilito dalla c.d “legge del mare” a tutela non dei “migranti” ma di quanti, trovandosi in mare per una qualsiasi ragione, corrano pericolo per la loro vita o la loro incolumità personale. Ciò comporta che per “luogo sicuro” nel quale il soccorritore ha poi l’obbligo di condurre le persone tratte in salvo deve intendersi non quello in cui le stesse, se e in quanto qualificabili come “migranti”, abbiano la garanzia che possano essere presentate ed esaminate eventuali richieste di asilo o di protezione internazionale, ma soltanto quello nel quale, come espressamente stabilito nelle linee guida elaborate nel 2004 dall’IMO-International maritime organization, “le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove: la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale”.
Questo non significa, naturalmente, che sia destinata a rimanere necessariamente ignorata l’esigenza di assicurare, per quanto possibile, alle persone soccorse che siano anche “migranti”, la possibilità di presentare richieste di asilo o di protezione internazionale. Significa soltanto che di essa non può e non deve darsi carico il comandante della nave soccorritrice, il quale deve invece, di regola, attenersi all’indicazione del “luogo sicuro” che, sempre secondo le “linee guida” dell’ IMO, deve essergli fornita dal governo o da altra autorità dello Stato responsabile della zona SAR in cui è avvenuto il recupero. A darsene carico – su eventuale segnalazione dello stesso comandante – dovrebbe essere invece la competente autorità dello Stato di bandiera della nave soccorritrice, dal momento che quest’ultima è da considerare, a tutti gli effetti, come territorio del medesimo Stato.
Essa e solo essa, quindi, avrebbe titolo per fornire al comandante le opportune istruzioni sul come gestire la situazione dei “migranti”. Come pure è la stessa autorità quella che dovrebbe assumersi il compito e la responsabilità di autorizzare il comandante a non attenersi all’indicazione del “luogo sicuro” fornita dallo Stato responsabile della zona SAR – che nella specie era la Libia – quando ritenga che manchi, in realtà, taluna delle condizioni previste dalle citate Linee guida IMO, impartendogli, anche in questa ipotesi, le opportune istruzioni. Nell’uno e nell’altro caso, fra tali istruzioni potrebbe anche esservi quella di dirigersi verso un porto di uno Stato diverso, a condizione però di aver preventivamente chiesto ed ottenuto – senza poterlo pretendere – il consenso dello Stato medesimo.
Alla stregua di tali considerazioni, deve dunque escludersi che i comandanti delle navi ONG, come pure di qualsiasi altra nave che effettui il soccorso di quanti versino, trovandosi in mare, in condizioni di pericolo (migranti o non migranti che essi siano), abbiano poi titolo per disattendere, di loro iniziativa, l’indicazione del porto che, come “luogo sicuro”, a essi sia stata fornita dalla competente autorità dello Stato responsabile della zona SAR in cui è avvenuto il recupero. Meno che mai può ammettersi che abbiano titolo per individuare essi stessi il diverso porto verso il quale dirigersi per poi pretendere di farvi sbarcare le persone soccorse.
3. D’altra parte, non può neppure dirsi che, a far ritenere giudizialmente accertato il fatto che siano “non sicuri” tutti i porti della Libia, ivi compreso quello di Tripoli, che pur risulta aperto al normale traffico di merci e passeggeri, siano sufficienti le pubbliche denunce delle stesse ONG che si dedicano stabilmente alla raccolta dei “migranti” provenienti dalle coste libiche, e neppure quelle di altri organismi, compreso lo stesso Commissariato dell’ONU per la tutela dei rifugiati (UNHCR), dalle quali tutte risulterebbe che i “migranti”, giunti in Libia da altri paesi nella speranza di poter poi raggiungere, via mare, l’Italia o altri paesi europei, sarebbero sottoposti a sistematiche e gravi violazioni dei più elementari diritti umani. Anche a fronte di tali denunce, infatti, siccome non dirette specificamente all’autorità giudiziaria, quest’ultima sarebbe tenuta, secondo le regole generali, a indicare, con apposita motivazione, le specifiche ragioni non solo della loro attendibilità in generale, ma anche della loro ritenuta idoneità a costituire prova della effettiva sussistenza della dedotta causa di giustificazione del reato per cui si procede, con riferimento a tutte le proprie e peculiari circostanze del caso concreto.
Tanto più sarebbe stata necessaria una tale motivazione (che risulta, invece, del tutto mancante), in quanto, a far sorgere almeno un qualche ragionevole dubbio circa la fondatezza delle denunce in questione, se non altro sotto il profilo della estensione delle situazioni in esse descritte a tutti indistintamente i “migranti” che si trovino in qualsiasi parte del territorio libico, dovrebbe essere, tra l’altro, il fatto che il governo italiano, da parte sua, con il sostegno di una maggioranza che comprende anche partiti notoriamente assai propensi all’accoglienza senza limiti dei “migranti”, oltre che con l’avallo dell’Unione europea, finanzia ed assiste ufficialmente la Guardia costiera libica perché si dia carico di intercettare e ricondurre sulle coste della Libia i “migranti” che da esse si siano messi in mare per raggiungere l’Italia.
Qualche altro dubbio, inoltre, sarebbe potuto sorgere ricordando il caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 23 febbraio 2012, Hirsi c. Italia, con la quale l’Italia venne ritenuta responsabile di un illegittimo respingimento collettivo verso la Libia di “migranti” intercettati nel Mediterraneo per la sola ed esclusiva ragione (peraltro assai discutibile) che tale respingimento sarebbe stato assimilabile a una “espulsione collettiva”, come tale vietata dall’art. 4 del protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: non, quindi, perché vi fosse stata violazione della “legge del mare” a cagione del carattere “non sicuro” dei porti libici verso i quali il respingimento era stato effettuato. L’eventuale sussistenza di tale carattere “non sicuro”, poiché implica la negazione dei più elementari diritti umani tra i quali, con ogni evidenza, anche quello di libera comunicazione con il resto del mondo, difficilmente sarebbe stata compatibile con il fatto, risultante dalla stessa sentenza della Corte europea, che proprio dalla Libia, dove erano stati respinti, i “migranti” avevano avuto modo di promuovere, con la necessaria assistenza di legali da loro nominati, l’azione giudiziaria contro l’Italia.
4. Last but not least, vi è infine da dire che, anche ad ammettere che i “migranti” raccolti dalle navi delle ONG al largo delle coste libiche non potessero essere riportati al luogo di partenza, perché da ritenere “non sicuro”, ma dovessero essere condotti verso un porto italiano, ciò non potrebbe in alcun modo valere ad escludere la configurabilità, a carico delle stesse ONG, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quale previsto dall’art. 12 commi 1, 2 e 3 del D.L.vo n. 286/1998. Tale reato è da ritenere sussistente ogni qual volta risulti – come, di fatto, risulta, in modo assolutamente pacifico, nella gran parte dei casi -, che la raccolta dei “migranti” in situazione di pericolo non sia frutto di un occasionale incontro, ma di una programmata attività concepita proprio in funzione di un supporto da fornire all’immigrazione clandestina, consistente nel pubblicizzato stazionamento delle navi in prossimità dei luoghi di partenza dei “migranti” a bordo di imbarcazioni di fortuna, in modo che sia loro garantita la sicurezza di essere tratti in salvo non appena vengano a trovarsi, come già previsto, in pericolo di naufragio.
A questo punto la punibilità delle ONG a titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non deriverebbe certo – come pretestuosamente si vorrebbe far credere nella “vulgata” immigrazionista – dall’avvenuto salvataggio delle persone in pericolo, essendo questo sempre e comunque doveroso e pertanto insuscettibile di sanzione. Esso deriverebbe dal fatto che in detto pericolo quelle persone mai si sarebbero trovate se non fossero state indotte ad affrontarlo proprio contando sulla presenza delle navi già predisposte per il soccorso. Questa presenza viene quindi a costituire un determinante contributo consapevolmente offerto dalle ONG agli organizzatori dei “viaggi della speranza”, tale da poterle far ritenere concorrenti con costoro, noti o ignoti che siano, nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: senza quel contributo, essi non si sarebbero indotti a commetterlo, ovvero lo avrebbero fatto procurando la disponibilità di mezzi almeno potenzialmente idonei a compiere la traversata del mare.
Ciò, del resto, corrisponde puntualmente a quanto in gran parte risulta già avvenuto nel breve lasso di tempo in cui l’attività delle ONG è stata fortemente ostacolata, pur se non del tutto impedita, per effetto della scelta politica adottata dal Governo dell’epoca, in coincidenza della quale si registrò, di fatto, un drastico calo tanto degli afflussi di “migranti” via mare quanto delle perdite di vite umane, a essi correlate.
È il caso di precisare che quanto appena detto sul possibile concorso delle ONG nel reato in discorso vale indipendentemente dalla dimostrata esistenza o meno di un previo accordo tra le stesse ONG e quelli che abbiamo definito come organizzatori dei “viaggi della speranza”. Per costante e indiscussa giurisprudenza, il concorso di più persone in un medesimo reato, quale previsto dall’art. 110 cod. pen., non richiede la prova che tutti i concorrenti abbiano preventivamente raggiunto tra loro la comune decisione di commettere il fatto, essendo invece sufficiente un qualsiasi contributo anche unilateralmente prestato che valga a rafforzare l’altrui proposito criminoso, senza alcuna necessità di “un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo” (così, fra le altre, Cass. I, 28 gennaio – 3 giugno 1998 n. 6489).
Se così è, l’incriminazione delle ONG per concorso nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina avrebbe dovuto costituire quasi una regola, non invece, come è avvenuto, una eccezione (poi seguita, peraltro, per quanto è dato sapere, da un nulla di fatto); e ciò avrebbe dovuto comportare anche la sistematica applicazione, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del sequestro preventivo dei mezzi navali adoperati per commettere il reato, in vista della confisca obbligatoria di tali mezzi, quale prevista, in caso di condanna o anche di applicazione della pena su richiesta dall’art.12 co. 4 ter del D.L.vo n. 286/1998; applicazione che normalmente viene disposta in tutti i procedimenti relativi agli altri, numerosi reati per i quali la legge prevede analoghi obblighi di confisca ,ma che, per misteriose ragioni, nei rari processi intentati a carico di ONG non risulta essere stata mai disposta.
5. In conclusione si può affermare non solo che la causa di giustificazione dei reati per i quali si è proceduto a carico di Carola Rackete è del tutto insussistente, ma anche che, in ossequio alla legge vigente e alla luce di elementari principi di diritto, in tutte le numerose volte in cui la condotta delle ONG aveva assunto le caratteristiche sopra descritte, si sarebbe dovuto dar luogo a una loro incriminazione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e alla conseguente applicazione del sequestro preventivo a fine di confisca dei mezzi navali da esse adoperati
Con il che si sarebbe pressoché azzerato tanto l’afflusso di “migranti” irregolari provenienti dal nord Africa – in grandissima parte, com’è noto, non aventi titolo alcuno alla protezione internazionale -, quanto il numero di coloro che hanno trovato la morte nel tentativo di compiere la traversata del mare. Perché ciò non è avvenuto e non sembra nemmeno ragionevolmente prevedibile che possa avvenire?
Pietro Dubolino
FONTE: https://www.centrostudilivatino.it/caso-rackete-tra-cause-di-giustificazione-che-non-esistono-e-leggi-e-che-esistono-e-non-sono-applicate/
CONFLITTI GEOPOLITICI
Perché la Somalia rischia di diventare l’Afghanistan d’Africa
Friedrich Hegel sosteneva che l’unico insegnamento tangibile della storia è che gli uomini dalla storia non hanno mai imparato nulla. Un aforisma su cui riflettere, una lezione fatalista o un cinico risultato di un’equazione applicabile ad ogni epoca e luogo? Per provare a rispondere occorre riportare lo sguardo sull’ultimo grande evento storico che ha catalizzato l’attenzione globale: la presa dell’Afghanistan da parte dei talebani.
Lo choc della riconquista talebana
15 agosto 2021, da giorni circolano notizie di un plausibile arrivo dei talebani a Kabul in concomitanza con il ritiro dei soldati americani. Le voci e le supposizioni, con il passare delle ore, mutano in certezze, i ribelli entrano nella capitale e da quel momento i fatti sono drammaticamente noti: la richiesta disperata dei visti da parte della popolazione, le bandiere bianche con impressi i versi coranici sventolanti sui pickup degli islamisti, le raffiche di kalashnikov per le vie cittadine, l’assalto procelloso del popolo afghano all’aeroporto della capitale, la canea dei cittadini in fuga, l’indignazione globale e il rodìo corale del rimorso sociale. Giorni storici di dirette televisive ed editoriali, di comparazioni ed equiparazioni, di Saigon come Kabul, e di un corale “mai più!”.
Ma il dramma afghano poco a poco è divenuto più silenzioso, lontano, e troppo velocemente ha iniziato ad essere relegato a una cronaca scritta al tempo passato mentre la massima del filosofo tedesco, da brusio lontano e accademico, ha ricominciato a echeggiare, sempre più forte e ammonitrice. A soli quattro mesi da quei drammatici momenti di agosto sta per ripresentarsi infatti un analogo “caso Afghanistan”. Un contingente internazionale che si ritira, un gruppo jihadista che avanza e una popolazione, condannata da anni a un neghittoso oblio mediatico, che rischia di venire travolta dal totalitarismo teologico delle bandiere nere. Dove? In Somalia.
Il ritiro dell’Unione africana
Quattordici anni esatti dopo essere stata schierata per combattere l’insurrezione islamista di Al-Shabaab, la missione dell’Unione Africana in Somalia (Amisom) è arrivata a scadenza di mandato. Il 31 dicembre, come da calendario, il mandato della missione è terminato, l’Onu ha prorogato l’impegno dei caschi verdi per soli altri 3 mesi e le possibilità che possa esserci un ulteriore rinnovo a fine marzo sono molto esigue. Parallelamente, le forze di sicurezza somale, che dovrebbero prendere il testimone lasciato dalla missione Amisom, non sono assolutamente in grado di sostituire in modo efficiente ed operativo le truppe del contingente di peacekeeping, le milizie qaediste, negli ultimi mesi, hanno mostrato di aver rafforzato e perfezionato le proprie tattiche militari e la Somalia, che sta affrontando una burrascosa crisi politica, rischia quindi, in termini molto concreti, di essere un nuovo Afghanistan ma di terra d’Africa.
Il ruolo che ha avuto, all’inizio del suo mandato, la missione di interposizione dell’Unione Africana è stato cruciale per la flebile stabilizzazione dell’ex colonia italiana. Nei primi anni del loro intervento i caschi verdi hanno infatti respinto le forze islamiste dai principali centri abitati, hanno permesso una timida ripresa della nazione, un ritorno delle rappresentanze diplomatiche internazionali sul suolo somalo, e hanno contribuito alla formazione di un sistema politico locale oltre che alla ricostruzione di infrastrutture e servizi basici.
Ma dai successi iniziali si è passati poi a un’impasse militare e politica. Critiche e scandali hanno iniziato a travolgere il contingente dei caschi verdi, la sigla jihadista non solo non è stata sconfitta ma in alcune aree è riuscita a riorganizzarsi e passare al contrattacco e l’obiettivo iniziale dell’Amisom, ovvero portare a una completa stabilizzazione della Somalia, è stato raggiunto solo in parte. Un lavoro importante, certo, ma ben al di sotto delle aspettative.
Alla luce di tutto questo, dopo quasi cinque lustri di missione, i principali donatori internazionali hanno iniziato a mostrarsi scettici sul fatto di procedere a un’ulteriore iniezione di capitale per il mantenimento di una missione che ha evidenti problematicità. E oggi la paventata chiusura dei rubinetti è l’ostacolo maggiore a un possibile rinnovo del mandato dell’Amisom dopo questi re mesi di proroga. L’Unione Europea, le Nazioni Unite e altri supporters internazionali appaiono infatti dubbiosi riguardo al finanziamento della missione. La prima incognita che li attanaglia riguarda l’effettivo valore che ha ora la missione stessa, dal momento che Amisom, negli ultimi anni, ha smesso di passare all’offensiva ma ha iniziato a svolgere unicamente un ruolo di contenimento e protezione delle aree ritornate sotto controllo del governo di Mogadiscio. La seconda incognita è dettata invece dalla stabilità del governo somalo che sta affrontando da mesi una crisi politica paralizzante che vede l’esecutivo contrapporsi agli stati federali che fanno parte della Somalia, uno scontro che è degenerato in una prova di forza tra il presidente ad interim Mohammed Abdullahi, detto Farmajo, e il primo ministro Mohamed Husein Roble. Una frattura in seno al governo che si teme possa degenerare in uno scontro armato tra fazioni e milizie rivali facenti capo rispettivamente al presidente e al premier.
I limiti della missione
Alla luce di questi due fattori i principali finanziatori continuano a chiedersi quali sarebbero quindi i compiti che l’Amisom dovrebbe perseguire e quali garanzie sull’utilizzo dei fondi possono avere loro, in quanto sovvenzionatori, da parte di un governo diviso, con enormi problemi di corruzione, e permeato da faide ontologiche. Il timore che l’estensione del mandato di Amisom non possa avere alcuna possibilità di portare a termine completamente i suoi scopi aleggia in maniera sempre più prepotente e inoltre, a preoccupare particolarmente i donatori è la paura di un impegno molto importante a livello economico per un’operazione ritenuta claudicante già in partenza.
Ma se da un lato queste analisi sono assolutamente legittime e inopinabili, dall’altro lato però è evidente che un ritiro o una drastica riduzione del contingente militare, qualora avvenisse, avrebbe conseguenze peggiori rispetto al mantenimento, con tutte le sue falle e criticità, della missione dei caschi verdi. In sostanza ci si trova di fronte a uno stallo alla messicana nel Corno d’Africa. Mantenere la missione significa infatti finanziare con enormi quantità di capitale un impegno che, ad oggi, si sa già essere in parte fallace. Ritirare il contingente vuol dire invece delegare all’impreparato esercito somalo e al farraginoso e rissoso governo di Mogadiscio il compito di contrastare il gruppo Al Shabaab che invece, negli ultimi mesi, è tornato a colpire violentemente mostrando una preparazione e una struttura molte ben articolate.
La sigla qaedista, che negli anni ha dimostrato di essere una professionista della resurrezione capace di ricostituirsi e riformulare le sue strategie di guerra anche nei momenti più critici, è tornata infatti all’attacco. Negli ultimi mesi c’è stato un feroce acuirsi delle azioni terroristiche e kamikaze nella capitale e nei principali centri urbani e inoltre i miliziani islamisti hanno preso il controllo di intere regioni dell’entroterra. Al Shabaab, da un punto di vista militare, vanta tra le sue fila oltre 10mila uomini e una colonna specializzata in spionaggio, ma un aspetto estremamente importante è che nelle aree dove esercita il suo potere, la formazione salafita è riuscita a creare, come rivela un indagine dell’International Crisis Group, sistemi statuali e servizi basici molto più efficienti rispetto a quelli messi in opera dal governo centrale. E questo, come già si è verificato in altre aree africane amministrate da gruppi appartenenti all’internazionalismo jihadista, ha spinto parte della popolazione ad appoggiare le bandiere nere e la loro politica.
Quale soluzione allora? È evidente che l’impegno e il ruolo di Amisom, che come obiettivo ha quello di portare a una stabilizzazione del Paese, devono essere riformulati. Inoltre devono essere date sicurezze concrete ai finanziatori e la politica somala deve ricucire le falle che stanno facendo marcescire lo sviluppo democratico della nazione. Ma, nonostante tutte le legittime e comprensibili preoccupazioni, la continuazione di Amisom è ad oggi l’unico strumento che può evitare una crisi militare, politica e umanitaria di dimensioni ciclopiche nel Paese africano.
Se però non si arriverà a una nuova pianificazione del lavoro del contingente militare dell’Unione Africana, a una pacificazione politica e i donatori non otterranno le legittime garanzie che chiedono , il ritiro dei caschi verdi sarà inevitabile e a quel punto la realtà, di nuovo, darà ragione al filosofo tedesco.
La Somalia verrà travolta da un’ondata di violenza, le forze islamiste avranno modo di poter passare alla controffensiva su larga scala e il “fattore Afghanistan” si ripresenterà nel Corno d’Africa. In questo caso non ci saranno né una nuova Kabul e neppure una vecchia Saigon, ma un’ eterna Mogadiscio, dal momento che da anni la Somalia è il proscenio dei fallimenti delle missioni internazionali e il prezzo più alto di questi insuccessi lo pagherà, ieri come oggi, la popolazione locale.
FONTE: https://it.insideover.com/terrorismo/missione-unione-africana-somalia-afghanistan.html
In Kazakistan Washington porta avanti il piano della RAND, poi toccherà alla Transnistria
Quanto accade da una settimana in Kazakistan è la quinta fase di un piano della RAND Corporation; la sesta riguarderà la Transnistria; le precedenti quattro fasi si sono svolte negli ultimi due anni in Ucraina, Siria, Bielorussia e Nagorno Karabakh. Obiettivo: indebolire la Russia e costringerla a sovraesporsi.

Questo articolo è il seguito di
«La Russia vuole costringere gli USA a rispettare la Carta delle Nazioni Unite», 4 gennaio 2022.
Durante il colloquio telefonico del 30 dicembre 2021 con l’omologo russo Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto alla proposta della Russia di un Trattato che garantisca la pace sulla base del rispetto scrupoloso della Carta delle Nazioni Unite e degli impegni assunti [1]. Non sorprende che Biden abbia ignorato la sostanza della richiesta russa, limitandosi ad alludere a una possibile cessazione delle operazioni USA in Ucraina.

Il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti ha simultaneamente avviato parecchie azioni contro la Russia. L’obiettivo non è rovesciare governi o scatenare nuove guerre, ma sfiancare Mosca, obbligandola a intervenire fuori dalle proprie frontiere. La Federazione di Russia si estende infatti su un territorio gigantesco, che non riesce a gestire con una popolazione di appena 150 milioni di abitanti.
A tal proposito, a maggio 2019 la RAND Corporation, il think-tank del complesso militare-industriale USA, aveva enumerato sei opzioni [2]:
1. armare l’Ucraina;
2. incrementare il sostegno agli jihadisti in Siria;
3. promuovere un cambiamento di regime in Bielorussia;
4. sfruttare le tensioni nel sud del Caucaso;
5. ridurre l’influenza russa in Asia centrale;
6. competere con la presenza russa in Transnistria.
Dall’11 al 13 ottobre 2021 la sottosegretaria di Stato per gli Affari politici, Victoria Nuland, ha incontrato a Mosca il governo russo. Con l’occasione è stato rimosso in via eccezionale il veto d’ingresso in Russia [3]. Nuland infatti non è una funzionaria qualsiasi. È una ragguardevole esponente dello Stato Profondo USA, che ha fatto parte di tutte le amministrazioni, repubblicane e democratiche, a eccezione dell’amministrazione jacksoniana del presidente Donald Trump. Fu lei a chiamare a raccolta nel 2001 gli alleati per combattere in Afghanistan, nonostante l’opposizione del presidente francese Jacques Chirac e del cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Fu ancora lei che, alla fine della guerra del 2006 contro il Libano, salvò Israele organizzando un cessate-il-fuoco unilaterale ed evitandogli l’umiliazione della disfatta militare. Fu di nuovo lei a organizzare nel 2014 la rivoluzione colorata del Maidan per rovesciare il presidente ucraino Viktor Yanukovich e sostituirlo con dei nazisti. Se ne poté allora costatare il disprezzo nei confronti degli europei, provocando disagio a Bruxelles e sanzioni contro Mosca.

Nuland appartiene a un’illustre famiglia neoconservatrice. Il marito non è altro che Robert Kagan, uno dei fondatori del Progetto per un nuovo secolo americano (Project for a New American Century – PNAC) che raccolse fondi per mandare alla Casa Bianca George W. Bush (figlio) e auspicò «una nuova Pearl Harbor», che gli attentati dell’11 Settembre poi realizzarono. Il cognato, Frederick Kagan, è un pilastro dell’Istituto dell’Impresa America (American Enterprise Institute). Fu l’ispiratore della politica USA di occupazione dell’Afghanistan e dell’Iraq. La cognata, Kimberly Kagan, è presidente dell’Istituto per lo studio della guerra (Institute for the Study of War). Svolse un ruolo di primo piano in tutte le guerre del Medio Oriente Allargato, in particolare nella politica dei rafforzamenti (the surge) in Iraq.
A luglio 2020 Nuland spiegò come trattare con la Russia in un provocatorio articolo su Foreign Affairs, “Inchiodare Putin” [4]. L’autrice, neoconservatrice, all’epoca collaboratrice dell’ex segretaria di Stato democratica Madeleine Albright, illustrava come il futuro presidente avrebbe dovuto agire nei confronti di Mosca. Dopo aver presentato una Russia in rovina e un Putin allo stremo, proponeva di negoziare un nuovo Trattato START [Strategic Arms Reduction Treaty, Trattato di riduzione delle armi strategiche, ndt], di ostacolare l’uso di internet da parte dei russi, di sostenere l’adesione dell’Ucraina alla UE (e successivamente alla NATO), nonché l’opposizione armata in Siria. Preconizzava investimenti USA per modernizzare quel povero Paese che è la Russia, in cambio del suo allineamento politico alle «democrazie occidentali». Il Cremlino, che ne respinge totalmente le affermazioni, l’ha ricevuta comunque, così come ha accettato il vertice Biden-Putin di Ginevra, sebbene il presidente statunitense avesse insultato l’omologo russo in televisione.
Non è trapelato niente delle riunioni a porte chiuse con il governo russo, ma è molto probabile che Nuland per l’ennesima volta abbia minacciato la Russia, visto che lo fa da vent’anni. Il ministro degli Esteri russo, Sergueï Lavrov, ha comunque confermato che la sottosegretaria USA non è pronta a sostenere l’applicazione dell’Accordo di Minsk per risolvere la crisi ucraina.
Da Mosca Nuland si è recata a Beirut per incontrare il nuovo governo di Najib Mikati, poi a Londra per suonare l’allarme, annunciando che Mosca stava ammassando truppe alla frontiera ucraina e s’apprestava a invadere il Paese.
Tre settimane dopo, il direttore della CIA, William Burns, si precipitava a Mosca per aggiustare quel che Nuland aveva mandato in frantumi: si è sforzato di essere conciliante ed è stato ricevuto dal presidente Putin in persona.
Ora però Washington ha smesso di fare il bello e il cattivo tempo. Dopo aver realizzato le prime quattro fasi: 1. armato l’Ucraina; 2. sostenuto gli jihadisti in Siria; 3. tentato di cambiare regime in Bielorussia [5]; 4. sfruttato le tensioni nel Caucaso del sud con l’attacco dell’Azerbaijan all’Armenia [6]; ora tenta di ridimensionare l’influenza di Mosca in Kazakistan – fase 5 – e successivamente dovrebbe misurarsi con la Russia in Transnistria – fase 6. In poche parole gli Stati Uniti mettono in pratica il piano della RAND Corporation.

KAZAKISTAN
Nella cultura dell’Asia centrale il capo è una specie di Kublai Khan e i membri della sua famiglia sono dei privilegiati. Il Kazakistan è nazione da pochi decenni. Lo deve al presidente Nursultan Nazerbayev, che ha saputo federare le diverse tribù. Il successore Kassym-Jomart Tokayev ha democratizzato il Paese, ma la condotta della popolazione continua a essere influenzata dalla cultura turco-mongola.
Il 2 gennaio 2022 manifestazioni contro il rialzo del 13% del prezzo del gas si sono trasformate in rivolta. Gruppi coordinati hanno attaccato edifici pubblici e spesso attività commerciali. Appostati sui tetti, dei cecchini hanno sparato sia sui manifestanti sia sulla polizia. Armerie militari sono state attaccate. Il bottino è stato distribuito ai componenti dei gruppi assalitori. Lo stesso è accaduto un po’ ovunque nel Paese. A Taldykorgan è stata attaccata anche la prigione dove sono rinchiusi degli islamisti.
L’operazione è opera di jihadisti che hanno combattuto in Siria, nonché di ex collaboratori della CIA afghani. Comandano gruppi formati da islamisti kazaki.
Il presidente Tokayev ha riconosciuto la legittimità delle manifestazioni e represso gli attacchi dei terroristi. Ha proclamato lo stato d‘assedio e fatto arrestare il presidente del Consiglio di Sicurezza, Karim Masimov, ex banchiere che fu due volte primo ministro, nonché capo dell’ufficio esecutivo del presidente. È accusato di alto tradimento. Tokayev dopo aver nominato il successore ha riunito il Consiglio di Sicurezza.
I rapporti ufficiali stimano in 20 mila circa il numero degli insorti, formati sia da jihadisti e rivoltosi stranieri sia da islamisti kazaki. Da anni, molto prima del piano Kushner di normalizzazione, il Paese era in rapporti cordiali con Israele. L’ex presidente Nazerbayev, che durante il periodo sovietico aveva assunto posizioni antireligiose, si è in seguito convertito e ha compiuto il pellegrinaggio alla Mecca. Le Chiese sono autorizzate, purché si registrino. Ogni anno si tiene un incontro inter-religioso, assimilabile a quello che il Vaticano organizza ad Assisi.
Il Kazakistan distingue le religioni, senza eccezioni, dall’islam politico, che è invece vietato. La Confraternita dei Fratelli Mussulmani e lo Hizb ut-Tahrir (Partito della Liberazione) si sono tuttavia sviluppati nell’intera l’Asia centrale con l’aiuto dell’MI6 britannico. Del resto, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai è nata per combattere questo separatismo.
Il Consiglio di Sicurezza kazako ha trasmesso al Cremlino gli elementi posseduti sul complotto di cui è vittima il Paese. Ha chiesto l’aiuto dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) per combattere gli jihadisti. Il presidente Tokayev ha subito ordinato alle forze di sicurezza di sparare a vista e di uccidere gli jihadisti intercettati [7].
Il CSTO ha immediatamente risposto inviando 2.500 soldati armeni, bielorussi, russi e tagiki agli ordini del generale Andrei Serdyukov, comandante in capo dei paracadutisti della Federazione di Russia. La Cina Popolare ha annunciato di essere pronta a intervenire in caso di bisogno.
La Turchia ha manifestato il proprio sostegno al presidente Tokayev, facendo così sapere di non essere implicata nel complotto jihadista. Senza sorpresa l’Afghanistan ha fatto altrettanto: parte dei talebani sono infatti deobandi e, del resto, gli afghani che partecipano all’attacco jihadista in Kazakistan sono ex collaboratori della CIA fuggiti dal Paese [8].
Rapidamente si apprendeva altresì che la National Endowment for Democracy [9], di cui Nuland è un’ex amministratrice, dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca ha speso milioni di dollari per «estendere la democrazia» in Kazakistan.

In passato, l’ex ministro dell’Energia, l’oligarca Mukhtar Ablyazov, insieme al genero del presidente Nzerbayev, Rakhat Aliyev, ha fondato un partito d’opposizione (non riconosciuto): Scelta Democratica del Kazakistan (QDT). Insieme hanno tentato di rovesciare Nzerbayev, aiutati da George Soros. Aliyev è morto nel 2015 in prigione in Austria, Ablyazov è andato invece in esilio, prima nel Regno Unito, poi in Francia. Arrestato diverse volte in Unione Europea per omicidio commesso in Russia, non è mai stato estradato. Ha ottenuto asilo politico in Francia e da un anno risiede a Parigi. Sin dal primo giorno di rivolta Ablyazov ha lanciato un appello per rovesciare il regime, ossia per liberarsi non soltanto del presidente in carica Tokayev, ma anche dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev, ufficialmente ritiratosi dalla vita pubblica ma che continua a esercitare molta influenza.
Secondo alcune fonti non confermate, Ablayazov sarebbe in collegamento con il nipote del presidente Nazerbayev, Samat Abish, ex vicedirettore dei servizi segreti. Costui sarebbe stato arrestato il 7 gennaio per alto tradimento. È notoriamente un militante dell’islam politico, come il padre, che ha fatto edificare una gigantesca moschea ad Almaty.
L’ex presidente Nursultan Nazerbayev è rientrato nella capitale. Salute permettendo, potrebbe prendere in mano la situazione, aiutato soprattutto dalla figlia, Dariga Nazarbayeva.

TRANSNISTRIA
Secondo il piano della RAND, dopo il Kazakistan sarà il turno della Transnistria.
Gli Stati Uniti hanno mobilitato l’Unione Europea per decretare un blocco economico della Transnistria, Stato non riconosciuto, la cui popolazione al momento della dissoluzione dell’Unione Sovietica si è separata per referendum dalla Moldavia. I funzionari della Missione d’assistenza dell’Unione Europea alle frontiere della Moldavia e dell’Ucraina (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine – EUBAM), sotto la direzione di Stefano Sannino (ex rappresentante dell’OSCE in Serbia), coordinano le dogane di Moldavia e Ucraina (Paesi che non sono membri della UE) per procedere dal 1° gennaio 2022 al blocco del Paese. La Russia sarà costretta a sistemare l’ex base spaziale sovietica e istituire un ponte aereo per nutrire i 500 mila abitanti dell’enclave.

I cittadini dell’Unione Europea l’hanno dimenticato, ma nel 1992 gli Stati Uniti tentarono invano di schiacciare militarmente la Transnistria (oggi Repubblica Moldava del Dnestr) utilizzando un esercito reclutato nelle prigioni rumene [10]. Il coraggio di questa popolazione fedele al modello dei Soviet, in particolare delle donne, ha fatto fallire il progetto della CIA.
Segnaliamo en passant che, seppure la popolazione della Transnistria parli russo, tre villaggi continuano a parlare francese. Gli abitanti sono discendenti dei soldati della vecchia guardia napoleonica che durante la campagna di Russia lì si sposarono e vi si stabilirono.
- In conclusione, se la risposta di Washington alla proposta di Trattato di Mosca per garantire la pace è ufficialmente un arresto dell’espansione a oriente, ufficiosamente è la conferma che Washington è sempre in grado di nuocere.
[1] “Draft Treaty betweeen the USA and Russia on Security Guarantees”, Voltaire Network, 17 December 2021.
[2] Extending Russia: Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.
[3] «U.S., Russia lift targeted sanctions to allow Nuland visit – Moscow», Elizabeth Frantz, Reuters, Octobrer 10, 2021.
[4] «Pinning Down Putin», Victoria Nuland, Foreign Affairs Vol. 99 #4, July 2020.
[5] “Chi vuole rovesciare il presidente Lukashenko?”, di Thierry Meyssan, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 1 settembre 2020.
[6] “Alto-Karabakh: la vittoria di Londra e Ankara, la disfatta di Soros e degli armeni”, di Thierry Meyssan, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 24 novembre 2020.
[7] “Analisi militare degli attacchi contro il Kazakistan”, di Valentin Vasilescu, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 11 gennaio 2022.
[8] “Sette menzogne sull’Afghanistan”, di Thierry Meyssan, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 19 agosto 2021.
[9] “NED, vetrina legale della CIA”, di Thierry Meyssan, Traduzione Alessandro Lattanzio, Оdnako (Russia) , Rete Voltaire, 8 ottobre 2010.
[10] « En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17 juillet 2007.
La task force Takuba tra forze speciali italiane e i russi della Wagner
La task force Takuba è un raggruppamento militare europeo presente tra il Mali e il Ciad che opera dal marzo 2020 sotto il comando dell’Operazione Barkhane ed è attualmente composta da due gruppi di forze speciali franco-estoni e franco-ceche, un distaccamento di soldati svedesi, uno di danesi (entro gennaio), uno di lituani, e da personale italiano, arrivato a Gao il 12 marzo scorso.
Il contingente italiano, il più numeroso dopo quello francese (si stima siano impiegati tra i 200 e i 250 operatori), risulta essere praticamente già operativo: la piena capacità operativa (Foc – Full Operational Capability) del nostro distaccamento sarà dichiarata nei prossimi giorni. La composizione esatta del contingente italiano è sconosciuta, ma sappiamo che vengono utilizzati distaccamenti di forze speciali e, tra gli altri mezzi, elicotteri da trasporto CH-47 ed elicotteri d’attacco A-129 Mangusta. A questo risulta, presto task force Takuba vedrà l’arrivo anche di un gruppo di soldati rumeni e ungheresi.
Sarebbero una cinquantina i rumeni arriveranno “nei prossimi giorni” a Ménaka, tra cui circa venti appartenenti alle forze speciali, mentre a marzo toccherà all’Ungheria entrare nel sistema: sono attesi quasi un centinaio di soldati, sempre a Ménaka. Il parlamento ungherese ha approvato lo scorso novembre l’invio di un contingente in Mali fino al 31 dicembre 2023.
L’Italia è attivamente coinvolta nel tentativo di stabilizzazione e contrasto al terrorismo della regione subsahariana. Roma partecipa alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misn), alla missione di stabilizzazione integrata delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), alla missione Eucap Sahel “Niger” e “Mali” e alla Eutm Mali nonché alla Coalizione per il Sahel, annunciata al vertice di Pau del G5 Sahel nel gennaio 2020.
La missione in Sahel viene considerata prioritaria dal governo italiano, in quanto da quel settore provengono le principali minacce terroristiche per il fronte sud europeo ed è cruciale per le crisi migratorie, inoltre essere presenti in Mali e in Ciad insieme ai partner europei significa stabilizzare una regione che rientra nella sfera del Mediterraneo Allargato.
A riprova di quest’importanza, il ministro degli Esteri Luigi di Maio aveva fatto visita a Bamako ad aprile del 2021, seguito il mese successivo dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che aveva passato in rassegna anche le nostre truppe ivi schierate.
Tuttavia, questo dispiegamento potrebbe essere compromesso se, per caso, il governo di transizione maliano, retto da militari che sono stati all’origine di due colpi di Stato, raggiungesse un accordo con la compagnia militare privata (Pmc) russa Wagner per formare le forze di sicurezza locali e garantire la protezione delle alte personalità del Paese.
La Francia molto di recente ha già avvertito che l’uso di mercenari russi sarebbe incompatibile con il mantenimento della sua presenza militare in Mali. Per il momento, e nonostante l’avvertimento rivoltogli dalla Comunità Economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas), il governo di transizione maliano non intende ricevere una linea per la sua condotta, sostenendo che non consentirebbe a nessuno Stato “di decidere a quali partner rivolgersi o meno”. In particolare il primo ministro maliano Choguel Kokalla Maiga ha fatto sapere che “ci sono partner che hanno deciso di lasciare il Mali per ripiegare su altri Paesi, ci sono aree che sono state abbandonate”, riferendosi all’annunciata evoluzione del sistema militare francese nel Sahel.
A giugno, infatti, il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la fine dell’operazione Barkhane. Dalla fine del 2021 il sistema francese farà affidamento sul distaccamento delle forze speciali “Saber”, con base in Burkina Faso, su Takuba, che continuerà a supportare le forze armate locali, e su risorse dislocate a Niamey in Niger al fine di supportare questi ultimi nelle aree in cui hanno deficit di capacità (aviazione, intelligence, comunicazioni).
Il governo maliano, in una nota del 24 dicembre, ha fatto sapere che, allo stesso titolo della missione Eutm, nel Paese sono presenti degli istruttori russi “nel quadro del rinforzo delle capacità operative delle forze di difesa e sicurezza nazionali”, ricordando anche che il Mali è impegnato in un partenariato bilaterale con la Russia da anni.
Il comunicato ha risposto a quello dell’Eliseo del 23, in cui tutti i partner internazionali impegnati nella missione Takuba hanno condannato fermamente il dispiegamento di truppe mercenarie sul territorio maliano.
“Truppe mercenarie” che, nel frattempo, sono arrivate e si sono schierate: sappiamo che i primi elementi della Wagner hanno preso possesso della base di Timbuctù precedentemente occupata dai francesi sino al 14 dicembre scorso.
La presenza russa in Mali potrebbe essere destabilizzante in quanto la diplomazia è in mano all’Eliseo, che ha usato toni durissimi verso la giunta militare attualmente al potere arrivando a dire che “sta esercitando il potere in modo illegittimo” e che per “salvarsi” si è affidata ai russi della Wagner.
Dal punto di vista pratico, prima di lanciarsi in qualsiasi previsione, bisognerà capire il numero totale di “consiglieri” militari russi ed il loro equipaggiamento, oltre alle regole di ingaggio con le quali opereranno. Qualora dovessero essere impiegati in vere e proprie operazioni, come i componenti della task force Takuba, potrebbero esserci episodi “spiacevoli” se mancherà un coordinamento tra i due gruppi. Coordinamento che difficilmente ci sarà.
FONTE: https://it.insideover.com/guerra/la-task-force-takuba-tra-forze-speciali-italiane-e-i-russi-della-wagner.html
CULTURA
Negatività, totalità e nuove forme della critica
di Giorgio Cesarale
 Il Novecento ha voluto realizzare l’idea, ha detto Alain Badiou, ma per realizzarla, si potrebbe aggiungere, ha anzitutto provato a cambiarla.1 Esso è stato infatti un secolo rivoluzionario non solo dal punto di vista sociale e politico o da quello artistico e scientifico, ma anche da quello filosofico. Forme, contenuti, risultati dell’impresa filosofica moderna sono rimasti “spiazzati” da un discorso nuovo, caratterizzato dalla radicale ricombinazione dei materiali consegnati dalla tradizione. Se si dà infatti uno sguardo alla costellazione filosofica del Novecento, dall’ermeneutica alla fenomenologia passando per il pragmatismo e la filosofia analitica, ci si accorge che ciascuna di queste correnti ha inteso effettuare una svolta, capace di proiettare la filosofia fuori da una situazione considerata ormai priva di sbocchi, di ogni autonoma possibilità rigeneratrice. Sennonché, dire “filosofia moderna” significa anche dire, come è noto, “critica”. A quale destino si è perciò dovuta sottoporre la critica, tipico manufatto del pensiero europeo sette-ottocentesco, entro il contesto filosofico novecentesco? È una domanda cruciale, per l’insieme delle implicazioni che reca con sé, e non è perciò un caso che attorno a essa si sia venuta componendo una vasta e articolata riflessione. A tal proposito, la nostra convinzione è che, malgrado le sue difficoltà, tale riflessione debba proseguire, sebbene si tratti di volgerla verso margini inesplorati, o non esplorati con sufficiente energia, come sta peraltro accadendo nel dibattito che su questo tema si sta svolgendo sulle colonne dell’«Ospite ingrato». Le notazioni che seguiranno cercheranno di conferire a questa convinzione un profilo più preciso.
Il Novecento ha voluto realizzare l’idea, ha detto Alain Badiou, ma per realizzarla, si potrebbe aggiungere, ha anzitutto provato a cambiarla.1 Esso è stato infatti un secolo rivoluzionario non solo dal punto di vista sociale e politico o da quello artistico e scientifico, ma anche da quello filosofico. Forme, contenuti, risultati dell’impresa filosofica moderna sono rimasti “spiazzati” da un discorso nuovo, caratterizzato dalla radicale ricombinazione dei materiali consegnati dalla tradizione. Se si dà infatti uno sguardo alla costellazione filosofica del Novecento, dall’ermeneutica alla fenomenologia passando per il pragmatismo e la filosofia analitica, ci si accorge che ciascuna di queste correnti ha inteso effettuare una svolta, capace di proiettare la filosofia fuori da una situazione considerata ormai priva di sbocchi, di ogni autonoma possibilità rigeneratrice. Sennonché, dire “filosofia moderna” significa anche dire, come è noto, “critica”. A quale destino si è perciò dovuta sottoporre la critica, tipico manufatto del pensiero europeo sette-ottocentesco, entro il contesto filosofico novecentesco? È una domanda cruciale, per l’insieme delle implicazioni che reca con sé, e non è perciò un caso che attorno a essa si sia venuta componendo una vasta e articolata riflessione. A tal proposito, la nostra convinzione è che, malgrado le sue difficoltà, tale riflessione debba proseguire, sebbene si tratti di volgerla verso margini inesplorati, o non esplorati con sufficiente energia, come sta peraltro accadendo nel dibattito che su questo tema si sta svolgendo sulle colonne dell’«Ospite ingrato». Le notazioni che seguiranno cercheranno di conferire a questa convinzione un profilo più preciso.
I. Critica immanente e negazione determinata
La tesi da cui vorremmo muovere, benché a essa si congiunga inizialmente un certo grado di forse inevitabile schematicità, è che il Novecento filosofico, anziché comprimere il discorso della critica, lo abbia piuttosto riarticolato e pluralizzato. Qual era infatti il modello vincente di “critica” con cui il pensiero filosofico si è dovuto misurare alla fine dell’Ottocento? Tale modello, prefigurato nelle opere di Hegel e Marx e incarnato da un soggetto sociale ben preciso e politicamente in ascesa, la classe operaia, era quello che abitualmente viene chiamato «critica immanente». Le caratteristiche fondamentali, generali, di questo modello sono quattro:
- la differenza fra nocciolo razionale di una realtà e suo guscio esteriore, per dirla in termini marxiani, o fra concetto e Verwirklichung, fra essenza e fenomeno, per dirla in termini più hegeliani e allo stesso tempo più vicini a certe espressioni della Scuola di Francoforte (Marcuse, Krahl);
- la differenza fra l’astratto e il concreto, fra ciò che è povero di determinazioni, e che in quanto tale “soffre” per la sua unilateralità e limitatezza, e ciò che è sintesi di molte determinazioni e perciò ricolloca in sé il motivo del suo esserci;
- l’idea che le condizioni della critica siano date all’interno dell’oggetto criticato, nella misura in cui esso è autonegativo, contraddittorio con sé. Il rovesciamento dei caratteri dell’oggetto non è dunque compito del suo osservatore, ma dell’oggetto stesso;
- l’unità fra teoria e prassi, detta in termini marxisti, o fra idea del vero e idea del bene, espressa in termini più hegeliani.
A tali requisiti della «critica immanente» si connettono tre ulteriori determinazioni. Ci riferiamo, in primo luogo, a ciò che il primo Lukács ha chiamato «il punto di vista della totalità»;2 in secondo luogo, all’assunzione della storicità come contrassegno dell’oggetto della critica così come del soggetto che, partecipandone, ne riflette gli svolgimenti; in terzo luogo, alla questione delle potenzialità utopiche custodite nel presente. Se infatti, per quanto riguarda il punto di vista della totalità, si afferma che la coscienza è immanente all’oggetto, e cioè che ciò che Hegel nella Filosofia del diritto avrebbe chiamato «il soggettivo»3 è sempre immanente allo spirito oggettivo, allora sarà inevitabile concluderne che il rinvio alla totalità – a qualcosa che sopravanza la soggettività pur includendola – è dimensione costitutiva della «critica immanente». Lungo la medesima direttrice bisogna procedere a proposito della storicità: se l’oggetto è scisso al proprio interno fra essenza e fenomeno, e il rapporto fra questi momenti non è di semplice identità, allora esso sarà percorso da una tensione, la cui forma di manifestazione è la storia. Entro questa storia, infine, l’utopico – l’aspirazione a realizzare un’«associazione di uomini liberi, in cui ciascuno ha la medesima possibilità di dispiegarsi»4 – può vivere nelle pieghe del presente solo perché quest’ultimo è fratto, dilaniato dalla lotta fra la razionalità della sua essenza e l’irrazionalità dei dispositivi di potere che ne impediscono lo sboccio.
Tuttavia, con ciò siamo giunti a uno stadio di elaborazione ancora inferiore, per grado di astrazione, rispetto a quello cui vorremmo approdare. La nostra impressione, infatti, è che il complesso delle caratteristiche della «critica immanente» che abbiamo fi qui enumerato sia descritto da ciò che Hegel ha chiamato, nell’“Introduzione” alla Fenomenologia dello spirito, «negazione determinata».5 Quest’ultima è una forma di negazione che – a differenza tanto della negazione proposizionale, che elimina il contenuto negato, quanto della negazione metafi a, che ha come risultato l’assenza di determinazioni6 – distilla un nuovo contenuto a partire dal rivolgimento interno all’oggetto. Ora, se si fi sa l’immagine di tale forma di negazione non è diffi intravedervi i lineamenti principali della «critica immanente». In tanto, infatti, la negazione determinata può essere, in quanto in essa 1) si esplicita la contraddizione fra l’essenza e le forme fenomeniche dell’oggetto; 2) si attingono ogni volta nuovi livelli di concretezza. Se infatti l’oggetto 1) non fosse abitato dalla diseguaglianza fra contenuto noetico e complesso delle manifestazioni ricavabili non si potrebbe produrre una diversa configurazione dell’oggetto stesso, data ogni volta dalla nuova connessione fra il primo e le seconde; ma 2) appena l’oggetto accoglie la negazione delle sue configurazioni precedenti esso diventa più concreto. Tuttavia, anche l’unità fra teoria e prassi, il quarto “criterio” della critica immanente, si costituisce nelle forme della negazione determinata. Se infatti la conoscenza è, secondo la concezione classica, già avanzata da Platone del Teeteto, «opinione vera giustifi ta», vale a dire un’opinione che acquisisce verità nella misura in cui corrisponde al mondo nella sua oggettività data, altra rispetto all’attività conoscitiva stessa, appena quest’ultima dovrà esibire le garanzie dell’unità fra pensiero e oggetto sarà costretta a evidenziare le connessioni dimostrative che la giustifi ano, negando con ciò, anziché conformarvisi, l’oggettività data. Ma negare al mondo esterno il suo au- tonomo valore conoscitivo signifi introdurre l’universalità del concetto nel mondo, signifi dare avvio alla realizzazione di ciò che, prima facie, appare opposto al vero, vale a dire il bene. L’unilateralità della pura attività conoscitiva, della theoria, è con ciò tolta, perché la conoscenza può raggiungere il suo scopo solo se diventa attuazione pratica del concetto, prassi, dunque il bene.
Sono note le vicende storiche che hanno condotto alla messa in crisi o all’indebolimento di questo modello della critica, persino dentro le postazioni che avevano provato a difenderlo. Non importa perciò, in questa sede, ripercorrerle. Più importante è riattraversare le specifiche ragioni teoriche che ne hanno decretato l’indebolimento. Su questo terreno, si può sostenere che per un verso la «negazione determinata» come anima della «critica immanente» è stata respinta perché, come la dialettica che la innerva, è sembrata portare a una chiusura forzosa dell’orizzonte storico, costretto, con l’insieme dei saperi che vi corrispondono, a ospitare solo i cambiamenti previsti nel modello teorico; per altro verso, perché essendo essa, la negazione determinata, dipendente dai rivolgimenti interni all’oggetto la critica immanente ha dovuto comprimere la sua libertà ricostruttiva, la sua capacità di incalzare l’esistente per allinearlo a bisogni e scopi razionali più alti. Se poi nell’oggetto, come è accaduto alla seconda generazione della Scuola di Francoforte (Habermas, Offe), è stata rintracciata una trama contraddittoria sempre più rarefatta e non-antagonistica, incapace di generare le condizioni per la riconfigurazione del suo assetto, affidarsi a tale modello della critica è apparso sempre più problematico. Per salvare la critica dall’estinzione si è ridislocato lo stesso luogo della critica, sbalzandolo fuori dall’immanenza all’oggetto.7
È in forza di tale consapevolezza che la ricerca novecentesca intorno alle forme della critica si è diramata in molteplici direzioni, spesso fra di loro molto distanti. Ciò cui abbiamo assistito è, così, una proliferazione delle forme della critica, in virtù dell’attraversamento di canali per un certo periodo poco battuti (si pensi qui alla massiccia ripresa nell’ultimo scorcio del Novecento dei motivi “normativi”, soprattutto nelle aree filosofiche di lingua inglese e tedesca) e dell’apertura di nuovi fronti (legati all’espansione di quel blocco teorico, particolarmente presente nelle aree filosofiche di lingua francese e italiana, che è variamente ricollegabile all’influenza di Nietzsche e Heidegger). Ne è venuto fuori un quadro eterogeneo, colmo di contaminazioni e formule nuove,8 nel quale sono tuttavia sempre ravvisabili, accanto al modello della critica immanente, di ascendenze “dialettica”, altri due grandi modelli: la critica del razionalismo liberaldemocratico, kantiano e illuminista, e la critica del pensiero negativo.9
Abbiamo appena detto delle difficoltà della critica immanente a tenere il passo con i profondi cambiamenti storici e teorici della seconda metà del Novecento. Ma anche le difficoltà della critica di stampo “normativo” e di quella del pensiero negativo, che avevano invece dominato la scena intellettuale a partire dal ’68, sono diventate negli ultimi anni particolarmente visibili, come avevano già avuto modo di segnalare Luc Boltanski e Ève Chiapello in Il nuovo spirito del capita- lismo. Boltanski e Chiapello, in particolare, rilevavano l’incipiente obsolescenza del paradigma della «critica artistica» al capitalismo, vale a dire la minore produttività contemporanea della critica romantica, variamente ispirata dalle trasformazioni del pensiero negativo.10 Tuttavia, anche la critica “normativa”, di ispirazione kantiana, è costretta oggi a misurarsi con sfide sempre più ardue da governare conservando inalterato il proprio impianto teorico. Sarebbe difficile per esempio ripromettersi oggi di scrivere una teoria normativa della democrazia della portata analoga a quella contenuta in Fatti e norme di Habermas, senza fare seriamente i conti, come purtroppo accade in questo libro, con gli effetti della mondializzazione capitalistica e delle più recenti trasformazioni della forma-Stato.
Ciò non vuol dire però che le critiche mosse al paradigma della critica immanente dal razionalismo normativo e dal pensiero negativo possano essere rapidamente rispedite in archivio. La loro riflessione sulle inadempienze della «negazione determinata», sulle sue chiusure deterministiche e sui suoi cedimenti giustificazionisti, rimane importante. Il paradigma della critica immanente, che oggi peraltro è nuovamente in grado di dispiegare potenti risorse concettuali, come è testimoniato dalla sua riattivazione in vaste zone del pensiero contemporaneo (con Jameson, Postone, Žižek etc.), deve riuscire a farvi fronte.11 Come? La questione va anzitutto affrontata a livello specificamente teoretico. A questo riguardo, la nostra tesi è che tali inadempienze debbano la loro origine alla separazione della «negazione determinata» dal più ampio decorso della hegeliana «riflessione determinante», vale a dire dal più complesso svolgimento di ciò che Hegel, soprattutto nella dottrina dell’essenza della sua Logica, ha chiamato «negatività». Ma che cosa è la negatività nella Logica di Hegel? Soffermiamoci, per capirlo, sullo stesso testo hegeliano.
II. Il concetto di negatività in Hegel
La negatività è la negazione determinata, ma in quanto applicata a se stessa, in quanto autoriferita, esito degli effetti della sua autoriflessione.12 Nella dottrina dell’essenza della Logica, la negatività fa il suo ingresso in corrispondenza del primo grado di sviluppo della riflessione, chiamato «riflessione ponente». La riflessione, anzitutto, è sempre un «ritornare», donde i suoi legami profondi con il «metodo trascendentale»: essa “ritorna”, rimbalza, dalla determinatezza di cui è il più generale correlato, di cui cerca di rispecchiare i caratteri. Ma qual è la determinatezza da cui la riflessione, quando è «ponente», ritorna? Parliamo della «parvenza». Quest’ultima è infatti una qualità che, dei due caratteri che costitutivamente le aderiscono, l’esserci e il non esserci (una qualità è tale perché altro rispetto al resto delle qualità), non sviluppa che il secondo, avendo la crisi della “metafisica”, di cui la dottrina dell’essere ha nel frattempo disegnato il diagramma, sottratto ogni positività, ogni stabile presenza, avrebbe detto Heidegger, alle determinatezze essenti. Ma se la parvenza è una qualità di cui è possibile rilevare solo l’esser per altro, ciò con cui avremo allora a che fare è una «immediatezza riflessa»,13 una determinatezza attingibile solo attraverso la sua negazione.
È in questo punto che la riflessione ponente irrompe: essa “ritorna” dalla parvenza, la inscrive nel suo movimento mediativo. D’altra parte, la parvenza stessa è tale solo in quanto autoriferimento negativo; ne consegue che ciò con cui la riflessione ponente ha a che fare quando si rivolge alla parvenza è di nuovo se stessa. Nella riflessione ponente si ratifica, così, l’avvenuta identificazione fra negatività e determinatezza immediata, fra riflessione e immediatezza. Ma che cosa succede quando la riflessione non ha più un altro con cui relazionarsi? Non avendo altro con cui entrare in relazione, la negatività eserciterà la sua azione solo su se stessa, diventando unità di sé e del suo opposto, del negativo cui essa mette capo negando continuamente se stessa. Tuttavia ciò che, in generale, nega il movimento mediativo è, di nuovo, una determinatezza. La riflessione ponente sarà perciò unità del movimento riflessivo e della determinatezza a esso immanente. Una determinatezza diversa, tuttavia, da quella dell’essere, esteriore e puntiforme, perché “partorita” dalla stessa negatività. È, questa, la specifica forma di determinatezza immediata prodotta dalla dottrina dell’essenza, ciò che Hegel chiama «esser posto».14
La negatività, tuttavia, non trova in questo «esser posto» requie. Deve agire ancora, perché non ha “dimenticato” la sua onnilateralità: se finora, infatti, essa ha negato l’immediatezza, incorporandola, d’ora in poi essa dovrà destituire il suo stesso meccanismo di produzione, dovrà superare lo stesso movimento di superamento della immediatezza. Movimento, lo abbiamo detto poc’anzi, che è posizione del proprio opposto, della determinatezza immediata in quanto esser posto. Ne risulta che la negatività dovrà negare lo stesso movimento di posizione dell’esser posto, dovrà annullare lo stesso meccanismo del «porre». Ma superare il «porre» vuol dire sottrarre a esso, anche solo per un attimo, il processo di determinazione dell’esser posto. La riflessione, dice Hegel, «trova prima di sé un immediato ch’essa sorpassa e dal quale essa costituisce il ritorno».15
Questa negazione del movimento di posizione dell’esser posto è la «riflessione presupponente», con la quale si presenta tuttavia un problema potenzialmente distruttivo: il procedere della negatività è, a questo livello, inarrestabile, con ciò precludendo ogni forma di “stabilizzazione” di sé. Si prospetta una situazione teorica analoga, nella sua improduttività, al divenire della prima triade della Logica, al terribile “cominciamento”, nel quale determinazioni stabili e consistenti con sé si palesano solo allorché il divenire diviene altro da sé, dissolvendosi. Hegel ha avvertito seriamente questo rischio e ha dovuto mettersi seriamente all’opera per allontanarlo. La via d’uscita presentata consiste nella costruzione, complessa e difficile, del passaggio dalla riflessione ponente alla riflessione esteriore.
Il motivo di fondo del passaggio hegeliano si può cogliere appieno solo compiendo una completa rotazione di prospettiva, osservando l’intera vicenda logica non dal lato del movimento mediativo, ma da quello dell’esser posto. Quest’ultimo, dicevamo, è un’immediatezza presupposta alla riflessione che tuttavia si mostra a quest’ultima omogenea sia perché in essa destinata a tramontare sia perché sua proiezione. Ma se così è, se l’esser posto ha acquisito a sé tutte quelle determinazioni che, prima, sembravano appartenere solo alla riflessione, esso diventerà equivalente alla riflessione. Anche l’esser posto non avrà più null’altro al suo fianco, avendo assorbito entro di sé il movimento mediativo. Come tale, come alcunché di autonomo, l’esser posto perderà la spinta a trascorrere in altro, nella riflessione stessa. Ma ciò che è autonomo, in quanto resiste, hegelianamente, al dileguamento, è qualitativamente differenziato; la variazione melodica è finalmente più forte.16
Con la transizione dalla riflessione ponente alla riflessione esteriore, l’esser posto riguadagna, dunque, un più elevato grado di stabilità. È per tale ragione che in questo luogo si affaccia il concetto di «determinazioni della riflessione», le quali si differenziano dalle determinazioni dell’essere, perché mentre quest’ultime, dice Hegel, sono transeunti, semplicemente relative, e che stiano nel riferimento ad altro; […] le determinazioni riflesse hanno la forma dell’essere in sé e per sé; esse si fanno quindi valere come essenziali, e invece di essere trapassanti nelle loro opposte, appaiono anzi come assolute, libere e indifferenti le une rispetto alle altre.17
La riflessione esteriore, tuttavia, con il suo richiamo a una logica qualitativa, impedisce al ciclo della riflessione, della mediazione pura, di compiersi. È con l’avvento della terza parte della riflessione, la riflessione determinante, che questo blocco della riflessione, questo cortocircuito fra riflessione e determinatezza, appare chiaramente. Anche il fare, dice Hegel a questo riguardo, della riflessione esteriore è un fare della riflessione überhaupt: essa però è un fare che pone un immediato come esteriore, che si sdoppia fra l’inaggirabile esplicarsi della mediazione e il momento appena maturato di esteriorità “qualitativa”. E, a questo proposito, Hegel aggiunge: la riflessione esteriore «diventando determinante, pone un altro, l’essenza, al posto dell’essere superato; il porre pone la sua determinazione non al posto di un altro; esso non ha presupposto».18
Il linguaggio filosofico hegeliano è irto di difficoltà, ma il messaggio che vi è depositato può essere in ogni caso appreso: mentre la riflessione ponente si muove all’interno di sé, riproducendo, “tautologicamente”, se stessa, la riflessione esteriore compie una “reale” mediazione perché sostituisce la originaria determinatezza “qualitativa” con l’essenza, e cioè con il movimento riflessivo stesso. Essa muove dalla determinatezza “qualitativa”, ma in seguito scopre che questo riflettere sul suo punto di partenza non è che il fare della riflessione stessa. Si attua una negazione concreta: il ritorno della riflessione nega, infatti, il dominio della determinatezza “qualitativa”. E poiché nel pensiero critico di derivazione dialettica non solo omnis determinatio est nega- tio, ma ancora di più, omnis negatio est determinatio, ogni negazione è sempre determinazione, questa scansione concettuale è chiamata «riflessione determinante».19
III. Negatività e critica
Con il passaggio dalla riflessione esteriore alla riflessione determinante appare un momento decisivo per tutte quelle prospettive critiche, di tipo, lato sensu, “trascendentale”, che hanno voluto scavare un più profondo solco fra l’ideale e il reale: la negatività o riflessione, se vuole essere fedele al suo fondamentale obiettivo di mediazione, non può
incontrarsi con una determinatezza a sé già del tutto omogenea. Reale mediazione, reale negatività, si hanno solo quando la determinatezza altra è davvero tale. Per inciso, questo è il motivo per cui l’«esser posto», in quanto determinatezza immediatamente risolvibile nella riflessione, non può adeguatamente rappresentare il concetto di riflessione. Essendo integralmente penetrato dalla negatività, l’esser posto non può sollecitare nessuna attività da parte di essa. Ma è decisivo anche quanto Hegel sostiene a proposito della negatività pura dispiegatasi con la riflessione ponente. Se l’attività negatrice, dunque critica, assorbe tutto all’interno di se stessa, allora essa sarà costretta negare anche se stessa, e quindi a porsi come qualcosa di presupposto. Essa cioè si negherà in quanto attività, trasformandosi nel suo opposto, in una nuova determinatezza, priva nondimeno di quella mobilità e di quella dinamicità che sembrava possedere nella precedente configurazione.
Nel rilevare il destino “nichilistico” della negatività pura Hegel compie, a nostro avviso, un gesto oltremodo significativo, che depotenzia ante litteram il dispositivo del pensiero negativo. Quando una delle fonti di questa tradizione, Heidegger, sostiene infatti che «la distinzione di essere ed ente è il fondamento ignoto e infondato, eppure ovunque reclamato, di ogni metafisica»,20 si sta riferendo al fatto che – fin dal Talete che «alla domanda su che cosa sia ciò che è (das Seien- de) risponde: è acqua, [spiegando] qui ciò che è a partire da un ente (das Seiende aus einem Seienden), pur cercando in fondo che cosa è l’ente in quanto essente (das Seiende als Seiendes)»21 –, la metafisica ha obliterato il fondamento della differenza fra essere ed ente, e dunque la circostanza per cui l’essere di cui pure la metafisica va in cerca non è una realtà ontica, pur tentando ogni volta di identificarlo con quest’ultima. La negatività è insomma il fondamento originario, obliato, ma sempre ricercato e malamente oggettivato, della metafisica. Al contrario, per il pensiero dialetticamente critico la negatività è sempre qualcosa di secondo, una ulteriorità, come abbiamo potuto constatare delineando prima i tratti della riflessione ponente, la quale sorge sulla base della corrosione dell’ultimo resto della dottrina dell’essere, la parvenza, e introducendo poi alla figura delle determinazioni della riflessione, le quali presuppongono il darsi positivo dell’essere. Con ciò Hegel non solo anticipa lo Adorno della Metacritica della teoria della conoscenza e della Dialettica negativa, critico sferzante del mito del Primo e dell’Originario, ma mette sotto scacco anche ogni tentativo di costruire una filosofia della riflessione intesa come filosofia della pura correlazione fra riflessione e determinatezza, fra pensiero e essere.22 L’anteriorità della determinatezza rispetto alla riflessione negativa è hegelianamente cruciale, come in un certo senso aveva intuito il Lukács di Il giovane Hegel e dell’Ontologia dell’essere sociale, particolarmente interessato a valorizzare i momenti “materialistici” del pensiero critico-dialettico.
Meditando sull’anteriorità del positivamente discreto sul processo di mediazione riflessiva ci procuriamo, tuttavia, anche i mezzi per ripensare la relazione della negatività con la negazione determinata, alla natura della quale abbiamo dedicato le nostre prime note. Se la negazione determinata è, anzitutto, negazione che produce un mutamento nell’oggetto, mentre fa apparire la differenza fra il nucleo essenziale della cosa e il suo fenomeno, quanto abbiamo appena detto sul potere “corrosivo” della essenza rispetto alla determinatezza conferma, potenziandola, tale capacità della negazione determinata, così come la contraddizione fra essenza e fenomeno che la rende possibile. Persino l’unità fra teoria e prassi, la trasformazione dell’oggetto nella misura in cui la theoria stessa si trasforma, è rappresentata nel passaggio dalla riflessione esteriore alla riflessione determinante, giacché la prima può “passare” nella seconda solo perché traduce il contenuto concettuale nel mondo.
Ma allora, cercando di ricapitolare il ragionamento, dove risiede da ultimo la superiorità teorica della negatività o negatio duplex sulla negazione determinata o negazione prima? La superiorità sta nel fatto che essendo la negatività negazione autoriflessa, negazione autoriferita, sottoposta fin da subito ai tormenti dell’autocontraddizione, essa ha, oltre che uno statuto critico, anche uno statuto autocritico. Essa corrode la datità e l’oggettività irriflessa corrodendo allo stesso tempo se stessa. Ha cioè una intenzionalità critica nei confronti sia di ciò che la vecchia teoria critica avrebbe chiamato “positivismo” sia nei confronti di una trascendentalità e di una normatività che si pongano come costituenti e non mai come qualcosa di costituito, storicamente costituito. La negatività è cioè una trascendentalità che si fa ragione storica, capace di porre le forme mentre le fa inerire ai contenuti e così ritornare su di sé. Filosoficamente, è questo il passaggio che più fortemente manca nelle posizioni trascendentaliste contemporanee, anche in quelle più sofisticate. Si esamini, a questo riguardo, la prospettiva di Karl-Otto Apel: se è suo incontestabile merito aver concepito la comunità ideale e illimitata di comunicazione a muovere dal carattere autoconfutativo di ogni posizione che rivendichi validità pur sottraendosi alla discussione, a muovere cioè dalla negazione determinata di tutte le istanze soggettive parziali e difettose – con ciò avvalorando la necessità di un atto che “ritorni” in sé dalle parziali determinatezze, chiamato, non a caso, «riflessione trascendentale» –, egli non è però giunto ad assegnare allo stesso standard di valutazione un carattere autocritico, autonegativo, storicamente tale. In Apel, la negazione determinata non diventa mai negatività.
Ma come si confronta una filosofia della negatività con i rimproveri di determinismo e debole impulso correttivo che sono stati tradizionalmente indirizzati, lo dicevamo sopra, a una critica impostata sul modulo della negazione determinata? Per un certo verso, la necessità della negatività è rigorosissima: essa porta fino alle estreme conseguenze il meccanismo autonegativo; per altro verso, questa necessità è quella che la consegna al suo stesso annullamento, all’assoggettamento a ciò che è a essa radicalmente altro, vale a dire il primato della determinatezza discreta ed esteriore.23 Né il debole impulso correttivo della negazione determinata trova, crediamo, continuazione nel procedere della negatività: con la separazione della riflessione ponente da quella presupponente e con il nesso fra riflessione esteriore e riflessione determinante ciò che si viene articolando è un’autonomia della funzione critica, non inferiore a quella rivendicata dalle vaste legioni dei pensatori neokantiani contemporanei.24 Solo che, come capita spesso, chi si pone sulle orme di Hegel vuole essere molto più conseguente e radicale: la critica che non diventi autocritica non ha forza trasformativa effettiva, è solo un gesto rassicurante e consolatorio rispetto ai nostri già delineati orientamenti di senso.
Note
1 A. Badiou, Il secolo, trad. it. di V. Verdiani, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 53.
2 G. Lukács, Storia e coscienza di classe, trad. it. di G. Piana, Milano, Mondadori, 1973, p. 201.
3 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, trad. it. di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1999, § 25, p. 40.
4 M. Horkheimer, Teoria tradizionale e teoria critica, in Id., Teoria critica, trad. it. di G. Backhaus, Milano, Mimesis, 2014, vol. II, p. 164.
5 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. di E. De Negri, Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 52.
6 C. Iber, Metaphysik Absoluter Relationalität: Eine Studie Zu den Beiden Ersten Kapiteln von Hegels Wesenslogik, Berlin-New York, De Gruyter, 1990, p. 221.
7 W. Privitera, Il luogo della critica. Per leggere Habermas, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996.
8 Federica Gregoratto, in Il doppio volto della comunicazione. Normatività, domi- nio e critica nell’opera di Jürgen Habermas, Milano, Mimesis, 2013, pp. 48-58, enuclea per esempio sei modi della critica (ricostruttiva, costruttivista, interpretativa, dischiudente, genealogica, anti-ideologica).
9 Su questi tre modelli della critica che sono anche tre diversi modi della sinistra politica cfr. C. Galli, Sinistra, Milano, Mondadori, 2011, cap. I e G. Cesarale, Una nuo- va stagione per la teoria critica e per la sinistra?, in «Etica & Politica», 22, 2020, pp. 639-648.
10 L. Boltanski, È. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, ed. it. a cura di M. Guareschi, Milano, Mimesis, 2014, pp. 469-471. Il legame fra negatività, attitudine romantica e critica è splendidamente delineato da W. Benjamin, Il concetto di critica d’arte nel romanticismo, ed. it. a cura di N.P. Cangini, Milano, Mimesis, 2017.
11 Ne ho parlato in G. Cesarale, A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989, Roma-Bari, Laterza, 2019.
12 Riassumo in questo paragrafo quanto contenuto in G. Cesarale, La mediazione che sparisce. La società civile in Hegel, Roma, Carocci, 2009, pp. 96-103.
13 G.W.F. Hegel, Scienza della logica, trad. it. di A. Moni rivista da C. Cesa, Roma-Bari, Laterza, vol. 2, p. 439.
14 Ivi, vol. 2, p. 447.
15 Ivi, vol. 2, p. 446.
16 Vincenzo Vitiello argomenta la sua proposta «topologica», che dovrebbe consentire la coappartenenza di ordine strutturale e temporalità plurime e sincroniche, enfatizzando la rottura fra «riflessione ponente» e «riflessione esterna» (V. Vitiello, Vincenzo Vitiello, in Storia della filosofia. Filosofi italiani contemporanei, a cura di D. Antiseri e S. Tagliagambe, Milano, Bompiani, 2010, vol. 14, p. 641). Ma tale rottura, come diciamo nel corpo del testo, non è così grande da impedire la loro relazione.
17 G.W.F. Hegel, Scienza della logica cit., vol. 2, p. 450.
18 Ivi, vol. 2, p. 451.
19 Il discorso sul passaggio dall’«esser posto» alle «determinazioni della riflessione» è a un grado molto alto di astrazione. Ma esso è la premessa diretta per pensare lo statuto delle determinazioni della riflessione di cui fa ampiamente uso la scienza sociale critica. Nessuna teoria della «forma di valore», come quella marxiana del Ca- pitale, sarebbe potuta decollare senza l’ausilio delle determinazioni della riflessione, come confessato dallo stesso Marx.
20 M. Heidegger, Nietzsche, ed. it. a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 2018, p. 705.
21 M. Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenologia, ed. it. a cura di A. Fabris, Genova, il Melangolo, 1990, p. 306.
22 La filosofia della riflessione hegeliana non soffre di “correlazionismo”, come altre correnti del Novecento (la fenomenologia husserliana in particolare). Le critiche che Quentin Meillassoux (in Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità della contin– genza, ed. it. a cura di M. Sandri, Milano, Mimesis, 2012) ha acutamente rivolto al correlazionismo non si applicano perciò a essa.
23 L’assolutizzazione hegeliana della negatività di cui parla giustamente Roberto Finelli nel suo intervento al dibattito non è dunque coincidente con la sua ipostatizzazione, al contrario di quanto Finelli stesso ritiene. L’assolutizzazione della negatività conduce piuttosto al suo “contraccolpo”, al passaggio irruento nella determinazione contrapposta.
24 Autonomia della funzione critica non signifi , sia detto a scanso di equivoci, separatezza del momento “ideale” rispetto a quello “reale”. Che si possa essere critici pur abolendo tale separatezza è precisamente l’obiettivo del discorso qui abbozzato.
FONTE: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/21986-giorgio-cesarale-negativita-totalita-e-nuove-forme-della-critica.html
CYBERWAR SPIONAGGIO INFORMAZIONE DISINFORMAZIONE
Ancora un cavo sottomarino tagliato al largo della Norvegia
Dopo quanto accaduto lo scorso novembre nel mare norvegese, quando una lunga porzione di un sensore sottomarino a cavo del sistema di sorveglianza LoVe (Lofoten-Vesteralen) era stata tagliata e asportata, nella giornata del 7 gennaio veniamo a conoscenza che uno dei due cavi in fibra ottica che collega la Norvegia alle isole Svalbard è stato tranciato.
Come ha riportato il Barents Observer, l’operatore di quello che è il cavo sottomarino in fibra ottica più settentrionale del mondo, Space Norway, ha localizzato l’interruzione tra 130 e 230 chilometri da Longyearbyen, nell’area in cui il fondale marino va da 300 metri fino a 2700 metri nel Mare della Groenlandia.
Lo Svalbard Undersea Cable System è un cavo di comunicazione sottomarino doppio che collega Longyearbyen, nell’arcipelago artico, con Andoya a nord di Harstad, nella Norvegia settentrionale.
I due cavi sono lunghi rispettivamente di 1375 e 1339 chilometri, e Space Norway, l’agenzia spaziale del Paese che gestisce i cavi principalmente a supporto della Svalbard Satellite Station (SvalSat), informa in un comunicato stampa che c’è un buon collegamento nel cavo ancora funzionante.
Come sia avvenuta la rottura non è chiaro, ma è stata aperta un’indagine, come ha informato sia Space Norway sia il governo norvegese in un comunicato stampa ufficiale. La riparazione del cavo avrà bisogno dell’impiego di una nave posacavi d’altura.
Lo Svalbard Undersea Cable System oltre a fornire connessione web all’insediamento umano alle Svalbard, serve il parco antenne SvalSat, che utilizza oltre 100 antenne satellitari su un vicino altopiano montuoso. SvalSat è oggi la più grande stazione di terra commerciale del mondo con clienti in tutto il mondo. La sua particolare posizione geografica, a 78 gradi nord cioè a metà strada tra la Norvegia continentale e il Polo Nord, conferisce alla stazione una posizione unica per fornire supporto agli operatori di satelliti in orbita polare.
Il governo norvegese ha affermato nella nota stampa che la comunicazione da e verso le Svalbard continua a funzionare normalmente, anche se una delle connessioni è saltata.
Quando l’anno scorso sono stati interrotti i cavi che facevano parte dell’osservatorio oceanico LoVe, in alcuni ambienti si è avanzata l’ipotesi che potesse essere coinvolta la Russia, che certamente ha i mezzi per farlo.
La Marina Russa ha infatti in servizio alcuni assetti particolari (i sottomarini/batiscafi Paltus e Losharik) che possono raggiungere elevate profondità e effettuare operazioni di sabotaggio e spionaggio. Il Losharik, in particolare, ha subito un importante incidente a luglio del 2019 in cui hanno trovato la morte 14 marinai mentre il battello era impegnato in non meglio precisati “rilievi batimetrici” nel Mare di Barents, e non sappiamo se sia rientrato in servizio.
Quello che sappiamo è che Losharik e Paltus vengono operati dalla Marina Russa ma sono inquadrati nella 29esima Brigata Autonoma della Flotta del Nord che è a tutti gli effetti dipendente dal Gru (Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie) ovvero il servizio informazioni militari russo.
“Qualcosa o qualcuno ha strappato i cavi nelle aree periferiche”, aveva detto Geir Pedersen, il leader del progetto LoVe in quell’occasione quando circa quattro chilometri di cavi elettrici e in fibra ottica erano stati tagliati e quindi rimossi per essere poi ritrovati a buona distanza dalla sede del cablaggio.
Tornando all’ultimo “incidente”, i cavi hanno anche un valore militare e la stessa stazione satellitare SvalSat, come logico, è un potenziale bersaglio per una missione di spionaggio o sabotaggio. Sebbene le isole Svalbard siano state designate “zona smilitarizzata”, ci sono state indicazioni, anche dalla Russia, che SvalSat sia utilizzata per scaricare dati da satelliti militari oltre che commerciali, quindi in violazione del trattato che definisce l’arcipelago come smilitarizzato.
L’indagine aperta dal governo norvegese probabilmente cercherà anche di identificare eventuali navi o sottomarini che erano attivi nell’area in questione nel momento in cui l’interruzione è stata segnalata per la prima volta. Se una nave è stata coinvolta nella manomissione deliberata del cavo, potrebbe aver operato senza il suo transponder navale attivato (il sistema Ais) oppure falsificandone il segnale. Ciò non significa che la nave sarebbe stata invisibile con qualsiasi mezzo, ma avrebbe potuto svolgere la sua missione più furtivamente.
C’è anche la possibilità che una potenza rivale desideri capire esattamente se i cavi vengono utilizzati per scopi militari , e quindi il danno potrebbe essere il risultato di un’operazione di spionaggio sottomarina per intercettare i dati passanti nei cavi finita male. Bisogna anche considerare che i cavi si trovano in un’area strategica sia per la Norvegia che per la Russia, e come avevamo ventilato nel 2019, in occasione dell’incidente al Losharik, un’operazione di spionaggio, sabotaggio o semplicemente di sorveglianza è molto facile che possa essere stata effettuata.
Gli occhi pertanto sono puntati sulla Russia, un po’ perché, come abbiamo visto, avrebbe la tecnologia sottomarina per effettuare un’operazione di questo tipo, un po’ per via della sua sempre maggiore presenza nell’Artico e per le azioni di disturbo che ha effettuato negli ultimi tempi proprio indirizzate alla Norvegia: il sito specializzato The War Zone ci ricorda che Oslo ha già accusato Mosca di interferire con azioni aggressive nei confronti delle sue reti di sensori e comunicazioni. Nel 2018 infatti il Norwegian Intelligence Service (Nis) ha fatto sapere di almeno tre casi in cui aerei russi hanno condotto esercitazioni di attacco contro una stazione radar segreta nel nord del Paese, mentre nel 2017, la stessa agenzia ha affermato che jamming russo aveva interrotto la telefonia mobile e il segnale Gps durante un’esercitazione militare.
FONTE: https://it.insideover.com/difesa/ancora-un-cavo-sottomarino-tagliato-al-largo-della-norvegia.html
SORVEGLIANZA GENERALE!
di Gianni Lannes
Ecco l’occhio e l’orecchio del grande fratello a spese del contribuente. «Accettazione dei vaccini nella popolazione»: e’ scritto testualmente nella piattaforma dell’Unione europea, varata nel 2019 per il controllo e la sorveglianza dell’ignara gente. Si tratta del progetto denominato European Joint Action on Vaccination (EU-JAV), finanziato dall’European Union’s Health Programme; esso ha come obiettivo il tracciamento di tutte le conversazioni in rete, relative all’argomento vaccinazione. Singolare coincidenza: poco prima dell’esordio targato nuovo coronavirus o covid-19, gli euroburocrati si prendono la briga di predisporre un sistema di spionaggio sociale.
A coordinare l’operazione totalitaria ci sono l’Istituto Superiore di Sanità italiano e l’Istituto finlandese per la Salute e il Welfare. In sostanza l’ISS (sul libro paga di Pig Pharma), in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha lanciato una piattaforma online che raccoglie e visualizza in tempo reale dati sui vaccini provenienti da diverse fonti. Dai social media geolocalizzati Twitter e Reddit; dall’enciclopedia Wikipedia, sempre ai primi posti nei risultati dei motori di ricerca e da Google Trends, uno strumento che riporta il volume delle ricerche degli utenti e che quindi conosce gli interessi di chi si esprime in materia. Attualmente, la commissione europea (il governo Ue, eterodiretto da logge e multinazionali)) è in possesso del più grande archivio digitale di controllo massivo sulle opinioni vaccinali di ogni individuo. L’EU-JAV sa e vede tutto, conosce il tuo pensiero, le tue opinioni, i tuoi amici, i tuoi familiari, sa con chi scrivi e da dove scrivi. Conosce i tuoi interessi e i tuoi desideri e può disporre delle informazioni in maniera incondizionata. La cosiddetta privacy è ampliamente violata con l’unico obiettivo di eliminare il rifiuto della vaccinazione, o meglio, dei sieri sperimentali anticovid-19 e favorire la propaganda dei produttori di sieri magici.
Gli scopi dell’EU-JAV sono da spionaggio antidemocratico: “analisi dei fattori che portano all’esitazione vaccinale, intercettazioni precoci di paure e fake news; sorveglianza degli utenti più coinvolti nella diffusione di disinformazione; mappatura delle comunità coinvolte; intercettazione dei contenuti più condivisi”. La sorveglianza dei cittadini che si interrogano e non credono a tutto è poi accompagnata dal controllo dei pro-vax, considerati fedeli servi: “identificazione degli utenti in grado di diffondere più efficientemente messaggi di promozione delle vaccinazioni e misurazione in tempo reale della portata e dell’efficacia di eventuali campagne di comunicazione”.
Riferimenti:https://eu-jav.com/https://www.epicentro.iss.it/ben/2021/2/conversazioni-vaccini-web-social-networkhttps://phmpt.org/pfizers-documents/https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=pfizerhttps://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=covid
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=ricciardi
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus
Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO. STRATEGIE DEL DOMINIO, Draco edizioni, Modena, 2012.
Gianni Lannes, VACCINI DOMINIO ASSOLUTO, Nexus edizioni, Battaglia Terme, 2017.
Gianni Lannes, VACCINI CAVIE CIVILI E MILITARI, Nexus edizioni, Battaglia Terme, 2018.
FONTE: https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2022/01/sorveglianza-generale.html
DIRITTI UMANI
I cento euro di multa? Non sottovalutateli. Sono una porta spalancata sull’abisso

Necessità della corretta interpretazione di quanto sta accadendo per una giusta resistenza e reazione
di Massimo Viglione
Rabbia e sconcerto, unitamente a una crescente volontà di resistenza e reazione, di non cedimento, aleggiano sempre più nelle anime e nelle parole di milioni di italiani, posti dinanzi alla ufficializzazione dell’obbligo vaccinale controfirmato dall’uscente presidente della Repubblica, come ultimo atto di un settennato di cui porterà per sempre il peso. In realtà, costoro sono ben più di quei due milioni (fonte Televideo) di ultracinquantenni ufficialmente indicati come non vaccinati; perché anche i più giovani iniziano a capire che è solo un caso – o forse una precisa volontà punitiva verso la categoria umana più restia a farsi iniettare un siero sconosciuto nelle vene per un numero indeterminato di volte – se a loro, per ora, non tocca lo stesso obbligo. Cominciano a capire che la vessazione che oggi spetta a una precisa categoria per un determinato motivo, domani, per altri aspetti, potrà toccare a tutti gli altri, e magari con pretese ben più amare e sistemi punitivi ben più gravi degli attuali.
Si stanno insomma radicando sempre più nella popolazione (compresi molti già sierizzati) due consapevolezze ben precise, con la seconda che è conseguenza logica della prima:
1) il siero non solo non serve a tutelare la salute, ma in realtà può rovinarla, fino a essere causa di morte precoce;
2) dinanzi a questa ormai comprovata realtà, chi governa anziché fermare la sierizzazione di massa ricorrendo alle cure alternative che ben funzionano la avalla con il sopruso sanitario (“tachipirina e vigile attesa”), legale e fiscale. Non solo: la vuole ripetere ad libitum e ricorre a sistemi legislativi inusitati (come l’obbligo vaccinale e la relativa multa una tantum) che aprono la porta verso un abisso oscuro.
Quest’ultimo aspetto è, a nostra opinione, il vero punto che ancora sfugge a moltissimi e sul quale vogliamo soffermarci.
Le due consapevolezze sopra citate sono condizione necessaria ma non sufficiente per la comprensione di quanto accade e la propria salvezza personale. Molti, pur arrabbiati e intenzionati a resistere, credono che possano cavarsela pagando cento euro, non pagando affatto o, se sono impossibilitati al lavoro, perdendo quattro mesi di stipendio (e qui già la situazione si fa molto più ardua per chi benestante non è).
In realtà, è assolutamente necessario iniziare a prendere coscienza di un terzo punto fondamentale della tragedia in atto: quello riguardante i princìpi.
Al di là delle delimitazioni d’età, del moderato – per ora – sistema punitivo e quindi dei cento euro, al di là pure della sospensione o della perdita del lavoro, occorre capire che questo governo, creato ed eterodiretto dai poteri nuovomondialisti della finanza sinarchica, ha aperto la porta dell’abisso che condurrà alla velocissima realizzazione dei loro piani, la cui superfice (solo questa) è stata chiaramente espressa nell’agenda 2030 e ancor più chiaramente in tanti discorsi e scritti – sempre più apertamente sbandierati – dei loro esponenti di punta.
Andiamo al sodo, avanzando esempi di azione concreta magari esagerati ma non per questo non possibili (anzi).
Se un governo si arroga il presunto diritto di imporre la somministrazione di un siero genico sperimentale nel corpo dei cittadini, senza un reale pericolo che possa giustificare tale rimedio e, per di più, sapendo di effettuare un’operazione che non solo travalica i confini della propria Costituzione ma è rischiosa per la salute e la vita delle persone, e per di più in presenza di valide alternative non invasive che vengono sistematicamente combattute senza reale motivazione né medica né umana, vuol dire che si è sorpassata la soglia di ogni confine morale, naturale e giuridico di oggettività del bene e del vero.
Stando così le cose, perché questo governo, che oggi impone cento euro di multa una tantum, domani non potrebbe imporre 15 mila euro? E perché dopodomani non potrebbe confiscare la casa ai dissidenti? O, magari, bloccare il loro conto in banca, con la stessa modalità fiscale con cui oggi pretende i cento euro? Una volta accettato il principio, le modalità di applicazione sono del tutto soggettive e temporanee.
Lo stesso concetto di multa una tantum è in sé del tutto inventato ex novo e del tutto illegittimo giuridicamente.
Ma andiamo avanti. Se oggi questo governo nuovomondialista adopera tali illegittime e amorali modalità politiche per il siero genico, perché non potrebbe adoperarle anche per altre motivazioni sociali? Chi impedisce – una volta che è passata nella prassi politica di uno Stato l’idea onnipotenziale del governo di turno “sotto eccezione” (vera, presunta o inventata del tutto che sia questa “eccezione”) – di imporre l’eutanasia ai malati, o a quelli che loro giudicano essere “malati” (magari tramite valutazione da remoto per mezzo di microchip aut similia)? Chi impedisce di togliere i figli minori, magari anche piccolissimi, a quei genitori renitenti all’onnipotenza dello Stato sotto la maschera della “patria in pericolo” di robespierriana memoria, ovvero lo “Stato di eccezione”?
Potremmo continuare a lungo con gli esempi di fantasia, ma non serve: oggi, chiunque sia dotato di un minimo di libero raziocinio e di dignità morale sa perfettamente che questi esempi di fantasia non hanno proprio nulla di fantastico, ma sono ormai obiettivi perfettamente realizzabili e già programmati.
In tal senso, fare le battute – che pur comprendiamo come necessaria valvola di sfogo personale – sull’esiguità dei cento euro, o fare gli ottimisti sul breve futuro di questo governo, non ha nessun senso né utilità pratica. Caduto un governo se ne fa un altro, finché il sistema mondiale che regge il tutto non precipita negli inferi dai quali è salito. E i cento euro di oggi sono la porta di ingresso per l’imposizione dell’eutanasia, o del blocco della carta di credito, o direttamente del contante o del prelievo fisico dei propri figli, di domani.
Chi avalla tutto questo è complice del più mostruoso Leviatano che la storia abbia mai prodotto. Anzi, purtroppo sta solo cominciando a produrre, gettando, per l’appunto, con questi ancora gestibili mezzucci, le basi della follia demoniaca che ci attende e che non sarà più gestibile. Denunciammo tutto questo fin dalla primavera del 2020, fummo accusati di essere “complottisti”, perfino “liberali” e “modernisti”, poi “no-vax”, in futuro magari saremo accusati di essere “no-eutanax” o “no-elettronix” (moneta elettronica) o chissà cos’altro, secondo un meccanismo rivoluzionario sovversivo iniziato nella Germania di Lutero con il termine “papisti” e nella Francia di Robespierre con il termine “contro-rivoluzionari” e poi proseguito ovunque in tante maniere fino a oggi. E a domani. E chi avalla questo sistema è parte integrante di questo sistema e come tale va giudicato.
Dobbiamo anche prendere la dolorosa consapevolezza che in realtà anche tutti noi che teniamo duro e non cediamo abbiamo già ceduto. Magari con una responsabilità crescente di passo in passo, o di persona in persona.
Abbiamo ceduto quando abbiamo accettato di essere reclusi per tre mesi in casa con regole e modalità assurde e totalitarie, che hanno causato la rovina economica di un numero enorme di attività esercenti e famiglie (più notevoli danni psicologici individuali e di massa).
Abbiamo ceduto quando abbiamo accettato di non abbracciarci, di non uscire e mangiare più insieme, di “distanziarci socialmente”, che poi voleva dire umanamente.
Abbiamo ceduto quando abbiamo accettato di farci imporre una mascherina sulla bocca, che ci nasconde il sorriso, ci infetta l’aria che respiriamo e, soprattutto, ci – simbolicamente – impedisce di parlare, ovvero di esercitare la seconda prerogativa dell’uomo come Dio lo ha creato, essere parlante, conseguenza inevitabile della prima, quella di essere un essere pensante, giudicante e amante.
Abbiamo ceduto quando abbiamo accettato di essere divisi in regioni colorate secondo arbitrio e umori di governanti e medici indegni e, con ogni probabilità, non “neutrali” nei loro interessi personali, svendendo così la nostra stessa libertà di movimento e la struttura geopolitica stessa del nostro Stato.
Abbiamo ceduto quando, in base a questi colori tanto totalitari che arbitrari, abbiamo accettato di chiudere negozi e attività commerciali, fino alla rovina e fino alla morte della libertà personale dei cittadini.
Abbiamo ceduto quando siamo ricorsi (e ricorriamo) ai tamponi per avere qualche mese di libertà personale, dimenticando che – al di là magari dell’aspetto specificamente medico (nessuno può negare che occorre avere senso di responsabilità verso il prossimo quando si è vittime del virus; in tal senso, mascherine e tamponi hanno una loro innegabile utilità medica, che pur non toglie però quanto stiamo affermando – questi tamponi ci fanno comunque entrare nel meccanismo di controllo delle nostre persone, che comunque avviene anche con ben altri usuali sistemi (internet e cellulari in primis).
Cederemo oggi se andremo a pagare i cento euro, porta d’ingresso di ben altri pagamenti futuri (che non saranno di cento euro) in ogni settore della nostra vita personale e sociale.
Hanno ceduto tutti coloro che si sono fatti iniettare un siero genico – e sorvoliamo su quello che contiene veramente e sulle sue conseguenze nel presente e in quelle facilmente intuibili nel futuro – per “stare bene” o “potersi muovere” o “guadagnare”: perché si sono già proiettati pienamente nel controllo da remoto prossimo venturo della loro persona, dei loro beni, in parte delle loro anime, tramite “microchip adveniente”, di cui il siero genico, ripetuto ad libitum, è precondizione tecnologica.
Certo, occorre anche tenere presente che siamo in guerra, e quando si è in guerra all’audacia e alla forza occorre alternare, secondo giustizia e buon consiglio, anche l’astuzia, la prudenza, la ritirata, entro certi accettabili confini morali, il compromesso. Altrimenti non saremmo in guerra. Ma non dobbiamo mai perdere di vista né la realtà presente per quella che realmente è (ci fanno guerra) né gli obbiettivi veri da raggiungere o difendere.
Decine di milioni di italiani hanno ceduto (e cederanno) su tutto, moltissimi su molto (e ora cominciano a capire), pochi hanno tenuto e tengono duro, resistono, e un gruppo di questi è anche pronto a reagire. Eppure, non esiste nessuno, ma proprio nessuno, che non abbia ceduto almeno su uno o due punti di questo infernale sistema, perché la trappola sanitaria è la più perfetta, geniale (e in quanto tale) ultima di tutte le trappole della storia della Rivoluzione gnostica. In costoro risiede oggi la speranza della salvezza di un piccolo resto, più o meno come avviene nella Chiesa Cattolica (e spesso vi è coincidenza di persone nei due settori).
Ci attendono giorni in cui dovremo costantemente decidere la nostra strategia e la nostra tattica per rimanere uomini veri e liberi. Ogni giorno, e non è detto che, in certi specifici casi, i criteri siano sempre identici per tutti.
In conclusione, il nostro invito è rivolto a questo piccolo resto – oggi composto da persone delle più svariate provenienze ideologiche, come d’altronde accade anche nel campo avverso – e consiste nel non cadere nella trappola della “porta d’ingresso”, ovvero del facile entusiasmo per una per ora ancora gestibile reazione di resistenza al tiranno: ciò che oggi è gestibile è, appunto, solo la porta d’ingresso di ciò che domano sarà l’inferno in terra.
Occorre invece cercare immediatamente la porta d’uscita, ovvero tornare a pensare, anche proprio ai fini di una vera, incisiva e corretta reazione di popolo, sul piano dei grandi princìpi, e non su quello dei mezzucci (“io speriamo che me la cavo”) hic et nunc; sebbene occorra ammettere che anche questo aspetto ha una sua ragione d’essere immediata, legata alla necessaria sopravvivenza quotidiana e alla libertà personale di agire. Ma solo una legittima resistenza e reazione basata sui grandi princìpi filosofici, morali, naturali, giuridici può poi permettere una reale resistenza e reazione anche sul piano quotidiano pratico, indicandoci appunto strategia e tattiche da seguire caso per caso.
Dobbiamo resistere su tutto, palmo a palmo, ovunque possibile e con ogni mezzo legittimo possibile, perché qui non è in gioco il nostro stipendio, e nemmeno solo l’immenso valore della nostra libertà naturale, ma la stessa nostra natura umana. Non perdiamo di vista il loro scopo ultimo, per poter essere veramente all’altezza del nostro compito.
E, come sempre, il primo livello di questi grandi princìpi rimane quello religioso-teologico: ovvero, quello a cui quasi nessuno pensa, anche a causa del totale tradimento di coloro che ne dovrebbero essere i primi artefici.
Ma “quando i grandi cadono, tocca ai piccoli guidare” (J.R.R. Tolkien). Secondo coscienza individuale, nel quadro della Verità oggettiva e della Legge naturale.
FONTE: https://www.aldomariavalli.it/2022/01/09/i-cento-euro-di-multa-non-sottovalutateli-sono-una-porta-spalancata-sullabisso/amp/
ECONOMIA
EVENTO CULTURALE
FINANZA BANCHE ASSICURAZIONI
“Le banche prestano soldi solo a chi non ne ha bisogno”. Vero, ma non per i motivi che pensate
10 Gennaio 2022 di Vincenzo Imperatore.
L’abusata frase, ripetutami migliaia di volte, nell’immaginario collettivo trova la sua ragione in quello che, oggi, è divenuto un luogo comune perché formatosi sui presupposti di un contesto macroeconomico completamente diverso.
Finora, per la precisione fino a un paio di anni fa, le banche non prestavano i soldi perché il costo del rischio era (ed è) nettamente superiore al margine di intermediazione.
Oggi ci sono (anche) altri motivi: gli istituti di credito hanno bisogno di fare profitti in una fase di tassi negativi e di compressione dei margini da servizi (vendita di polizze ed altre schifezze)
Ricordiamo che la BCE ha introdotto nel giugno 2014 i tassi negativi sulle liquidità depositate presso di sé dalle banche europee per dissuadere le stesse a parcheggiare le disponibilità in maniera tale che avrebbero trovato più conveniente prestare denari alle imprese e alle persone fisiche.
Per farla breve, se ipotizziamo un tasso negativo del 0,5%, nel momento in cui una banca deposita 100.000 euro dopo un anno ne ritirerebbe 99.500. Conviene alla banca? Sicuramente no!
Non solo ma, oltre la “tassa” sui depositi, la Banca Centrale Europea ha varato anche il TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations): ha prestato denaro alle banche a tassi negativi purchè li offrissero in prestito alle imprese. E la curva dei tassi ci indica che tale situazione sarà stabilire per almeno altri tre anni.
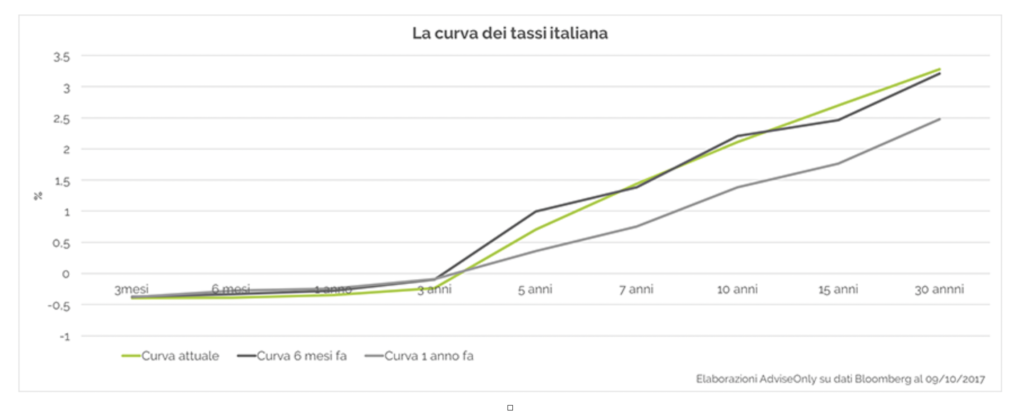
Ritornando sempre allo stesso esempio, se la stessa banca chiedesse un prestito alla BCE di 100.000 euro per prestarli a imprese, dopo un anno dovrebbe restituirne 99.500 euro. In questo caso, invece, la banca ha una covenienza.
Quindi, in sintesi, alle banche conviene prendere a prestito denaro dalla BCE invece che depositarlo presso l’istituto centrale.
Nonostante tutto ciò, tranne qualche eccezione, nell’ambito del sistema bancario non si intravedono significativi segnali di ripresa. I soldi all’economia reale non arrivano. Si mette l’acqua ma il cavallo non beve.
Perché allora, in questo scenario, alle banche conviene, riecco il tormentone, prestare denaro a chi non ne ha bisogno?
Perche’ guadagnano in due, la banca e chi non ne ha bisogno.
Come?
Prestando e depositando la somma presso la stessa banca. Si tratta di un’altra fantasiosa applicazione del principio del “fare finanza con la finanza”.
Spieghiamoci meglio con un altro esempio: immaginiamo che una banca si faccia prestare dalla BCE 100.000 euro al tasso negativo del -0,50% e presti tale denaro ad una impresa applicando il tasso dello 0,10%. Il guadagno lordo per la banca sarebbe 0,60% ovvero, semplice calcolo algebrico, 0,10% – (-0,50%), che è il costo del funding.
Immaginiamo ora che la banca “consigli” al cliente la possibilità di depositare su un suo conto il denaro erogato che viene remunerato allo 0,45%.
Al cliente, al netto del 0,20% quale imposta di bollo, arriva quindi un rendimento pari allo 0,25%.
Tuttavia, non dimentichiamo che il cliente sta pagando lo 0,10% sul prestito ricevuto, per cui il suo vero rendimento netto è lo 0,15% .
E il rendimento netto per la banca? Lo stesso 0,15%, ossia lo 0,60% incassato sul prestito al netto dello 0,45% pagato sul conto deposito.
Allora e’ vero che la banca presta i soldi a chi non ne ha bisogno? Si! Ma non per paura ma per una questione di conto economico.
Come vedete, tanto la banca quanto l’impresa hanno guadagnato con soldi prestati a rischio zero.
Fantascienza?
Dall’analisi dell’ABI sui bilanci dei principali gruppi bancari ad agosto 2021 emergono indicazioni contrastanti: i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 2,3% rispetto a un anno fa mentre i depositi sono cresciuti su base annuale del 7,7%.
Se chiedo, però, conferma al campione delle piccole imprese che gravitano intorno alla mia professione, la risposta è unica: “non abbiamo ricevuto un euro in prestito e, men che meno, abbiamo accumulato liquidità”.
Qualcosa non quadra!
FONTE: https://www.ilparagone.it/attualita/le-banche-prestano-soldi-solo-a-chi-non-ne-ha-bisogno-vero-ma-non-per-i-motivi-che-pensate/
GIUSTIZIA E NORME
IMMIGRAZIONI
LA LINGUA SALVATA
LAVORO PENSIONI DIRITTI SOCIALI
NOTIZIE DAI SOCIAL WEB
PANORAMA INTERNAZIONALE
VENTESIMO ANNIVERSARIO DEGLI ATTENTATI DELL’11 SETTEMBRE
Oggi tutto conferma le tesi di Thierry Meyssan
Contestando la versione ufficiale degli attentati dell’11 Settembre, Thierry Meyssan innescò un dibattito mondiale. Ma la parte più importante del suo libro è in realtà uno studio di scienze politiche, che prediceva quale sarebbe stata l’evoluzione degli Stati Uniti dopo quegli atti criminali. Il problema non è stabilire la modalità degli attentati, ma capire perché quel giorno gli Stati Uniti reagirono violando la Costituzione e perché in quelli successivi adottarono riforme profonde delle istituzioni che le snaturarono. Meyssan previde la trasformazione dell’Impero americano, confermata oggi dalla pianificazione della caduta di Kabul. La storia degli ultimi vent’anni convalida tutte le sue previsioni.

Afine 2001 pubblicai una serie di articoli sugli attentati dell’11 Settembre e, a marzo 2002, un libro [1] − tradotto in 18 lingue − che metteva in discussione la veridicità della versione ufficiale, aprendo un dibattito a livello mondiale. La stampa internazionale si rifiutò però di analizzare le mie argomentazioni e lanciò una campagna denigratoria in cui mi si accusava di «dilettantismo» [2], di «complottismo» [3], nonché di «negazionismo» [4].
Ma, soprattutto, le autorità USA e i loro seguaci ridussero la mia ricerca alle prime pagine del libro: la contestazione della versione ufficiale degli attentati. Si trattava invece di un’opera di scienze politiche, di denuncia di quel che gli attentati sotto falsa bandiera avrebbero reso possibile: il controllo delle popolazioni occidentali e la guerra senza fine nel Medio Oriente Allargato. Ora in questo articolo passo in rassegna ciò che negli ultimi vent’anni è emerso sugli attentati, ma principalmente riscontro l’esattezza delle mie previsioni del 2002.

IL BUCO NERO DELL’11 SETTEMBRE
Se ci chiedono cos’è accaduto l’11 Settembre, tutti rivediamo le immagini degli attentati delle Twin Towers e del Pentagono. Ci siamo però dimenticati di molti altri fatti, per esempio dell’insider trading sulle azioni delle compagnie aeree colpite, dell’incendio che ha devastato l’annesso della Casa Bianca (Old Eisenhower Builging) come del crollo di una terza torre del World Trade Center.
Il fatto più stupefacente è che quasi più nessuno ricorda che, alle 10 del mattino, Richard Clarke fece scattare il Piano di Continuità del Governo [5]. Esattamente nello stesso momento il presidente Bush e il Congresso furono sospesi dalle funzioni e messi sotto protezione militare. Il presidente Bush fu portato in una base aerea del Nebraska, dove dalla sera prima si trovavano i capi delle imprese che avevano sede ai piani più alti delle Torri Gemelle [6]; i membri del Congresso furono invece portati nel mega-bunker di Greenbrier. Il potere passò al Governo di Continuità − che si trovava nel mega-bunker di Raven Rock Mountain (Sito R) [7] − e fu restituito ai civili solo a fine giornata.

Da chi era esattamente composto il Governo di Continuità? Cosa fecero i suoi membri nelle ore in cui detennero il potere? Ancora oggi non lo sappiamo. I membri del Congresso che cercavano risposte non sono stati autorizzati a organizzare una seduta del parlamento sull’argomento.
Ovviamente la polemica sull’11 Settembre non finirà finché gli avvenimenti non saranno chiariti. La procedura messa in atto l’11 Settembre era stata concepita dal presidente Eisenhower, in un’epoca di timori di guerra nucleare: se egli stesso, i presidenti delle camere e la maggioranza dei membri del Congresso fossero stati uccisi sarebbero venuti meno i poteri costituzionali. I militari avrebbero dovuto perciò assumere la continuità di governo. Non fu in ogni caso quel che accadde l’11 Settembre: nessun parlamentare morì. Il passaggio di poteri fu perciò incostituzionale. In senso stretto si trattò di un colpo di Stato.

GLI ATTENTATI DELL’11 SETTEMBRE
Nel mio libro, nonché in seguito, avanzo un’ipotesi su quanto realmente accadde quel giorno, irrilevante però per quanto voglio dimostrare. Chi ha perpetrato questo crimine voleva provocare uno shock simile a quello di Pearl Harbor − come scrissero tempo addietro i membri del Project for a New American Century − per cambiare la vita e il funzionamento degli Stati Uniti. Così ci hanno raccontato un’inverosimile storia, che ci siamo bevuti senza battere ciglio. Ma:
A oggi non esiste prova della presenza dei 19 pirati dell’aria che si sostiene fossero a bordo degli aerei dirottati. Costoro non figuravano sulle liste dei passeggeri diffuse il giorno stesso dalle compagnie aeree. I video dei pirati dell’aria in aeroporto non sono stati girati a New York, ma in altri aeroporti di transito.
A oggi non esiste prova della reale esistenza delle 35 telefonate dei passeggeri dei voli dirottati [8]. Questo vale sia per la conversazione attribuita al coraggioso passeggero che avrebbe attaccato i pirati dell’aria del volo UA93, sia per la telefonata ricevuta dal Procuratore Generale degli Stati Uniti, Theodore Olson, dalla moglie a bordo del volo AA 77. Anzi, durante il processo di Zacarias Moussaoui (accusato di essere il ventesimo pirata dell’aria che non si sarebbe imbarcato) l’FBI testimoniò che i sedili degli aerei non erano dotati di telefono, quindi i passeggeri avrebbero dovuto usare telefoni cellulari, che però all’epoca non funzionavano a un’altitudine superiore a 5 mila piedi; dichiarò inoltre che i tabulati forniti dalle compagnie telefoniche non riportavano alcuna delle comunicazioni in questione, compresa quella ricevuta dal Procuratore Generale Olson.
A oggi non esiste alcuna spiegazione fisica del crollo sulle fondamenta (ossia verticalmente) delle tre torri del World Trade Center. Le Torri Gemelle colpite dagli aerei non hanno vacillato. Tuttavia il carburante sarebbe colato lungo i pilastri e li avrebbe fatti fondere. La terza torre sarebbe stata destabilizzata dal crollo delle due a fianco. Anch’essa si sarebbe afflosciata, ma non lateralmente, bensì verticalmente. Si noti che nessuna spiegazione è stata data delle esplosioni laterali udite dai pompieri e ampiamente documentate da filmati, né dai piastri verticali sezionati invece che fusi; due prove che attestano una demolizione non accidentale, bensì controllata. Si noti peraltro che mai, né prima né dopo l’11 Settembre, è avvenuto il crollo di un grattacielo a causa di un incendio di grandi dimensioni… e che nessuno ha tratto insegnamento dall’11 Settembre e, onde evitare analoghe catastrofi, ha cambiato il metodo di costruzione di questo tipo di edifici. Infine, le fotografie dei pompieri delle “piscine” d’acciaio fuso, nonché quelle della FEMA (l’agenzia incaricata della gestione delle catastrofi) della fusione delle rocce in cui erano costruite le fondamenta sono inesplicabili secondo alla luce della versione ufficiale.
A oggi non esiste prova che un aereo di linea abbia colpito il Pentagono. Già l’indomani, in una conferenza stampa al Pentagono, i pompieri affermarono di non aver trovato niente che potesse appartenere a un aereo. Le autorità, che si erano premurate di emettere un comunicato livoroso contro il mio libro, diedero l’annuncio del ritrovamento di molti rottami dell’aereo che sarebbero serviti a ricostruirlo in un hangar: non se n’è più parlato. Del resto, alcune famiglie dei passeggeri, dapprima scandalizzate per le mie affermazioni, hanno cambiato idea quando sono state loro restituite urne funerarie, garantendo che i corpi erano stati identificati per mezzo delle impronte digitali (che però in un incendio a tali temperature sarebbero state completamente distrutte). Alcune famiglie hanno rifiutato l’impegno alla riservatezza a cospetto di un cospicuo indennizzo.

SORVEGLIANZA GENERALIZZATA DELLE POPOLAZIONI OCCIDENTALI
Nei giorni successivi agli attentati l’amministrazione Bush ha fatto votare al Congresso una normativa contro il terrorismo, l’USA Patriot Act. Un testo molto voluminoso, redatto nei due anni precedenti dalla Federalist Society (di cui il Procuratore Generale Theodor Olson e il ministro della Giustizia John Ashcroft erano membri), che sospende la Dichiarazione dei Diritti (Bill of Rights) nelle vicende di terrorismo.
Gli Stati Uniti nascono dallo scontro di due fazioni. La prima, guidata da Alexander Hamilton, redasse una Costituzione che istituiva un sistema simile alla monarchia britannica, ma con i governatori in luogo dei nobili. La seconda, attorno a Thomas Jefferson e James Madison, accettò la Costituzione soltanto dopo gli emendamenti finalizzati a prevenire ogni uso della Ragion di Stato. La sospensione di questi dieci emendamenti, chiamati la “Dichiarazione dei Diritti”, altera l’equilibrio sul quale gli Stati Uniti furono fondati, attribuendo maggiori poteri al primo gruppo, i discendenti dei Padri Pellegrini, puritani esiliati dall’Inghilterra. Il presidente Bush è discendente diretto di uno dei 41 firmatari del Patto del Mayflower (1620).
Per l’applicazione dell’USA Patriot Act fu istituito un nuovo ministero, il dipartimento per la Sicurezza della Patria (Homeland Security Departement), che ha assorbito alcuni organismi già esistenti. Si è dotato di una polizia politica, in grado di spiare ogni cittadino. Secondo la rivelazione del 2011 del Washington Post, ne fanno parte 835 mila funzionari, di cui 112 mila in incognito [9]: una spia ogni 370 abitanti. Gli Stati Uniti sono il Paese più orwelliano del pianeta. La modalità operativa di questo dipartimento è stata rivelata nel 2013 da Edward Snowden, il quale non si è accontentato d’informazioni sul sistema di intercettazioni nella NSA all’estero, ha soprattutto divulgato informazioni sul sistema di sorveglianza di massa interna agli Stati Uniti. Oggi Snowden è un rifugiato politico che vive in Russia.
Sebbene sia un fatto meno documentato, questo sistema si è esteso progressivamente a tutti gli Stati occidentali, attraverso i Cinque Occhi [10] e la NATO.

LA «GUERRA SENZA FINE»: DALL’11 SETTEMBRE ALLA CADUTA DI KABUL
Un mese e mezzo dopo gli attentati, il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld istituiva l’Ufficio per la Trasformazione della Forza (Office of Force Transformation) e lo affidava all’ammiraglio Arthur Cebrowski. L’obiettivo era cambiare la funzione stessa delle forze armate. La dottrina Rumsfeld/Cebrowski [11] è una riforma importante quanto l’istituzione del Pentagono dopo la crisi del 1929. La sfida è ora l’adattamento al capitalismo finanziario: gli Stati Uniti non vorranno più vincere le guerre, cercheranno invece di farle durare il più a lungo possibile. Questo è il significato dell’espressione «guerra senza fine» usata dal presidente Bush. L’obiettivo sarà distruggere le strutture statali locali per poter sfruttare le ricchezze naturali senza dover incorrere in un controllo politico; obiettivo efficacemente sintetizzato dal colonnello Ralph Peters: «La stabilità è il nemico dell’America» (Stability: America’s ennemy) [12].
È esattamente quanto accaduto in Afghanistan. La guerra è iniziata subito dopo l’11 Settembre. Doveva durare poche settimane, ma non si è mai interrotta. La recente vittoria dei talebani è stata organizzata dagli stessi Stati Uniti per prolungare ulteriormente il conflitto. Infatti il presidente Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono andati in Afghanistan per costruire uno Stato, a differenza di quanto fecero alla fine della seconda guerra mondiale in Germania e Giappone. Nell’incontro a Ginevra con Vladimir Putin, Biden aveva respinto il concetto di guerra senza fine; ora però l’ha rilanciata, allineandosi, come Barack Obama, alla dottrina Rumsfeld/Cebrowski.
Nessun conflitto iniziato dopo l’11 Settembre è terminato: l’instabilità domina in Iraq, Libia, Siria, Yemen e Libano. Si possono definire questi conflitti “guerre civili” e accusare i leader di questi Paesi di essere dittatori, oppure rinunciare a qualsiasi spiegazione, ma è innegabile che, prima dell’intervento occidentale, erano Paesi stabili e che, quando ebbero inizio le loro disgrazie, la Libia di Gheddafi e il Libano di Aoun erano alleati degli Stati Uniti.
Il vicepresidente Dick Cheney costituì alla Casa Bianca un gruppo segreto, incaricato di delineare l’evoluzione della politica nazionale per l’energia (National Energy Policy Development). Cheney era convinto che nel medio termine ci sarebbe stata penuria di petrolio. Ed è questo il motivo che ha indotto gli Stati Uniti a distruggere altri Stati: per poterne sfruttare a termine il petrolio; a scadenza, non immediatamente. La dottrina Rumsfeld/Cebrowski afferma anche che non bisogna combattere le potenze globalizzate, quali Russia e Cina. Bisogna invece consentir loro di accedere alle ricchezze naturali conquistate, costringendole però a versare diritti di sfruttamento agli Stati Uniti.
Pubblicando moltissimi rapporti interni delle forze armate USA, Julian Assange non ha rivelato informazioni sensibili, però dall’insieme emerge che il Pentagono non ha mai voluto vincere le guerre post-11 Settembre. Assange è stato perseguitato sino a perdere la ragione.
Per gestire bene queste guerre il Pentagono si è segretamente dotato di Forze Speciali clandestine: 60 mila soldati senza uniforme [13] in grado di uccidere senza lasciare traccia chiunque e ovunque si voglia. Bob Woodward ha rivelato l’operazione “Matrice dell’attacco mondiale”, decisa tre giorni dopo gli attentati [14]. Wayne Madsen ha pubblicato il nome delle prime vittime in Papuasia, Nigeria, Indonesia e Libano [15].

CONCLUSIONE
La storia degli ultimi vent’anni conferma tutte le mie previsioni. Purtroppo sono rari coloro che hanno compreso l’evoluzione del mondo. La maggior parte delle persone rifiuta di collegare le singole rivelazioni e di prendere atto della responsabilità delle democrazie occidentali nei crimini compiuti nel Medio Oriente Allargato.
Il problema è sempre lo stesso: non vogliamo ammettere che il criminale sia così vicino a noi.
NOTE
[1] L’incredibile menzogna. Nessun aereo è caduto sul Pentagono, di Thierry Meyssan, Fandango Libri, 2002. Seconda edizione riveduta e corretta L’Effroyable imposture suivie de Le Pentagate con la prefazione del generale Leonid Ivashov, che l’11 settembre 2001 rivestiva la carica dicapo di stato maggiore ad interim delle forze armate russe l’11 settembre 2001, Demi-Lune, 2006.
[2] Secondo i miei detrattori non mi sono recato sul luogo degli attentati, come avrebbe dovuto fare un vero giornalista. Ebbene, le tre scene del crimine furono immediatamente dichiarate “segreto militare”. Per anni nessun giornalista di nessun giornale fu autorizzato ad accedervi. L’epiteto di “dilettantismo” dovrebbe perciò valere non solo per me, ma per tutti coloro che esercitano la mia professione.
[3] Il termine “complottismo” si riferisce a chi mette in discussione la teoria ufficiale del tiratore solitario che avrebbe ucciso il presidente Kennedy. Denunciano invece un complotto per eliminare il presidente.
[4] Io nego in effetti la versione ufficiale. Ma il termine “negazionismo” si riferisce a una corrente di estrema destra, le cui idee non ho mai smesso di combattere, che nega la volontà dei nazisti di compiere il genocidio degli ebrei d’Europa.
[5] Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, Richard Clarke, Free Press, 2004.
[6] Come ogni anno Warren Buffet (all’epoca l’uomo più ricco del pianeta) organizzava una cena di beneficienza in Nebraska. La cena, diversamente da quelle dei due anni precedenti, non si tenne in un grande hotel, ma in una base militare. I capi d’impresa invitati misero in congedo la maggioranza dei dipendenti di New York. Questo spiega il numero relativamente basso dei morti nel crollo delle prime due torri.
[7] A Pretext for War: 9/11, Iraq and the abuse of America’s intelligence agencies, James Bamford, Anchor Books (2004).
[8] “11/09, chi ha inventato le false telefonate dagli aerei?”, di Giulietto Chiesa, Megachip-Globalist (Italia) , Rete Voltaire, 23 luglio 2013.
[9] Top Secret America : The Rise of the New American Security State, Dana Priest & William M. Arkin, Little, Brown and Company (2011).
[10] I “Cinque Occhi” sono l’alleanza dei servizi d’intercettazione e di localizzazione di Australia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Regno Unito, creata nel 1941 dalla Carta Atlantica.
[11] “La dottrina Rumsfeld/Cebrowski”, di Thierry Meyssan, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 25 maggio 2021.
[12] “Stabiliy American’s Ennemy”, col. Ralph Peters, Parameters #31-4 (winter 2001).
[13] “Exclusive : Inside the Military’s Secret Undercover Army”, William M. Arkin, Newsweek, May 17, 2021.
[14] Saturday, September 15, At Camp David, Advise and Dissent, Bob Woodward & Dan Balz, Washington Post, January 31, 2002.
[15] «J’accuse – Bush’s Death Squads», Wayne Madsen, Makingnews.com, January 31, 2002.
Uno Stato democratico? intervista a Michel Warshawski
a cura di Alessandra Mecozzi – da Comune-info.net
Abbiamo incontrato Michel Warshawski, giornalista, scrittore e attivista israeliano, nato a Strasburgo nel 1949 da madre francese e padre polacco immigrato e residente a Gerusalemme, in occasione del seminario “E’ tempo di giustizia in Palestina. Le responsabilità dell’Europa”. L’Università La Sapienza di Roma ha negato la sera prima l’aula designata per ospitare l’incontro, Warshawski, co-fondatore dell’Alternative Information Center (Gerusalemme ovest – Beit Sahour), ne era uno dei relatori più autorevoli. Abbiamo approfittato del suo viaggio a Roma per porgli alcune domande sulla nuova profonda svolta antidemocratica che sta investendo il suo paese.
Come sei arrivato a impegnarti nella lotta contro l’occupazione israeliana? E’ stato il frutto dell’educazione familiare?
Mio padre, rabbino, è diventato una personalità, ma ha dovuto lottare per farsi accettare socialmente. Io non capivo granché, ma da piccolo a scuola mi chiamavano dispregiativamente “polaque” (non polonais). Faccio parte della prima generazione nata dopo la guerra, sono cresciuto con l’onnipresenza dei discorsi e dei ricordi sulla “occupazione” nazista. A 17 anni sono andato nei territori palestinesi, accompagnavo mio padre che portava pellegrini ebrei a visitare i luoghi santi. Mi sono trovato di fronte alla occupazione israeliana senza sapere proprio niente di conflitto arabo-israeliano, della guerra del 1967…ma è lì che ho capito. Nel momento in cui, parlando con un commerciante palestinese, ho visto nei suoi occhi la paura, paura di un ragazzo israeliano! e di nuovo è risuonata la parola “occupazione”. Ma questa volta noi non eravamo gli occupati, ma gli occupanti. Quella parola, occupazione, evocava nella mia testa storie di violenza, di brutalità, di miseria, ho capito che mi riguardava in prima persona e che dovevo battermi contro di essa, ma dovevo farlo mantenendo sempre aperto e vivo il rapporto tra Israeliani e Palestinesi. Per questo, insieme ad altri, fondammo l’Alternative Information Center, che è l’unica organizzazione “bilaterale” che ha resistito a resiste a tutte le crisi. Siamo riusciti a farne una sola organizzazione, non una partnership tra due diverse. Quelle che hanno scelto la separazione ad ogni crisi si sono fermate, ognuno si è rinchiuso nel suo cerchio. Perfino Neve Shalom che esiste da moltissimi anni…
A che cosa attribuisci questa resistenza?
Per quanto mi riguarda, sono certo che derivi dalla mia formazione internazionalista, per la quale ritengo che ci siano valori che trascendono le diversità di paese, di religione, di etnia….Per molti anni il lavoro, la lotta in comune tra Israeliani e Palestinesi, è stato forte….Oggi purtroppo le cose sono cambiate, ed è diventato molto più difficile. Israele ha costruito un muro di cemento, che si è alzato anche nelle teste di tantissimi attivisti/e. Ci tengo a dire che io parlo sempre di occupazione coloniale e che tutto il dibattito sull’indipendenza ci porta alla questione del controllo dei confini. Fin da Ben Gurion nella cultura israeliana non ci sono confini. Il termine anglosassone, americano, fronteer indica uno spazio libero da occupare, quello di border indica invece un limite che non va oltrepassato! Dal 1967, con l’occupazione conseguente di territori, il concetto “colonizzazione” è entrato nel discorso politico. Anche l’impatto psicologico è stato forte; si è realizzato nel 1977, quando è avanzata la destra nazionalista, la religione ha preso maggior peso, e i giovani a quel momento sono diventati l’avanguardia dei coloni…
Oggi, e ancor più dopo l’elezione di Trump, sembra che la situazione non permetta più di parlare di “due popoli, due Stati”. Molti dicono che la situazione sul campo è irreversibile. Sei d’accordo?
Assolutamente no. Questo concetto di irreversibilità già negli anni ’70 lo esprimeva Meron Benvenisti (vice sindaco di Gerusalemme) dicendo che il processo di colonizzazione/annessione era un fatto irreversibile e dunque non fattibili i due Stati. Ma non ero e non sono d’accordo. Non c’è niente di irreversibile…tranne se c’è un genocidio!
In Europa, e ancor più in Italia, stiamo assistendo ad una azione repressiva ed escludente rispetto a iniziative che vogliano promuovere informazione sulla Palestina e la cultura palestinese. L’ultimo caso è quello dentro cui anche tu ti sei trovato, con il divieto dell’ Università la Sapienza di fare il seminario a cui sei stato invitato all’interno dell’università. Il divieto è stato espresso su richiesta esterna di un Osservatorio sulle discriminazioni, Solomon, legato alla Comunità ebraica. A tuo avviso questa “stretta” corrisponde ad una stretta anche nella politica interna di Israele?
Sì, in Israele si sta verificando più che una regressione, c’è un passaggio da un regime a un altro. Lo Stato di Israele sta diventando un’altra cosa. Lo stesso Adam Burg, già presidente di Israele, e della Knesset, parla di fascismo. La dimensione democratica viene rimessa in discussione. Si parlava di Stato ebraico democratico: adesso il ministro dell’Istruzione, Naftali Bennett, dice apertamente che la parte importante di questa definizione è l’ “ebraico”, non il democratico. E questo viene realizzato attraverso una serie di nuove leggi discriminatorie nei confronti dei Palestinesi in Israele. Per esempio quella detta della regolarizzazione che permette di espropriare un proprietario palestinese e passare la sua terra a uno ebreo. Prima per gli espropri si adducevano ragioni di sicurezza, per la località in cui era situata la terra, per esempio su una certa collina…Con questa legge lo si può fare senza alcuna motivazione. E’ importante notare che la Corte Suprema ancora non si è dichiarata, è stato espresso qualche dubbio di incostituzionalità, ma la ministra della giustizia Ayelet Shaked ha già dichiarato che se la Corte Suprema si immischia nella questione verrà fatto un articolo speciale che proibisce alla Corte di esprimersi sulle decisioni del governo.
Ma come può avvenire una cosa del genere?
E’ semplice, il governo dice: noi siamo la maggioranza, quindi esprimiamo la volontà popolare. Una volontà assoluta, che non può essere contraddetta dalla Corte Suprema. Insomma, c’è una dittatura della maggioranza. Il cambiamento è profondo e viene operato passo dopo passo. Adesso ci sono due argini: la Corte Suprema e certi organi di informazione, dove ci sono buoni giornalisti, articoli critici, reportage. Netanyahou e la ministra della giustizia Ayelet Shaked hanno deciso di rompere entrambi gli argini. Il governo sta distribuendo gratuitamente per strada un suo giornale e ha espresso l’intenzione di far votare una legge per limitare il potere dei mezzi di informazione. D’altro canto, la ministra della giustizia ha già fatto un passo verso la modifica della Corte Suprema, rimpiazzando con propri nominati nella commissione che ne sceglie i giudici, man mano che vanno in pensione i suoi componenti, quelli considerati dell’”attivismo giuridico”, che può cioè intervenire sulla natura della legge. Se la Corte Suprema perde questa prerogativa, diventa una semplice corte d’appello, senza alcun potere.
Sulla informazione non siamo ancora alla censura, ma le ultime leggi rafforzano il “discorso unico”. Al fondo c’è il concetto di “fedeltà allo Stato”. Ad esempio i deputati della Knesset dovranno esprimere fedeltà allo Stato di Israele come Stato del popolo ebreo. Intanto, la ministra della cultura ha dichiarato che non darà più fondi a chi non dimostra fedeltà allo Stato: il Teatro Nazionale si è visto tagliare i fondi perché ha presentato una pièce teatrale scritta in carcere da un ex prigioniero politico palestinese. L’argomento a sostegno di tale scelta è che il bene pubblico va gestito dalla maggioranza eletta, cioè dal governo. Ora la ministra della cultura è piuttosto incolta, ma è significativo che sia stata il generale dell’esercito che operava la censura militare su tutta l’informazione pubblica civile, una censura motivata da questioni securitarie. Questa censura era scomparsa negli anni ’80.
E sul caso dell’Università di Roma in particolare, tenendo conto che non è il primo, cosa ti senti di dire?
Immagino che non sarà neanche l’ultimo. Ricordo che in Francia, nel 2002, Sharon incontrò Cukiermann, presidente del CRIF, Consiglio dei rappresentanti della comunità ebraica in Francia, e disse esplicitamente che bisognava organizzare una controffensiva all’estero utilizzando “l’antisemitismo”. Venne lanciata una campagna di demonizzazione di giornalisti e politici accusati di essere antisemiti. Poi ci fu un po’ di calma. Ma dal 2008, da quando la campagna BDS ha cominciato a mostrare efficacia, dal punto di vista dell’immagine più che economicamente, in Israele si è aperta una nuova fase. In partnership con il ministro degli affari esteri, Lieberman, è stata messa in piedi una task force per una “strategia difensiva di attacco”! Una strategia basata su propaganda e repressione contro chi critica questo Israele. E’ rivolta contro tutti coloro che chiedono qualche forma di sanzione, non solo la campagna BDS. La novità è che da un anno si è costituito un dipartimento con ampio budget statale che, attraverso una task force, è incaricato di tenere sott’occhio e prendere di mira Stati e istituzioni pubbliche, una vera e propria strategia del governo. Quanto è successo a Roma rientra in questa politica e di solito, penso al caso francese, c’è un collegamento con l’ambasciata israeliana del paese interessato.
FONTE: https://palestinaculturaliberta.wordpress.com/2017/03/29/uno-stato-democratico/
POLITICA
LA DEMAGOGICA ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO DIRETTO AI PARTITI
 Tutto iniziò nel 1974 con la “legge Piccoli” (legge 195/1974), quando fu introdotto il finanziamento pubblico ai partiti, affinché si contrastasse la collusione fra i partiti politici e le lobbies economiche, proprio per evitare certi scandali come ad esempio il caso Trabucchi. Due tipi di finanziamento furono legiferati, il primo riguardava il finanziamento ai gruppi parlamentari (articoli 3 e successivi), che determinò l’obbligo di dare il 95 per cento del finanziamento ricevuto al rispettivo partito di appartenenza, il secondo tipo invece riguardava il finanziamento dell’attività elettorale per le diverse competizioni elettorali (articoli 1-2). In seguito fu approvata la legge 659 del 1981 che aumentò l’importò dei finanziamenti e li riformò. A seguito dello scandalo di Tangentopoli e sull’onda emotiva, cavalcata artatamente da una certa classe politica, in modo alquanto demagogico, fu promosso dai Radicali il Referendum nel 1993 sull’abolizione del finanziamento ai partiti. La vittoria del “Sì” determinò l’abolizione del finanziamento ai partiti tramite i gruppi parlamentari, mantenendo però il finanziamento per l’attività elettorale.
Tutto iniziò nel 1974 con la “legge Piccoli” (legge 195/1974), quando fu introdotto il finanziamento pubblico ai partiti, affinché si contrastasse la collusione fra i partiti politici e le lobbies economiche, proprio per evitare certi scandali come ad esempio il caso Trabucchi. Due tipi di finanziamento furono legiferati, il primo riguardava il finanziamento ai gruppi parlamentari (articoli 3 e successivi), che determinò l’obbligo di dare il 95 per cento del finanziamento ricevuto al rispettivo partito di appartenenza, il secondo tipo invece riguardava il finanziamento dell’attività elettorale per le diverse competizioni elettorali (articoli 1-2). In seguito fu approvata la legge 659 del 1981 che aumentò l’importò dei finanziamenti e li riformò. A seguito dello scandalo di Tangentopoli e sull’onda emotiva, cavalcata artatamente da una certa classe politica, in modo alquanto demagogico, fu promosso dai Radicali il Referendum nel 1993 sull’abolizione del finanziamento ai partiti. La vittoria del “Sì” determinò l’abolizione del finanziamento ai partiti tramite i gruppi parlamentari, mantenendo però il finanziamento per l’attività elettorale.
Il finanziamento ai partiti tramite i gruppi parlamentari fu di fatto sostituito successivamente con l’aumento dell’importo previsto per i rimborsi elettorali sancito con l’approvazione della legge 515 del 1993 e della legge 157 del 1999. Fino a quando non arrivò il Governo Monti che legiferò una riforma del finanziamento ai partiti in senso radicalmente restrittivo, con la legge 96 del 2012, grazie alla quale venne ridotta in modo significativo l’entità dei rimborsi elettorali e provò a strutturarne una disciplina unitaria. Infine con il Governo Letta ci fu la definitiva abolizione del finanziamento ai partiti con il decreto legge 47 del 2013, convertito in legge dalla legge 13 del 2014 ed il pagamento dei rimborsi inerenti alle precedenti elezioni proseguì, con una progressiva riduzione, fino al tutto 2016. Oggi sono previste e legittime solo forme di finanziamento indiretto ai partiti, purché essi abbiano una rappresentanza in Parlamento. L’articolo 15, comma 4, dei regolamenti della Camera e l’articolo 16 commi 1-2, del regolamento del Senato prevedono dei contributi per i gruppi parlamentari, affinché essi possano finanziare le loro attività istituzionali.
Tramite i soldi pubblici vengono finanziati i fondi presenti nel bilancio della Camera e del Senato, da cui si attinge per erogare i fondi per finanziare le sopra citate attività istituzionali dei gruppi parlamentari. Secondo quanto riportano i rispettivi progetti di bilancio della Camera e del Senato, risulta che nel 2019 la Camera darà ai gruppi parlamentari circa 31 milioni di euro, mentre il Senato prevede di dare circa 22 milioni di euro. Per contribuire al finanziamento dei partiti è stato previsto anche il finanziamento privato, infatti, in base al decreto legge 149 del 2013 del Governo Letta è stata introdotta la possibilità da parte del privato di distrarre il 2 per mille o la piccola quota dell’Irpef dovuta allo Stato (analogamente all’8 per mille per le confessioni religiose) a favore dei partiti in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, sono state introdotte le “erogazioni liberali”, ossia quelle donazioni private in parte detraibili fino a 30mila euro, purché esse non siano maggiori di 100mila euro.
In questa oggettiva situazione, da cui si evince una drastica diminuzione delle risorse pubbliche destinate al finanziamento dei partiti, minando in tal modo la tenuta del sistema democratico e parlamentare che si regge costituzionalmente sulla rappresentanza dei partiti, si è sviluppato in modo significativo il fenomeno delle fondazioni in stretta connessioni con singoli politici o partiti, come canale alternativo funzionale al finanziamento delle attività politiche, a causa delle quali è sorta l’esigenza di garantire un maggior obbligo di trasparenza nella raccolta dei loro fondi, in quanto decisamente inferiore rispetto a l’obbligo di trasparenza stabilito per i partiti. In funzione di garantire quest’obbligo di trasparenza è stata recentemente approvata la legge soprannominata “spazza-corrotti”, con l’equiparazione dei partiti alle fondazioni, riuscendo solo in parte nel suo scopo di garantire un’adeguata trasparenza. Da un’attenta analisi e comparazione delle discipline sui finanziamenti ai partiti degli altri stati europei si evincono delle significative differenze con ciò che è previsto a riguardo in Italia. Come spiega un approfondimento della Camera del 2013, in Germania la questione del finanziamento pubblico ai partiti è stata a lungo una Vexata quaestio, con la Corte costituzionale che a più riprese ha bocciato le leggi che il Parlamento faceva in proposito, fino ad arrivare al sistema attuale che si fonda sui rimborsi elettorali e non sul finanziamento diretto. La legge del 1994 che disciplina la materia (articolo 18, comma 3), modificata poi a fine 2004 in seguito a una sentenza della Corte costituzionale tedesca, prevede che alle formazioni politiche che superano determinate soglie di voti venga annualmente corrisposto un contributo proporzionale ai voti ricevuti e un contributo calcolato sulla quota dei contributi versati da privati, entrambi a carico del bilancio dello Stato. L’esborso massimo per lo Stato è fissato, per il 2019, in 190 milioni di euro. Sono poi previsti un contributo pubblico ai gruppi parlamentari e la possibilità di finanziamenti privati, deducibili entro determinate soglie. Mentre in Francia, riporta ancora il dossier della Camera, il finanziamento pubblico dei partiti è a carico del bilancio dello Stato e l’entità massima dell’erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria. L’ammontare degli stanziamenti di pagamento individuato dalla legge finanziaria è ripartito (articolo 8 della legge 88-227 del 1988) in due frazioni eguali: la prima è destinata ai partiti politici in base ai voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la seconda è destinata ai partiti politici in funzione della loro rappresentanza parlamentare.
Sono poi previsti dei rimborsi, forfettari ma con dei limiti, per le spese elettorali e i privati possono fare donazioni, di nuovo entro certi limiti e con modalità specifiche.
Invece per ciò che concerne il Regno Unito, “nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale”, si legge ancora nel dossier della Camera. “Tali caratteristiche del finanziamento pubblico – prosegue il dossier – derivano dalla natura giuridica dei partiti politici, privi di personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie”. Di fatto sono previsti – a parte gli incentivi finanziari destinati a tutti i partiti (Policy development grants) – conferimenti in denaro solo per i partiti di opposizione, con l’idea di compensare i vantaggi che vengono al partito di maggioranza dall’essere al Governo; vantaggi economici, ma non solo. Come risulta dal relativo dossier della House of Commons, questi conferimenti (detti Short money) sono stati introdotti nel 1975, vengono dati ai partiti che hanno eletto almeno due deputati (o un deputato ma più di 150mila voti) e assumono tre diverse forme: contributo generale per lo svolgimento dell’attività parlamentare; contributo per le spese di viaggio sostenute dai membri dei gruppi parlamentari di opposizione; dotazione riservata all’ufficio del capo dell’opposizione.
Nel 2018/2019, ad esempio, il Partito laburista ha ricevuto meno di 8 milioni di sterline e tutti gli altri partiti meno di un milione di sterline. Sono poi possibili donazioni private, in un quadro di regole stringenti che garantiscono la trasparenza e la pubblicità delle operazioni. Alla luce di quanto esposto e analizzato si può affermare che l’abolizione scriteriata del finanziamento diretto ai partiti non ha generato più trasparenza e né ha implicato che ci fossero minori collusioni con torbidi interessi e commistioni con dinamiche illecite, che rispondessero ad interessi lobbistici, ma ha determinato solamente un deficit di democrazia e di rappresentanza democratica destabilizzando alla radice la funzione costituzionale dei partiti, trasformando la politica italiana in faziosi personalismi che hanno contribuito all’attuale paralisi politica, di cui subiamo le perniciose conseguenze.
FONTE: https://www.opinione.it/politica/2022/01/11/fabrizio-valerio-bonanni-saraceno_referendum-abolizione-finanziamento-partiti-radicali-tangentopoli/
DA ISTITUTO LIBERALE
Sisto Ceci – 9 01 2022
L’innovazione tecnologica ha sempre dei nemici. In Italia ogni innovazione viene accolta con ostilità da chiunque operi nello stesso settore.
Un’ostilità che può sfociare in proteste di piazza o in azioni di lobbying sul parlamento affinché legiferi per vietare le nuove invenzioni.
Questo comportamento è nocivo poiché può rallentare il progresso tecnologico anche di molti decenni.
In un caso, lo rallentò addirittura di un secolo.
Denis Papin era un professore di matematica e fisico francese convinto che le macchine a vapore avrebbero rivoluzionato il mondo.
Aveva lavorato per anni al progetto di un motore a vapore e finalmente, nel 1705, montò un prototipo su un’imbarcazione. Per eseguire il primo test scelse un tratto del fiume Fulda nei pressi di Münden, nello stato tedesco dell’Assia-Kassel.
All’epoca, i trasporti sul fiume Fulda erano monopolio di una corporazione di barcaioli. Papin, fiutando complicazioni, chiese al governo di ricevere qualche forma di protezione durante la navigazione, ma questa gli fu negata.
Interessato a condurre comunque l’esperimento, mise il battello sul fiume e, come aveva previsto, la corporazione reagì attaccando la sua nave e distruggendola.
La colpa di Papin, per i barcaioli, era quella di minacciare il loro commercio sul fiume introducendo un’imbarcazione più veloce che avrebbe fatto loro concorrenza.
Lo stato di Kassel, dal canto suo, era più interessato a tutelare gli interessi costituiti delle varie corporazioni, piuttosto che la proprietà privata di un solo e ininfluente cittadino.
In ogni caso, dopo l’evento, Papin non tentò mai più l’esperimento e morì alcuni anni dopo in povertà.
Il merito di aver inventato il battello a vapore andò, quindi, all’americano Robert Fulton che nel 1807 compì il primo viaggio di 270 miglia.
Robert Fulton poté godere dei vantaggi di un’industria metallurgica ormai meccanizzata, quindi il suo motore era più performante, ma a fare la differenza furono le istituzioni americane: non si opposero e, anzi, lasciarono che il progresso andasse avanti.
Solo cinque anni dopo l’esperimento di Fulton, i commerci via fiume con battelli a vapore erano la normalità.
FONTE: https://www.facebook.com/100031860510496/posts/631462034592475/
PROMEMORIA per la sinistra italiana ed europea complice del terrorismo genocida islamico.
Sisto Ceci – 8 01 2022
Il primo di gennaio 2015 il presidente egiziano Al Sisi , in un discorso all’universita’ Al Azhar , forse la sede teologica – culturale piu’ prestigiosA del mondo islamico, nel quale dice , tra le altre cose : ” E’ possibile che la nostra dottrina debba fare di tutta la Umma ( la comunita’ dei fedeli islamici ) una sorgente di ansieta’ , di pericolo , di uccisioni e distruzione del resto del mondo ?…….e ancora” il corpo dei testi e di idee che abbiamo sacralizzato e’ in antagonismo con tutto il mondo ………e’ possibile che 1,6 miliardi di persone vogliano , per poter esse stesse vivere, uccidere il resto degli abitanti del mondo ? e infine ” Abbiamo bisogno di una rivoluzione religiosa ” . Il presidente Al Sisi e’ un islamico osservante , conosce i musulmani assai meglio della Boldrini della Kyenge , della Caritas , delle COOP , delle ONG , delle ONLUS , dei cattocomunisti del PD, dei buonisti ,dei multiculturalisti, dei terzomondisti , dei politicamente corretti , di tutta quella feccia POLITICA di sinistra che diffonde veleni IDEOLOGICI E culturali in Europa e in Italia ,che manda i ragazzi/e a morire con l’ISIS , che si affanna a dire che esiste un Islam moderato , che i terroristi non sono l’Islam , ma Al Sisi dice 1,6 miliardi di islamici,tutta la Umma , NON UNA PARTE , TUTTI , NON DICE CHE ESISTE UN ISLAM MODERATO ,L’ISLAM MODERATO E’ UNA INVENZIONE DELLA SINISTRA EUROPEA PER COPRIRE IL SUO TRADIMENTO E LA SUA COMPLICITA’ CON I TERRORISTI GENOCIDI . UN ISLAMICO ORTODOSSO PIU’ LAICO DI TUTTA LA VERGOGNOSA SINISTRA EUROPEA CHE LISCIA IL PELO AL GATTO ISLAMICO PER NON ESSERE GRAFFIATA ….NON SARA’ GRAFFIATA MA DECAPITATA.
FONTE: https://www.facebook.com/100031860510496/posts/631020497969962/
Gli Stati Uniti e la ribellione delle élite
Scritto da Alessandro Aresu – 11 Gennaio 2022
7minuti di lettura
Questo contributo è tratto dal numero 4 di «Pandora Rivista» – uscito nel 2016 e intitolato “Élite” – ed è stato scritto all’epoca dell’elezione di Trump. L’articolo di Alessandro Aresu è ora liberamente accessibile, altri sono leggibili solo agli abbonati nella sezione Pandora+ che ospita l’archivio delle versioni online dei contributi dei numeri cartacei pubblicati.
I. Il musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda, a Broadway dal 2015, dedicato alla vita del padre fondatore Alexander Hamilton, è stata l’ultima e sorprendente incarnazione della religione civile degli Stati Uniti. Ha restituito una capacità unica di tornare alle proprie origini per ravvivarle, facendo rappare e cantare a milioni di persone le vicende della fondazione.
Nella scena che racconta l’elezione del 1800, si raffrontano Thomas Jefferson e Aaron Burr, dando spazio alle opinioni degli elettori: UN ALTRO ELETTORE MASCHIO: E Jefferson / DUE UOMINI: Quello lì è innamorato della Francia / UN’ALTRA ELETTRICE DONNA: Già, è così elitista! / DUE DONNE: A me piace quell’Aaron Burr! / UNA DONNA: Wow, non posso credere che siamo davvero qui assieme a lui! / UN UOMO: Sembra uno alla mano? / UN ALTRO ELETTORE MASCHIO: È il tipo di persona con cui si può prendere una birra [1].
In realtà, l’accusa di essere il campione “elitista” tra i Padri Fondatori è stata normalmente formulata proprio contro l’eroe del musical, Alexander Hamilton, per la sua filosofia legata all’azione centralizzatrice del governo, alla centralità del potere esecutivo, al sospetto verso lo spirito democratico (capace di amazing violence and turbulence), alla vicinanza al potere finanziario. Secondo la biografia su cui si basa il musical, «la sua implicita preferenza per l’élite basata sul merito venne fraintesa dai suoi nemici come un’adorazione segreta dell’aristocrazia». D’altra parte, questa incomprensione era giustificata da un’ambiguità presente nello stesso pensiero di Hamilton, che spesso evocava un passato in cui le élite privilegiate prendevano decisioni in luogo di cittadini meno preparati, così contraddicendo «il pensiero economico espresso nella sua visione di una élite fluida e meritocratica, aperta agli outsider di talento come lui stesso» [2].
Al contrario, l’opera di Lin-Manuel Miranda esalta Hamilton come simbolo di una nazione di immigrati e come icona della mobilità sociale, il «padre fondatore senza un padre» che passa dalla povertà all’amministrazione dell’economia della giovane nazione, diventando dal nulla la persona più importante della storia dell’economia e dell’impresa degli Stati Uniti [3].
II. Che si tratti di prendere una birra o di comprare un’auto usata, il simbolismo sulla vicinanza al popolo dei candidati per le cariche pubbliche è una caratteristica saliente della riflessione sulla politica americana e della sua percezione pubblica. Un libro pubblicato postumo dal sociologo Christopher Lasch (1932-1994), The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy [4], fornisce un’impalcatura teorica per affrontare questo tema, tenendo presente la specificità degli Stati Uniti. L’aspetto centrale della ricerca di Lasch è la preoccupazione sul futuro della democrazia. A suo avviso, la minaccia principale alla democrazia degli Stati Uniti viene dall’abisso «che divide le classi privilegiate dal resto della nazione». A metà degli anni Novanta del Novecento, le élite non sono «mai state così pericolosamente isolate da quanto le circonda». Il problema che Lasch cerca di svolgere nella sua opera, tanto in The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy quanto nei lavori precedenti dedicati alla critica dell’individualismo radicale (The Culture of Narcissism) e del concetto di progresso (The True and Only Heaven), è proprio la separazione tra gli strati della società. La minaccia per la tenuta della democrazia per Lasch sta in questo straniamento reciproco delle élite e del resto della società, perché ciò rende impossibile un discorso pubblico comune, legato alla volontà e alla capacità di tradurre i diversi linguaggi che compongono la democrazia. La ribellione non riguarda più principalmente le masse, ma le élite, perché il passo dello straniamento e della separazione è stato compiuto dalle stesse élite, le quali «guardano alle masse con una mescolanza di disprezzo e di apprensione» e hanno rinunciato agli spazi e alle istituzioni comuni. La ribellione delle élite sta quindi in un’opzione politica precisa, la loro decisione di costruire una realtà parallela, nell’urbanistica, nell’istruzione e nella politica: in questo modo una parte della nazione alimenta attivamente lo spirito di fazione (faction) che i Padri Fondatori ritenevano particolarmente dannoso per le repubbliche. Ne consegue una “insularizzazione” in cui il conflitto democratico tra diversi interessi non esiste più, perché manca il momento del riconoscimento. È in questi termini che Lasch legge le cultural wars, le guerre culturali: «Le guerre che hanno sconvolto l’America dagli anni Sessanta in poi si comprendono meglio se le vediamo come una specie di guerra di classe, in cui una élite illuminata (una élite, almeno, che si considera tale), cerca non tanto di imporre i propri valori alla maggioranza (una maggioranza considerata incorreggibilmente razzista, sessista, provinciale e xenofoba), e meno ancora di convincere la maggioranza con gli strumenti del dibattito razionale, quanto di creare delle istituzioni parallele o “alternative” in cui non sarà più necessario scontrarsi con i non illuminati». In questa costruzione delle realtà parallele e delle istituzioni parallele, la possibilità della discussione viene quindi espulsa. Gli illuminati e i non illuminati possono ritrovarsi nei loro rispettivi gruppi, ma non avere un’arena comune per comporre – e anzitutto chiarire – i loro conflitti. L’incontro delle élite con gli altri non è quindi democrazia. È più che altro una forma di turismo. Con il conflitto, viene espulso anche il concetto di classe («il concetto basilare che le nostre élite respingono come inguaribilmente fuori moda»), per affidarsi a espressioni edulcorate e neutre per affrontare la questione del potere.
Leggere oggi Lasch è interessante perché la sua operazione a metà degli anni Novanta recuperava in senso positivo una parola che gode di pessima reputazione: populismo. A suo avviso il populismo è la «voce autentica della democrazia». Lasch si riferisce al concetto statunitense di populismo, radicato nella difesa della piccola proprietà, ma non ne fornisce una puntuale definizione storica. Come ha mostrato Michael Kazin, la storia della proposta populista negli Stati Uniti non è legata solo all’ascesa del People’s Party alla fine del diciannovesimo secolo (e alla ripresa di alcune esigenze populiste di uguaglianza e di contrasto attivo ai trusts da parte di un fiero oppositore e ridicolizzatore del People’s Party come Theodore Roosevelt). La persuasione populista, infatti, è tornata ciclicamente nella storia del Novecento. Per esempio, negli anni Sessanta l’appello al populismo accomunava George Wallace, governatore dell’Alabama, e gli studenti che protestavano contro il suo segregazionismo [5]. Populista lui, populisti gli altri. D’altra parte, il populismo si lega sempre sia alla costruzione/indicazione di un “popolo” che a quella dell’élite, una power élite (Charles Wright Mills) più o meno definita. Perciò, entrambi questi concetti sono resi omogenei nella retorica politica, ma difficilmente sono tali.
In The Revolt of the Elites, Lasch discute insieme il populismo e il comunitarismo. A suo avviso, sia il populismo che il comunitarismo si oppongono alla ragione illuminista e cercano una terza via rispetto al predominio del mercato e allo stato assistenziale. In particolare, Lasch definisce il populismo in opposizione alla «ideologia della compassione», ovvero alla rinuncia della società di elevare il livello generale di competenza – «il vecchio significato della democrazia» – per rendere invece prassi istituzionale il diritto della classe responsabile di occuparsi di tutti gli altri, attraverso «pretese di superiorità morale avanzate a nome degli oppressi». In questo senso, per tornare alle cultural wars, c’è una vicinanza tra populismo e comunitarismo all’interno delle posizioni conservatrici su principi e valori morali, per esempio sulla famiglia e l’aborto. Questo aspetto, tuttavia, per Lasch non è il più importante. Ciò che distingue il populismo è una specifica attenzione al problema economico, senza cui è impossibile comprendere il concetto di comunità. Nella sua idea della politica della compassione le élite si occupano di ciò che non conoscono, dacché vivono in un mondo separato. Nella politica populista, le questioni di classe sono centrali: «le grandi ineguaglianze, come i populisti hanno sempre sostenuto, sono incompatibili con qualsiasi forma di comunità quale oggi sarebbe considerata desiderabile e (…) tutto dipenderà, come sempre, dalla possibilità di colmare l’abisso tra le élite e il resto della nazione».
Che si tratti di “divergenza” o di “abisso”, la questione della separazione tra le élite e il resto della nazione è diventata una costante del dibattito intellettuale degli Stati Uniti, nelle analisi di alcuni dei suoi maggiori protagonisti. Limitiamoci a due esempi. Nel 2004 Samuel Huntington ha utilizzato l’espressione «uomo di Davos» per descrivere la nuova élite globale cosmopolita, formata da persone che vedono i confini nazionali come ostacoli per fortuna destinati a svanire e considerano i governi nazionali dei relitti del passato che si rendono utili solo quando facilitano la loro operatività globale. Nel 2012 Charles Murray ha pubblicato Coming Apart: The State of White America, 1960-2010, in cui descrive con un notevole apparato statistico le faglie dell’America bianca degli ultimi cinquant’anni, con la riduzione della classe media e la separazione crescente tra una classe disagiata e una nuova superclasse. La superclasse vive in quelli che Murray chiama i SuperZIPs, i codici postali indicatori di ricchezza, in cui la meritocrazia funziona in modo così perfetto da disegnare una società perfettamente chiusa rispetto alle influenze esterne: i membri della classe più agiata vivono negli stessi quartieri, hanno le stesse abitudini alimentari e sportive, frequentano le stesse scuole e università, si sposano tra di loro. Il momento in cui una élite si guarda allo specchio è quello della circolazione, e nell’analisi di Murray la circolazione non esiste.
III. «Nel 1959, un giovane uomo giunse negli Stati Uniti dal Kenya, si innamorò di una ragazza del Kansas e divenne padre di un figlio che, da grande, mantenne la promessa che qualunque ragazzo, per quanto sembri impossibile, può diventare Presidente. Nel 1973, un altro giovane uomo giunse qui da Porto Rico, imparò l’inglese, mise su famiglia fino a vedere, una notte del 2009, suo figlio ricevere una standing ovation dal Presidente degli Stati Uniti» [6]. L’intreccio delle storie di Alexander Hamilton, di Barack Obama e di Lin-Manuel Miranda cerca di testimoniare che nella nazione di immigrati ogni cosa è possibile. Il musical Hamilton si apre con la domanda: «Come può un bastardo, un orfano, un figlio di puttana scozzese, gettato dalla provvidenza nella povertà e nello squallore del mezzo di un posto dimenticato dei Caraibi, crescere e diventare un eroe e uno studioso? [7]» La risposta a questa domanda è: gli Stati Uniti d’America. La storia di Barack Obama dovrebbe testimoniarlo, il musical di Lin-Manuel Miranda dovrebbe raccontarlo di nuovo, trasmettendo la frenesia dell’ascesa e della circolazione delle élite. Grazie alla forza trascinante del merito, un orfano può diventare padre fondatore, e chiunque può diventare qualunque cosa. Davanti al mantenimento di questa promessa, l’America dovrebbe ascoltare e commuoversi, riconoscersi in quello specchio. Invece, le cose non sono così semplici. La storia è più ambigua: se i diversi stili musicali di Hamilton mettono sullo stesso palco i conflitti dei Padri Fondatori, quei conflitti parlavano in ogni caso linguaggi traducibili gli uni con gli altri. I loro contrasti potevano essere ricomposti nella democrazia. Quando gli abissi, ideali e materiali, segnano le differenze, e in esse si inseriscono le grandi cesure demografiche, non è detto che possa esservi una vera ricomposizione, tantomeno basata su singole storie di successo. Per questo, gli specchi di Lasch e di Hamilton convivono negli Stati Uniti di oggi.
[1] Lin-Manuel Miranda e Jeremy McCarter, Hamilton. The Revolution, Grand Central Publishing, New York 2016, p. 259.
[2] Ron Chernow, Alexander Hamilton, Penguin Books, Londra 2004, pp. 218 e 234.
[3] Il giudizio è dello storico Thomas K. McCraw.
[4] I virgolettati di questo paragrafo, qualora non diversamente indicato, sono tratti dalla traduzione italiana del volume, La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia, Feltrinelli, Milano 2009.
[5] Si vedano Michael Kazin, The Populist Persuasion, Basic Books, New York 1995, e, in riferimento alla campagna presidenziale del 2016, il suo How Can Donald Trump and Bernie Sanders Both Be ‘Populist’?, «New York Times Magazine», 22 marzo 2016.
[6] Lin-Manuel Miranda e Jeremy McCarter, op. cit., p. 15.
[7] Ibidem, p. 16.
FONTE: https://www.pandorarivista.it/articoli/gli-stati-uniti-e-la-ribellione-delle-elite/
Chi finanzia l’Oms? Cos’è e come funziona l’agenzia dell’Onu

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=Ze5P710YgpM
QUI L’AFFARE S’INGROSSA, ARRIVA FRANCO FRATTINI
Tonio de Pascali – 9 01 2022
Qui l’affare s’ingrossa, direbbe qualcuno.
S’era detto di Draghi molto papabile per il Quirinale e la sua candidatura appare ancora la più probabile al successo.
S’era detto. Giustamente.
Ma tutto cambia, anche se è sempre legittimo fare previsioni in base alle notizie in campo.
Anche perchè a mettersi contro Draghi c’era Prodi, Casini, Mattarella bis e il Cavaliere.
Poi è arrivato Giuliano Amato e qui non si capisce se D’Alema punta davvero sul Dottor Sottile o è solo una manovra per avere spazio nel Pd in cambio del ritiro del suo cavallo.
Sempre ricordando che Berlusconi insiste nella sua candidatura e a quest’iniziativa, probabilmente non ci crede neanche lo stesso visto il suo pedigree di gran puttaniere di belle signorine.
Per carità, eccetto rare eccezioni non è che i Presidenti della Repubblica italiani abbiano spiccato per alte doti morali e soporattutto politiche (per queste ultime si veda Napolitano e Mattarella) ma mister B. è davvero troppo.
Forse anche lui lo fa per alzare il prezzo del suo ritiro in cambio di qualche vantaggio alla sua vecchia Mediaset, visto che i figli non assomigliano al padre per intelligenza.
Comunque vada, dai clan di destra ecco spiccare la candidatura di Franco Frattini.
E qui viene il bello.
Franco Frattini è il personaggio veramente più pericoloso a ricoprire il ruolo della più alta autorità dello Stato.
Pericoloso? Sì e per tanti motivi.
Franco Frattini è praticamente il ritratto in sedicesimi di Emmanuel Macron. Giovane, si fa per dire – dimostra molto di meno i suoi 65 anni -, bella presenza, sempre elegantissimo ed a tutto punto, sempre dritto come un manico di scopa nel suo linguaggio di uomo delle istituzioni.
Frattini ha sempre navigato nei corridoi del Potere, tra mille ruoli in tantissimi luoghi, italiani ed internazionali, quasi sconosciuto ai più ma molto apprezzato nelle sale dei ben noti , a pochi, “Luoghi di Forza”. Come Macron viene dalla Loggia e, dai signori di questa, è stato cresciuto e coccolato con mille attenzioni.
Sempre in politica senza mai comparire. Esperto come pochi ai luoghi ed ai ruoli della politica e delle istituzioni. E, non fa mai male, come Macron, ha fatto le scuole giuste e una buona gavetta e condivide notoriamente le stesse “altre passioni” senza che, al contrario della moglie-tata del presidente francese, lui invece si accompagni con qualcuna.
Sempre che, come avvenuto per Giuseppe Conte. all’ultimo momento, per ragioni di Stato, non gli venga affibbiata una dama d’alto bordo, bella e di classe.
Succede. In certi luoghi.
Franco Frattini è la quintessenza del volto patinato di quel Potere che come una piovra tutto gestisce all’ombra del grembiule. Non s’è mai sporcato con la politica vera, dunque non si può equiparare ai Franco e Ciccio del Parlamento e possiede notevoli doti a navigare nei corridoi del Palazzo.
L’ideale dell’uomo di potere di oggi, indispensabile alle cariche più alte perchè non ha mai venduto bibite al San Paolo.
Certamente non sarà il “Presidente degli Italiani”. come Sandro Pertini. ma ancora più certamente lo sarà delle lobby finanziarie,
Proprio come Emmanuel Macron.
Ecco perchè al contrario dei Prodi e dei Casini, è il concorrente ideale e più pericolo per la Presidenza italiana del futuro.
Così, ancora una volta ci tocca tifare Draghi, che certamente, ripeto, ha intelligenza da vendere.
Comunque vada, che Dio ci aiuti.
FONTE: https://www.facebook.com/100015824534248/posts/1133208257216648/
SCIENZE TECNOLOGIE
STORIA
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°